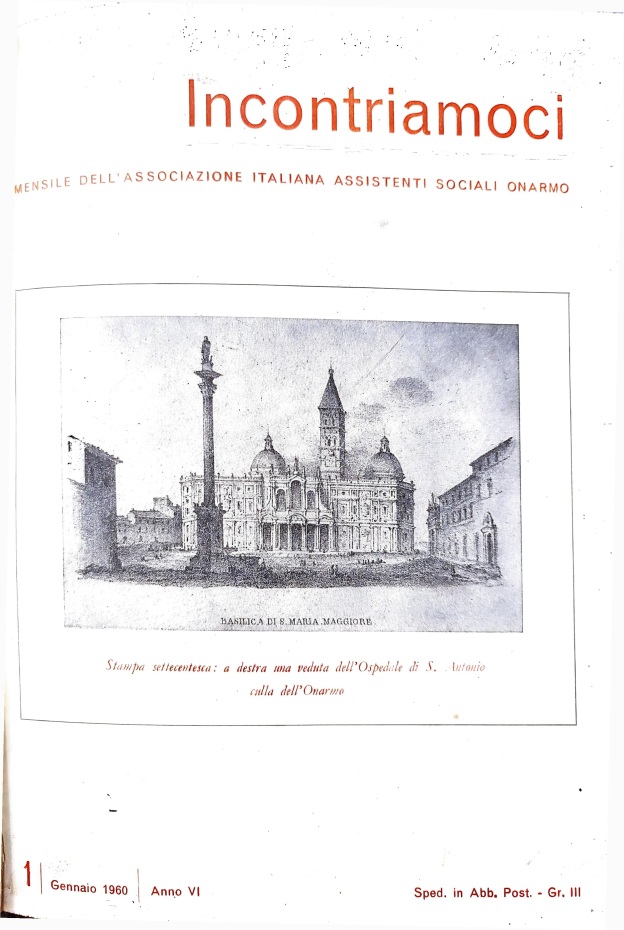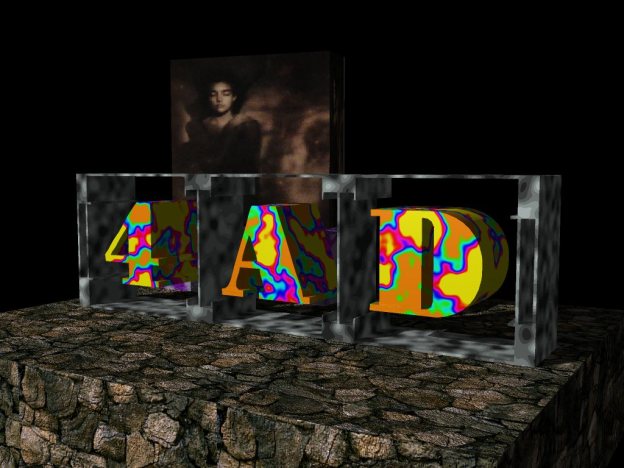Incontriamoci: mensile dell’Associazione Italiana Assistenti Sociali Onarmo, Roma, p.zza Cairoli 117, direttore responsabile Virginia Delmati. Inizia le pubblicazioni nel 1955, cessa nel 1961. Nel 1962 subentra “Rassegna di servizio sociale”.
Servizio Sociale Cattolico
Coordinamento del Servizio Sociale nell’industria
La missione dell’Assistente Sociale e della Collaboratrice Sociale
Il nostro servizio sociale pratico
Spiritualità dell’assistente sociale
Ricordi di un servizio sociale di fabbrica
Carriere per Assistenti Sociali
Storia del servizio sociale aziendale in Italia e all’estero
Esperienze. Incontro Collaboratori, Assistenti Sociali, Segretari Provinciali Rev.mi Delegati Onarmo di Toscana
Esperienze. Relazioni umane e servizio sociale aziendale in Campania
Storia del Servizio Sociale Aziendale in Italia e all’estero (II parte)
Storia del Servizio Sociale Aziendale in Italia e all’estero (III parte)
Alcuni punti orientativi per il Servizio Sociale di fabbrica
Esperienze. Il Servizio Sociale in atto nelle Marche
Servizio Sociale Onarmo agli Emigrati in Germania
Servizio sociale di fabbrica
Attività dell’Assistente Sociale O.N.A.R.M.O. nel bacino minerario di Liegi
Ferdinando Baldelli e il suo lavoro sociale
Bianco e nero (ricordi di un’A.S. di fabbrica)
Ferdinando Baldelli: l’uomo
Il miracolo (7 giugno 1945)
Assistenza Religiosa di fabbrica
Servizio Sociale di Fabbrica
Scuola di Roma. Tesi « Assistenza Sociale di Fabbrica nell’Ente Onarmo»
Il Servizio Sociale nell’impostazione della POA e dell’ONARMO
Seminano sul Servizio Sociale di impresa
Problematica sindacale attuale determinata dallo sviluppo tecnologico industriale
Possibilità di contenzioso infortunistico dell’opera di Patronato
L’apostolato del Cappellano del Lavoro e l’Assistente Sociale
Esperienze della più giovane assistente sociale di fabbrica
Esperienza di servizio sociale in una grande impresa milanese
Servizio Sociale Cattolico, 1-2, 1957, pp. 5-7.
di Virginia Delmati
Invitata a scrivere di Servizio Sociale Cattolico, ossia della possibilità di definire un Servizio Sociale capace di assumere caratteristiche essenziali riflesse dalla fede della Chiesa, interpreto il mio tema come enucleazione di alcuni punti sui quali si potrà stabilire una discussione e quindi sollecitare il contributo dei lettori nel delineare alcune idee guida sul Servizio Sociale, inteso come cattolico.
Certamente non possiamo pensare che esistono differenze di essenza, quanto a prestazioni assistenziali, tra il Servizio Sociale che vorremmo definire cattolico ed il « servizio » sic et simpliciter, o laico.
E vogliamo anche subito accantonare il pensiero che sorge spontaneo in noi, a questo proposito, e che cioè nelle medesime prestazioni, esistano, a favore del Servizio Sociale cattolico, almeno differenze nel modo di attuazione. E ciò perchè, di fronte a quello che verremo dicendo, il modo, la maniera, hanno una importanza assai relativa, più che essenziale. E cioè sono solamente una conseguenza di intrinseca diversità.
Proprio perchè vogliamo portare la nostra attenzione all’interno più che alFesterno delle attitudini ed azioni assistenziali, per ora mettiamo da parte questo rilievo.
Consideriamo invece l’interiore o precedente dinamico del Servizio Sociale, quello che sta dietro all’« arte migliore di aiutare gli altri ».
Procuriamo di puntualizzare:
1) la fede importa una propria concezione dell’uomo; tale concezione finalizza il Servizio Sociale.
2) e si riflette perciò nella realtà pratica assistenziale.
Finalizzazione del Servizio Sociale
3) — Non so quanti consapevolmente si propongono un fine generale attuando il Servizio Sociale. Di fatto molti identificano il fine con dati inerenti al servizio stesso. Ad esempio: l’istanza sociale, oppure la sofferenza individuale: problemi che richiedono una soluzione. C’è una società disuguale, torbida talvolta, inquieta, che’ esige una composizione.
C’è poi la sofferenza personale, una realtà umana disturbante. Benché si attribuiscano ad essa differenti cause, nessuno la nega; e tutti sentono la necessità di placarla, per reciproco bisogno. La scienza suggerisce come si fa. Tanto i problemi sociali, come quelli personali della vita, sono certamente studiati oggi da scienze specifiche, assai sviluppate. Tra le quali, esemplifico alcune più pertinenti: la sociologia, e la psicologia, per non accennare all’antropologia, alla psicopedagogia, alla psichiatria ed a molte altre. Anche perché le scienze tendono sempre di più alla specializzazione, ossia al ramificarsi.
Ma, in base alle informazioni nelle quali, per obbligo di studio della mia materia devo aggiornarmi, In campi propedeutici o laterali ad essa, modestamente posso affermare, con il Prof. Labrière, professore di filosofia sociale a Lovanio, che né la sociologia né la psicologia, dominanti, parlano dell’interno dell’uomo, né del senso della fenomenologia sociale; e nemmeno, per la verità, esse presumono di farlo.
La psicologia, quella psicologia alla quale mi riferisco, si limita soltanto a descrivere ciò che chiama «la strutturazione della personalità umana», studiata attraverso il dinamismo dei comportamenti controllabili.
Dal canto suo, la sociologia afferma di studiare, le condizioni, fenomeniche del convivere umano, senza addentrarsi, a scrutarne il significato. Queste scienze si reputano perciò e vogliono essere scienze esatte, cd in ciò stesso rifuggono da un contenuto filosofico e tanto meno metafisico. Ma, questo è il compito della filosofia. La filosofia però, per conto suo, si propone di studiare la natura delle cose; ed in ciò stesso pone il concetto di valore.
Infatti, il comportamento umano non è, semplicemente determinato, ossia riducibile ai fatti studiati dalla psicologia. La irriducibile varietà delle reazioni, individuali,, è, ad esempio, profondamente eteroclita in sé. Anche i fatti sociali non sono riducibili, ad un unico meccanismo. Tralucono, attraverso ai fatti catalogati dalla sociologia, i problemi della libertà per la meditazione, filosofica.
Ma anche la filosofia, affrontati i suoi problemi, mentre critica la ragione, non può pronunciarsi su quanto la supera.
Negheremo dunque, i risultati della scienza e della filosofia?
Mi sembra clic ciò sia vietato dalla nostra stessa filosofia tomistica; perché, cosi facendo, si negherebbe la validità della ragione, figlia di Dio. Dobbiamo soltanto riconoscere i limiti relativi al campo che è loro proprio, sia per la scienza che per la filosofia. Se la ragione pone dei perché, essa però non c sufficiente a dare le supreme risposte circa l’essere, l’origine e la finalità dell’uomo e del mondo, oggetto della teologia.
Ilo fatto tanto cammino per giungere a definire la specifica differenziazione del Servizio Sociale Cattolico da quello laico; anche se il primo deve riconoscere la validità dei metodi adottali anche dal secondo, nei loro limiti.
La differenziazione deriva dalla fede in Dio, di modo che anche le attuazioni esteriori si distinguono specificamente da quelle di ogni altro servizio sociale. Perchè?
1) Prima di tutto per la loro finalizzazione. Il servizio sociale, per il cattolico, non è fine a sè; non ha come fine mediato neppure l’uomo e la società; fine mediato ossia non per sè stessi, ma come sensibili apparenze d’uria infinita realtà d’amore, cui sono intimamente relativi, appartenenti e cari.
2) Le salute dell’uomo e della società è concepita dunque dal Servizio Sociale Cattolico sulle basi di tale destino. Solo raggiungendolo l’uomo può attuare interamente sè stesso e conseguire il pleroma della sua natura. Esso è destino di felicità.
3) Bisogna aiutarci ed aiutare a ritrovarlo; e noi, per convinzione religiosa, fermamente crediamo di poterne divenire capaci. Questa è l’anima dell’aiuto che noi diamo. Tanto più efficace, quanto più sarà improntato alla nostra incrollabile fede. In dipendenza di questa fede, crediamo realmente alla riabilitazione umana.
Alcuni casi di riabilitazione, ottenuti dai metodi attuali, ci mostrano in sede didattica, mutamenti di altitudini nei clienti che parrebbero aver valore riabilitativo. Minori delinquenti ad esempio, con l’aiuto psicologico dell’assistente sociale, la quale non si spaventa, ma accetta tali clienti così come sono, riescono ad obbiettivarsi; ossia a separarsi dai loro comportamenti sociali dannosi a sé ed agli altri. A questo punto, in generale, dopo una descrizione minuta degli accorgimenti psicologici e razionali dell’assistente sociale, il raso è dimostralo come concluso positivamente. Ma vien fatto di domandare se questa obbiettivazione si limiti soltanto al sollievo dalla tensione dello adolescente, ovvero sia efficace per un reale suo mutamento durevole nel tempo.
In casi sperimentati in modo diretto, mentre è onesto riconoscere che, applicando i metodi di una razionale ed intelligente psicologia si hanno davvero miglioramenti e risultati positivi, è anche onesto dichiarare che, asseconda della gravità dei mali cui si rimedia, tale riabilitazione minaccia di rimanere soltanto superficiale, se non risolve, in profondità, il problema del male in sé, ossia nella profonda attitudine interiore umana. Si tratta il più delle volle nei casi presentati in sede didattica, di comportamenti dipendenti da incomprensioni occasionali, nei quali si riesce, applicando i metodi, a raggiungere soltanto un migliore adattamento sociale.
Solo la Grazia può riabilitare l’uomo in realtà, anche se, naturalmente essa si giova dei mezzi a nostra disposizione, ivi compresa la nostra ricerca scientifica.
Infine, quanto all’inserimento della pratica, la caratterizzazione specifica di un Servizio Sociale Cattolico deriva dal Vangelo, ove tesori inesauribili di suggerimenti altamente psicologici si connettono, come maglie invisibili di un velo d’oro, capace di trasformare la realtà quotidiana della vita in una realtà spirituale; ed a risolvere gli infiniti problemi che sorgono ad ogni passo della nostra via.
« Vince in bono malum », che ricchezza di accorgimenti psicologici, ragionevoli, di accettazione paziente e lungimirante contiene questo consiglio! Il Vangelo offre il fermento attivo di perfettibilità, e di evoluzione personale e sociale. Ed ognuno di noi può divenire, aderendo ad esso sinceramente, un elemento catalizzatore della dinamica umana di miglioramento, e di avvento del Regno di Dio dentro e fuori di noi, e determinare in realtà, uno sforzo umano, personale e collettivo di bene!
« Ambulale, dum lucem habetis ».
E la luce capace di illuminare dall’interno il nostro Servizio Sociale è Cristo stesso!
Conta infinitamente perciò e soprattutto lo stare con Lui!
il cielo azzurro, nudo, le impronte del trattore e la solitudine infinita.
In questa mattina, mentre gli uccelli cantano, alzo gli occhi a Te, Dio dell’eternità, col desiderio di essere più silenzioso, più povero, più puro.
Signore, liberami dalle preoccupazioni vane della terra e del tempo, perché possa esser chiamato alla mondezza, del cielo ove stanno i tuoi santi di oro e di argento, davanti al Tuo trono.
T. M. foglio di un Diario
“Chi ama più se stesso che Dio, ama cose e persone per il bene che ne può trarre. Il suo amore egoista tende a distruggerle, a consumarle, ad assorbirle nel suo stesso essere, giacché tale amore è solo un aspetto del suo egoismo e una specie di pregiudizio in proprio favore. Una tale persona non è affatto indifferente all’urto di cose, persone ed eventi nella sua vita, ma è realmente distaccata dal bene di queste stesse persone e cose, se esse non hanno nessuna interferenza col suo vantaggio personale. Non è quindi affatto distaccato né indifferente dal bene che gliene può derivare, lo è, invece, e completamente, nei riguardi del loro bene” (Thomas Merton)
Coordinamento del Servizio Sociale nell’industria. Note dalla VIII Conferenza Internazionale di Servizio Sociale di Monaco (agosto 1956), 12, 1957, pp. 11-12.
1. Coordinamento del Servizio Sociale nell’industria.
Il lavoro sociale è anche necessario nel piano dell’industria come in tutti i servizi sociali che sono al di fuori dell’industria. Il Servizio Sociale istituito nella industria, anima, nella sua struttura, gli aspetti che la caratterizzano oggi.
Questo tipo di lavoro sociale, non deve in effetto, limitarsi a combattere il male umano e sociale e le sue cause. L’età della seconda rivoluzione industriale esige un rapporto comune costruttivo da parte di tutti gli interessati, al fine di rendere l’uomo contemporaneo capace di superare i molteplici problemi che egli incontra nella vita laboriosa dell’individuo, del gruppo, della comunità.
Il lavoro sociale nell’industria aiuta la direzione della fabbrica ad adattare l’industria alle possibilità dell’uomo, ed insieme aiuta il lavoratore ad adattarsi alle necessità dell’industria.
Gli scopi specifici del lavoro sociale nell’industria sono:
— venire in aiuto all’individuo e ai gruppi, sviluppando in tutti i ceti il senso delle responsabilità sociali e dei rapporti umani;
— fornire assistenza ai gruppi minoritari, quali per esempio le madri, le giovani, gli invalidi, etc…
È dunque necessario porre una correlazione tra i problemi interni ed esterni dell’industria, poiché il lavoratore e la sua famiglia devono dar fronte anche ai problemi fuori della fabbrica.
Questa correlazione è un’arte ed il suo attuarsi si deve inspirare a diversi principi.
Abbiamo bisogno di una sistematica sufficientemente sviluppata per stabilire il coordinamento tra i diversi servizi sociali interessati, secondo le loro competenze, i loro mezzi e la loro buona volontà.
La collaborazione dei servizi sociali è necessaria con gli organismi religiosi, elemento molto importante.
Bisogna anche regolare i rapporti tra i diversi Assistenti Sociali interessati ai casi. Il coordinamento e la divisione dei compiti del Servizio Sociale debbono essere attuati secondo gli scopi specifici di proteggere i clienti tenendo conto della loro libera scelta.
2. Ripercussioni delle opere sociali sulla fabbrica.
Le iniziative diverse prese nelle aziende in favore dei lavoratori e delle loro famiglie sono state dapprima manifestazioni dì paternalismo, diversamente giustificato, ma che aveva generalmente ragione di essere nella stabilizzazione del personale occupato, e in ultima analisi, nel miglioramento della produttività.
Ma altre circostanze hanno favorito lo sviluppo di queste iniziative.
Lo spirito di solidarietà imposto da gravi avvenimenti come la guerra, per esempio, hanno portato talvolta i dirigenti ad occuparsi più particolarmente del loro personale. Parimenti lo sviluppo della legislazione sociale, quasi sempre sotto la spinta delle organizzazioni dei lavoratori, ha imposto modifiche di struttura interna alle aziende, modifiche che ebbero la loro ripercussione sulle opere sociali.
L’industrializzazione delle regioni nuove, talvolta il trasferimento d’aziende, e sempre più la razionalizzazione delle imprese, esigono e continuano a necessitare della creazione di opere e di servizi sociali diversi.
L’evoluzione di domani è in funzione della necessità di fronteggiare i diversi problemi che sorgono dalle esigenze del lavoro. Essa deve accompagnarsi a modifiche sia nelle strutture come nelle relazioni di ambienti di lavoro.
Un censimento rapido delle iniziative prese attualmente in questi ambienti a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, permette di raggrupparle in tre gruppi:
a) iniziative che hanno direttamente per scopo l’adattamento dei lavoratori all’impresa e che favoriscono specialmente il miglioramento individuale;
b) quelle che concernono la creazione di opere e di servizi d’assistenza, di aiuto scambievole e di previdenza, in favore del personale della azienda;
c) quelle che favoriscono il risparmio, permettono la ricreazione e lo studio e incoraggiano le differenti forme di attività, favorevoli allo sviluppo della cultura del personale dell’impresa.
Si pensa che l’evoluzione anche nella vita economica imporrà sempre maggiormente da una parte, l’assimilazione di tutto ciò che favorisce direttamente l’adattamento del lavoratore all’impresa, e dall’altra, lo sviluppo sul piano civico delle istituzioni alte a formare una vita collettiva evoluta.
Simile evoluzione reclama nelle imprese una considerazione più reale dell’uomo, in quanto lavoratore, e delle relazioni umane tali che ciascuno che partecipa ai procedimenti del lavoro senta il proprio valore e quello delle responsabilità solidali dell’uomo.
La famiglia e l’impresa hanno un interesse comune per la evoluzione felice di questi rapporti, e dal migliore rendimento che finalmente l’economia potrà trarne. Si desidera in conseguenza che tutto ciò che può favorire l’uomo nel lavoratore, sia iniziato e sviluppato così che egli possa essere più istruito,
più qualificato per il lavoro-meglio temperato ai doveri della solidarietà e a quelli del cittadino. Questa formazione multiforme deve trovare come punto d’appoggio principale, e, come mezzo e scopo parziale, la famiglia.
È necessario che i mezzi messi in opera per elevare e promuovere l’individuo e la famiglia restino normalmente sulla scala umana e che una attenzione sempre più grande sia apportata alla soluzione dei numerosi problemi dell’educazione popolare che l’evoluzione economica e sociale fanno sorgere.
A questo fine, ha importanza il ruolo che debbono occupare i lavoratori sociali chiamati via via a fare azione d’insieme ben compatta.
La missione dell’Assistente Sociale e della Collaboratrice Sociale (1ª parte), 1-2, 1957, p. 18.
di don Giovanni Nervo
Per poter approfondire questo tema è necessario chiarire alcuni equivoci.
Il primo è questo: « L’Assistenza Sociale, modernamente concepita, e una missione o è una professione? »
Molti affermano: l’Assistenza Sociale non è una professione, è una missione.
Costoro sono preoccupati dell’afflato spirituale che l’Assistente Sociale vogliono porti al lavoro, e temono non senza fondamento che tutto si riduca ad applicazione meccanica di una tecnica fredda.
Altri, preoccupati della preparazione tecnica delle Assistenti Sociali, desiderosi di darle una precisa qualificazione e dignità professionali, diffidenti di fronte ad una certa faciloneria ed a frequenti improvvisazioni, sia pure fatte con ottime intenzioni, affermano: l’Assistenza Sociale non è una missione, è una professione.
A me sembra che alla base ci sia un equivoco, chiarito il quale la questione non ha più ragione di esistere.
L’equivoco sta in questo: i due termini missione e professione non sono necessariamente antitetici, anzi a me sembrano complementari.
Cioè al termine « missione » non si oppone « professione », ma mestiere nel senso deteriore di mestierantismo.
Al termine « professione » non si oppone « missione », ma « dilettantismo » cui spesso è unito il concetto di superficialità, faciloneria, improntitudine.
I due termini mi sembrano complementari in questo senso: la professione, preparata ed esercitata molto seriamente, impegna tutta la personalità, comprese le facoltà spirituali, e quando nella professione, oltre che competenza, si porta entusiasmo, amore, passione, dedizione, la professione non perde di valore, ma ne guadagna.
Direi che se la professione non è esercitata con questi elementi spirituali, si degrada e diventa mestiere, professionalismo. Cosi se uno ha veramente spirito di missione, cerca d’impossessarsi nel mondo più perfetto di tutti gli strumenti della tecnica, li usa con la più scrupolosa attenzione, combatte la improvvisazione, la superficialità e la faciloneria: proprio perché ama il suo lavoro e le persone cui esso è rivolto. Direi che se usassimo la parola missione, ma non avessimo questa ansia di perfezionamento tecnico e professionale, faremmo abuso di una grande parola Chiarisco maggiormente con un paragone: il medico esercita una professione che e certamente anche una missione. Ora lo spirito di missione non toglie nulla alla dignità della professione, anzi è stimolo al suo perfezionamento/ come il concetto di professione non esclude quello di missione, anzi in un medico, se manca, degrada la sua nobile professione ad un mestiere Dunque quando parliamo di missione dell’Assistente Sociale, sottolineiamo il contenuto spirituale di una professione che si accosta così da vicino alla persona umana e richiede tanta partecipazione dello spirito in chi la esercita, ma non escludiamo il concetto di professione con la preparazione e gli strumenti tecnici che le sono propri.
Non escludiamo e supponiamo il concetto di professione:
1) Perché l’Assistenza Sociale è veramente una professione. Il Santo Padre Pio XII in una lettera inviata alla Presidente dell’Uciss in occasione del 25° anniversario dell’Unione e del Congresso di Roma nel 1950 dice:
« Niente può contestare, in effetti, il doppio carattere di competenza professionale e di fedeltà cristiana che deve qualificare una azione come la vostra.
Nel mondo moderno, dagli ingranaggi pesanti e complessi, il Servizio Sociale non conquista di fatto un posto sempre più considerevole?
Le sue ambizioni, oggi, sono vaste e le sue tecniche rigorose; dopo lungo tempo, ha superato lo stadio delle iniziative spontanee e tende a fondarsi sui dati pii1 recenti della scienza ».
2) Perchè la delineazione in una figura professionale assicura dignità all’Assistente Sociale e rende più facile il suo inserimento permanente nell’organismo della vita sociale.
3) Perchè la precisazione dei compiti, del campo di azione, impegna maggiormente il senso di responsabilità dell’Assistente Sociale: se è tutto ed è niente, di che cosa risponde? (continua)
Il nostro servizio sociale pratico, 3-4, 1957, pp. 3-6.
di Virginia Delmati
Il Servizio Sociale non è accademia. Se è necessario premettere al Servizio Sociale una rigorosa preparazione teoretica, e quindi di studio, che approfondisca intellettualmente i principi ideali e tecnici del nostro lavoro; se è necessario alimentare sempre l’attività pratica di riflessione, e cioè di pensiero, tuttavia il Servizio Sociale, in quanto tale, è eminentemente prestazione concreta.
La scienza nucleare, ad esempio, procede innanzi, nelle alte sfere della scienza, per lo studio degli scienziati puri; ma la società non si gioverebbe dell’enorme valore delle loro scoperte se non esistessero i tecnici che le applicano, ed in tal modo le stimolano.
Con la necessaria, debita proporzione, tra due campi così diversi, l’esempio giova per affermare che la teorica pura degli intellettuali odierni del Servizio Sociale diviene utile effettivamente alla società solo se esistono i pratici che l’applichino, e l’adottino, non solo, ma l’adattino alla realtà.
Non lasciatevi quindi mai compenetrare da un complesso di inferiorità constatando che voi lavorate più di quello che non studiate; perchè soltanto il lavoro, e quindi anche il vostro lavoro, dà un senso allo studio del Servizio Sociale. Nè intimiditevi venendo a contatto con certi pseudo-teorici, quelli feticisti della lettera, come possono essere ad esempio, studenti o assistenti neo-diplomati, nei quali non sia ancora avvenuta l’assimilazione dello studio ingerito e la sua trasformazione in cibo digesto.
I quali snocciolano volentieri un numero, ahimè ristretto e monotono, di espressioni, quasi sempre tradotte di peso, e nella medesima reciproca connessione.
La nostra è un’azione valida, autentica e molteplice, confluente, sia dalla Scuola come dall’esperienza, contrassegnata dalla impronta insostituibile della sperimentalità, che la vaglia, ed, in un certo senso, controlla anche la Scuola.
C’è nella crescita, ossia nel perfezionarsi dei nostri metodi, l’ampio respiro della prova, diretta a sollevare, nella realtà, e su larga scala, concreti bisogni. E ciò costituisce un privilegio di fronte a Scuole che si trovano nella necessità di crearsi una casistica artificiale, del momento, e quindi affrettata ed incerta, remota in certo senso dalla verità.
Finché le condizioni del nostro paese si trovano in fase di transizione in quanto a sminuire le percentuali del bisogno dimostrate dall’inchiesta Parlamentare della Miseria e Disoccupazione del ’54 finché si stanno confrontando ed evolvendo le forze economiche e politiche della patria, noi, pur sapendo di non poter essere noi a risolvere i gravi problemi che tali trasformazioni invocano ed includono, stiamo già in azione rinnovatrice nel nostro campo, che è quello limitato e specifico del Servizio Sociale. Non stiamo oziosi, ma lavoriamo almeno a sollevare la necessità di chi soffre, se non possiamo eliminarla, fiancheggiamo la trasformazione in atto dal vecchio al nuovo mondo sociale, la facilitiamo, cui andò anche tutti i problemi di adattamento che essa include.
Infatti i grandi mutamenti delle condizioni sociali del popolo, non avvengono, quanto agli uomini, se non attraverso processi lenti a maturare, ostacolati spesso da incomprensioni, diffidenze, atavismo da parte di coloro che ne sono oggetto; e dai difetti di quelli stessi che promuovono tali mutamenti.
Dunque non supponete che, per fare del buon Servizio Sociale, si debba soltanto fare del « case-work » o del « group-work ».
Sì, nel Servizio Sociale che voi fate, questi metodi sono parte essenziale e voi dovete prendervi la cura di usarli e di applicare i principi che li ispirano, e le tecniche in cui si attuano. Questi metodi e quelli dell’inchiesta sociale o ricerca scientifica, la quale deve impiegare sempre più perfetti strumenti di indagine.
Dovete anche usare il metodo dell’« organizzazione di comunità », che per voi presenta una tal quale possibilità; perché esso significa anche attrezzare una comunità con le risorse assistenziali esistenti.
Tutti questi metodo il nostro Ente applica nella sua estesa attività e desidera perfezionare, attraverso la vostra opera, nelle zone in cui lavorate, ove i bisogni sono più incidenti e gravi e dove il rinnovamento sciale stenta a penetrare, ma ciò nonostante è invocato non solo dalla necessità, ma anche da un fermento che stagna talvolta, più che agitarsi ma che è presente in tutti ed in tutto.
Avviene agli abitanti di queste zone, forse a causa delle vie più facili della informazione e delle comunicazioni, della radio, delle macchine, della propaganda, quello che avverrebbe ad una casa di periferia che, per il crescere della città, si trovasse nuda e vecchia, compresa ormai nel centro di essa, e che non piacesse più ai suoi padroni i quali la trovavano già comoda e familiare.
Un travaglio percorre oramai in tutti i sensi ogni lembo di terra ed attira a sé coloro i quali eventualmente ne rimangono fuori.
Ma, in esso, l’evoluzione sociale degli uomini deve andare di pari passo con il rinnovamento delle strutture; nei tempi di evoluzione, o crescita, che avviene fervida, ma ineguale e soggetta a crisi, come per ogni sviluppo, si inserisce il Servizio Sociale, ossia lo sforzo di liberazione, o di sollievo dai disagi più gravi, e di alleggerimento dei problemi più urgenti del malessere personale o collettivo.
Questo indirizzo hanno i nostri Centri Sociali; e questo è il carattere del Servizio Sociale che essi attuano. Sono posti di avanguardia e di vedetta, destinati a svolgere, attraverso una efficace collaborazione dei clienti, un’azione preparatoria e laterale all’azione rinnovatrice di riforma.
Le iniziative dei vostri Centri, siano esse assistenziali, culturali, ricreative, sono sempre squisitamente sociali, e dirette a sviluppare forze spontanee e sincere di attrazione, ed a esercitarne anche efficaci di irradiazione sulla comunità.
Il Servizio Sociale prestato nei Centri svolge innanzi tutto la lotta contro la miseria e la povertà, s’intende al proprio livello, ossia secondo la sua natura di rimedio immediato, su molti piani, ma con l’attivazione spirituale di coloro che ne soffrono. E se pure non presumiamo di vincere tali mali, di portata enorme, nelle loro cause, e quindi nelle loro radici, cerchiamo però di sollevarli nelle loro conseguenze più disturbanti. Giova infatti ricordare che l’assistenza economica non può spesso subire remore; quando, soprattutto, il malessere di troppe persone si addiziona, ma deve essere affrontata. Occorre però che chi la presta, come chi la riceve, abbia la consapevolezza della sua temporanietà e la certezza che essa è costruttiva se è resa ed accolta attivamente, come segno di comprensione umana, di sollecitudine solidale e di rispetto della persona cui è rivolta, e di stima delle sue possibilità — ossia se l’assistenza materiale si spiritualizza.
S’intende che siamo obbligati a rispettare, in questa forma di assistenza, una accurata organizzazione preventiva. Per esempio nelle distribuzioni assistenziali, prevedendone lo svolgimento in tutti i particolari, studiandone le possibilità di collaborazione di coloro cui sarà diretta, tenendo presenti le esigenze di tatto, di convenienza, di giustizia e di discrezione. Eseguite la scelta dei destinatari anche con il loro consiglio, con giustizia scevra di pregiudizi, ricordandovi il significato di aiuto dato indipendentemente dal merito. Curate direttamente le distribuzioni, e con l’aiuto, in incarichi diversi, di coloro che ne sono i destinatari.
Sta in voi quindi l’impedire che un servizio delicato, per il quale occorre particolare esperienza, divenga sterile e magari motivo, da parte di estranei, di accusa.
Tra i metodi da applicare il principale è il metodo del contatto personale, come mezzo di colloquio, ossia di rapporto. Per riuscire a stabilirlo impegnate a fondo la vostra attenzione, intelligente e penetrante, nel mobilitare le risorse interne del cliente e nel metterle in correlazione con quelle esterne, della società.
Ricordatevi sempre che il soggetto dell’assistenza non siete voi, nonostante la vostra possibile, anche sviluppata competenza, ma è lui, il cliente, con la sua personalità umana, di un valore ontologico, incontestabile, nonostante il suo grado vano di evoluzione. Per questo importa lavorare più con il cliente che per il cliente; attendere al suo stato d’animo, più che al suo bisogno. Poiché le reazioni al suo stato di bisogno, e quindi, le capacità sue a liberarsene, stanno nel suo stato d animo, più che nel vostro aiuto. E rispettate la sua libertà, cercando di destarla, perché soltanto in quello che liberamente uno vuole, ed a cui arriva da solo, agisce efficacemente.
Ed ecco la visione psicologica del vostro lavoro: conoscere ed utilizzare le risorse del cliente.
Assodato questo, non crediate però che le prestazioni pratiche per il cliente, quali la produzione di certificati, le procedure complesse degli Istituti Assicurativi, le pratiche militari etc. non siano Servizio Sociale. Non le disprezzate; il Servizio Sociale sta essenzialmente nel farsi utili ai clienti, e quindi in una attitudine fondamentale, ed inesauribilmente ripetuta, esteriore ed interiore. di prestarsi secondo la necessità, a collaborare con loro.
Lo so che le pratiche burocratiche sono pesanti. Ma anche qui il soggetto non è la pratica, nè la vostra bravura o capacità di strappare, comunque, un risultato ; nè siete voi stessi, per farvi onore presso i vostri superiori. Ma, ancora una volta, il soggetto del vostro lavoro è il vostro cliente, forse indiscreto ed inopportuno, ma è lui che vi dà occasione, di adempiere, anche in queste fastidiose cure, un grande compito mettendo alla portata di chi le ignora, le provvidenze, le leggi sociali, che, forse, senza di voi, non lo raggiungerebbero. Siete, in questa funzione, un prolungamento dico sul serio — dei poteri dello Stato. Emana dunque, anche dalle pratiche burocratiche, una dignità sociale larga ed umana.
Questo riassunto a grandi linee è il Servizio Sociale come l’Onarmo concepisce, integralmente sociale e tecnico, nella misura non solo della sua esattezza concettuale ed esecutiva, ma anche dell’umanità con cui si adempirà.
Spiritualità dell’assistente sociale, 3-4, 1957, pp. 14-15.
di Don Franco Conese, Centro Climatico di S. Paolo Martina Franca.
Il mondo è come noi lo facciamo. Prima di salvare le anime, bisogna dare alla povera gente cosciente vita. La miseria è una malattia. Bisogna che i ricchi portino il peso della ricchezza e del casato, come i poveri portano il peso della miseria.
In questa chiarezza si inserisce e si inquadra la spiritualità di colui che entra in contatto con la povera gente, con l’ansia sincera di fare il più possibile perché sia alleviata la miseria, lenite le ferite, ed assicurata a tutti una vita spiritualmente più tranquilla.
Il termine “spirituale” delinea la figura dell’assistente sociale, ne definisce la persona, ne indica la vera vitalità. Spiritualità è un’espressione molto ricca: noi ne intendiamo il culmine, e cioè l’unione con Dio, nella carità.
Di fronte alla meditazione di Dio vediamo con chiarezza i motivi che ci fanno amare Dio sopra ogni cosa, con tutte le forze.
Questo amore ci porta conseguentemente ad amare il prossimo: «quia Deus amat, nos amamus» (S. Tommaso).
In questo amore c’è tutta la ricchezza dell’Assistente Sociale.
Gesù sceglie — è Lui il Signore — ci manda — non ci lascia in casa, ci manda fuori. Ci fa muovere, ci disturba.
In questa nostra missione ci sono parecchie scomodità:
— disagi fisici (S. Paolo, Seconda lettera ai Corinzi XI, 26);
— sentimentali: siamo disturbati negli affetti (bisogna lasciare le chitarre, le fisarmoniche).
Stiamo attenti a non cadere in quella falsa concezione del Cristianesimo, ventilata da taluni che non hanno compreso la nostra religione, i quali dicono che il cattolicesimo ha bisogno dei poveri, perchè è la religione della carità. Badate: è più facile volersi bene quando siamo sullo stesso livello sociale, che non quando per la dura realtà in condizioni diverse, della vita che s’impone):
— ci manda in città : un terreno più difficile (S. Paolo ad Atene) è stato detto con amore.
— ove c’è la moda : un andazzo di vita; e noi vogliamo chiarezza e serenità di intenti;
C’è una psicologia del ricco da studiare. Egli deve riconoscere la funzione sociale della ricchezza al lume degli insegnamenti divini.
di fronte ai problemi che, nella sua missione, incontra l’Assistente Sociale assumerà sempre attitudine di molta umiltà.
Attitudine di grande speranza: l’ottimismo e non sarà apocalittico, scoraggiato, malinconico, lacrimoso, pieno di pettegolezzi; bisogna innamorare tutti di Dio.
Attitudine di grande fede: possiamo avere il mondo intero; non mendichiamo l’elemosina….
Atteggiamento di grande fortezza : ci è necessaria la decisione senza ammorbidire le situazioni.
Questi propositi spirituali, impegnativi al massimo si attuano sul piano soprannaturale:
— con il contatto con Dio;
— con la preghiera.
Preghiamo: è un ordine di Gesù «dunque pregate»; con preghiera vocale e mentale, unitiva, alla presenza di Dio, nel colloquio con Lui.
Come ha pregato Gesù : «Preservali dal male, santificali nella verità, che siano una cosa sola, che abbiano in la pienezza del mio gaudio » (Gv 16).
La Preghiera è l’avvio alla vita interiore, moto a Dio, distacco dalle creature, pienezza di Grazia, vita sacramentaria.
Attraverso essa, Dio si comunica all’uomo, e mette l’uomo in condizioni di comunicare con Lui. La preghiera c il riordinamento del mondo: tutto e al servizio dell’uomo perchè cresca in proporzione del suo destino, cioè in ordine alla sua
Il Sottosegretario agli Esteri, on. Del Bo, ha visitato, venerdì 1° marzo, nella Sede del Seminarium Pio XII in Roma, il nostro Corso di specializzazione per Assistenti Sociali, destinate a svolgere la propria attività nella Germania Occidentale a favore degli operai italiani colà emigrati per i lavori stagionali dell’agricoltura o per lavori di carattere permanente nel settore industriale.
Presentato da Monsignor Presidente, il Sottosegretario Del Bo ha rivolto alle assistenti parole di augurio e di incoraggiamento per la missione sociale che si dispongono ad iniziare, mettendo in risalto l’importanza e la responsabilità della loro missione, che si rivolge ad una categoria di operai tra i meno privilegiati.
« I nostri fratelli emigrati — ha detto l’on. Del Bo — hanno partecipazione alla vita, intima di Dio.
L’augurio di conclusione sia il trittico:
Non vi manchi la luce. Il cuore non si stanchi. Il filo non si spezzi.
Ricordi di un servizio sociale di fabbrica, 5-6, 1957, pp. 6-7.
Voglio intrattenervi, questa volta, sulla vita di fabbrica veramente vissuta, riassumendone un ricordo tra le congerie, non indifferente, di materiale superstite dai miei trentacinque anni di professione. Superstite alle selezioni, distribuzioni, perdite, invariabilmente apportate, in tanto tempo, nella massa dei documenti, attestazioni, lettere, articoli, fotografie, bagaglio della mia vita di lavoro che mi è apparso più o meno interessante asseconda la prospettiva del momento. Asseconda cioè dell’umore che, in un momento di depressione, può avermene fatto distruggere buona parte, come ormai inutile, o superstite dalle dispersioni magari di un trasloco, o comunque di smarrimenti. Così avvenne del materiale di inchiesta sul lavoro femminile, che avevo diligentemente condotto in più di dieci industrie di Roma, di cui almeno 4 o 5 molto grandi, e che delle Diocesi, gli uscieri mi persero al momento di un trasferimento di ufficio.
Da allora le librerie di casa mia si arricchirono ohimè di molte carte, fotografie, appunti, riassunti, note di colloqui un po’ da per tutto e con tutti, che costituirebbero una bella miscellanea il giorno che avessi tempo di metterle insieme e di pubblicarle.
Ma il Servizio Sociale, come prima prova della mia lunga carriera, ha, in tale bagaglio, un posto d’onore, ed oggi per dare un po’ di luce poetica a questa nostra rivista tecnica, ne estraggo un documento, un libro di cui, come assistente sociale, curai tanti anni fa l’edizione. Si tratta di una raccolta di poesie, in romanesco, di un operaio, Enrico Tombolini, dal titolo « Senza sugo ».
La vena è autentica, il suono musicale, la rima facile.
L’autore mi portò un giorno una poesia scritta a grossi caratteri incerti, su di un pezzetto di carta strapazzato, estratto dalla tasca dei pantaloni di lavoro, costellato da poderose ditate nere, sigillo autentico del poeta gassista, e del suo scrittoio, una parete di cemento. Non era una di quelle solite poesie che vi mettono in imbarazzo di fronte a chi ve le porge confidente; nell’imbarazzo di non offenderlo senza mentire! Era diversa, significava qualche cosa; e detta in modo che poteva modularsi, ritmata e senza sforzo.
Gli domandai ammirata quali poeti conoscesse: mi rispose con schiettezza: « nessuno ». Mi convinsi poi che non possedeva alcuna cultura. L’arte nasceva in lui, che non la cercava; era lei ad invadere, con il suo breve battito d’ala, l’atmosfera pesante del grave lavoro del suo amico.
Al primo foglietto ne seguirono tanti altri tutti scintillanti ai miei occhi, nell’aria così pesante e avvolgente della fabbrica che inondava generosamente anche il mio sgabuzzino, collocato al centro di essa. Il libro ha una mole di circa 200 pagine, ben stampato su ottima carta e con un elegante copertina vivace, adatto al titolo arguto.
Ancora oggi questi versi, che risuonarono la loro ingenua bellezza nell’animo del poeta tra una « sfornata » e l’altra della ferrigna « batteria », mi piacciono assai. C’è dentro lo amore ideale e delicato di un popolano di Roma, cantato come un sogno, sotto le finestrette restie ad aprirsi, fiorite di garofani d. ogni colore «cornice d’angioletti belli e santi» nella luce del maggio suggestivo, o in quella, misteriosa, delle stelle. C’è dentro anche a pietà per il dolore di chi soffre ogni giorno’ cercando nell’umile vita la sua umile via; c’è dentro il baleno saltellante e rapido dell umorismo, che brilla nel motto rapido e felice, ce dentro, bravo Tombolini, anche la religione!
«Sento ’na voce che mi dice: «Spera!».
Io spero e la speranza me rincora
Listesso ar sole de ‘sta Primavera
Sta Primavera che qui a Roma bella
È già un mesetto che sta fa la bulla
Pe’ li giardini e su ogni finestrella
Finestre de Trastevere, che ancora
godete er bacio de ‘sta Primavera
Finestre ciuche, co3 li vasi fora
Sento una vocettina de sirena
Che canta li stornelli: questa è Nina,
Nina che me fa sta3 sto core in pena! »
Ma si tratta di una fiera trasteverina
« Me basta solo un pizzico d’amore
pe levamme da tutte ste torture…
sole, sole, riscalleje quer core! »
Avviene che Nina risponde talvolta…
« Te vojo bene! Ste parole d3oro jersera me l3hai dette finarmente,
Tu me voi bene…
Tramezzo a le giunchije e ale viole,
Tra le rose sbocciate a centinara,
Dimmele sempre que le tre parole! »
Carriere per Assistenti Sociali, 12, 1957, p. 16.
Il Ministero degli Esteri d’accordo con il Ministero della Marina mercantile e con l’intervento dei rappresentanti dell9armamento libero predisporrà un ruolo degli assistenti sociali adibiti al servizio sociale di bordo. Velò richiesta per l’iscrizione è fra i 25 e i 45 anni, il titolo, la laurea o il diploma di scuola media superiore unitamente al diploma di assistenza sociale.
L’imbarco dell’assistente sociale è obbligatorio allorquando la nave trasporta 480 emigranti. L’assistente sociale imbarcato dipenderà disciplinariamente dal comandante di bordo, avrà un grado parificato, in via sperimentale a quello di allievo ufficiale, una paga mensile di L. 67.000 lorde, oltre i compensi e le indennità indicate in una apposita tabella.
La funzione dell’assistente sociale a bordo è quella di contribuire ad assicurare il benessere degli emigranti durante il periodo della navigazione e di creare le premesse per un loro migliore inserimento nella vita di lavoro e di relazione del luogo in cui sono destinati.
In particolare l’assistente sociale dovrà fra l’altro:
a) agevolare gli emigranti nelle operazioni di imbarco e sbarco, aiutandoli nell’espletamento delle relative pratiche;
b) accoglierli e metterli a loro agio sulla nave, spiegando loro le norme e le caratteristiche della
vita di bordo e del viaggio.
c) tenere conversazioni agli emigranti per fornire tutte le informazioni di maggior interesse relative al Paese di destinazione (notizie sulla posizione geografica, clima, risorse naturali, condizioni economiche, politiche, sociali; cenni sulla storia, religione, tradizioni, usanze, abitudini di vita, sul sistema monetario, misure di peso e grandezza, etc);
d) riunire le madri di famiglia per la illustrazione di quelle norme di carattere igienico sanitario, soprattutto relative all’allevamento della prole e alla buona tenuta della casa, di cui si rende necessaria la conoscenza in rapporto al clima, alle caratteristiche del luogo di immigrazione, alla vita in un paese straniero, al fine di favorire indirettamente l’iniziale adattamento di tutto il nucleo familiare;
e) provvedere all’insegnamento in modo facile e pratico dei vocaboli e delle frasi di uso comune nella lingua del Paese di immigrazione, tenendo eventualmente anche un corso più avanzato nel caso siano pure presenti emigranti già in possesso di cognizioni linguistiche;
f) dare la propria consulenza professionale per i problemi che l’emigrante ha lasciato in patria e per quelli che prospetta per il suo immediato futuro.
g) « L’Assistente Sociale POA e ONARMO è un apostolo ».
Ricordando il concetto di Padre Matteo secondo cui Y Apostolo è nient’altro che un calice ripieno di Amore che dona ai fratelli il soprappiù, si invitano tutte ad entrare con slancio nel clima degli Esercizi Spirituali per rifornire abbondantemente il proprio calice onde poter molto riversare sui fratelli.
L’Apostolo è tale in quanto dona — il dono è amore perciò vita.
Non sempre è facile l’opera dell’Apostolo. Spesso la nostra particolare opera di Assistenti Sociali è ardua, alle volte ingrata! Le passioni, i pregiudizi, gli interessi sono alle volte una barriera che sembra insuperabile. Ma non bisogna dimenticare che l’uomo è fatto per il soprannaturale, e che perciò istintivamente quasi lo cerca. Alle volte la più dura resistenza è nient altro che una più viva presenza del problema, e perciò frequentemente ove è più accanita resistenza si trova più vicina la vittoria. Basta che tutto il nostro operare sia sempre permeato dallo spinto dell’apostolato.
Storia del servizio sociale aziendale in Italia e all’estero, 3, 1958, pp. 6-10.
di Virginia Delmati
L’assistenza di Fabbrica è il primo Servizio Sociale sorto in Italia ed il rifarne la storia è un po’ descrivere la storia del Servizio Sociale presso di noi.
Ne è stata la iniziatrice, non dobbiamo dimenticarlo, la Dott. Tarugi Paolina, attuale Direttrice della Scuola UNSAS di Milano, la quale ne pose le basi fin nel 1921 nel primo dopoguerra a Terni ed a Milano, svolgendolo in una certa misura, a favore delle donne dei combattenti che erano state assunte al lavoro nei posti lasciati liberi dagli uomini sotto le armi. La Dott. Tarugi, divenne così anche la prima tecnica della materia.
Ho l’onore di essere stata la seconda su questa strada, cominciando anch’io, a Roma nel ’23, in forme diverse per ambito e per ispirazione, ma simili per natura, il Servizio Sociale di Fabbrica; confesso, però, senza conoscere il lavoro di colei che mi aveva preceduto.
Nella documentazione che ho potuto raccogliere, e sulla quale delineerò la mia comunicazione, non ho potuto rinvenire alcuna traccia riguardo quel lavoro di Terni e di Milano, primo ad apparire tra noi; nè ho potuto aver contatto con la fonte diretta.
Non posso quindi che usare, come notizie, quelle che direttamente appresi nel 1928 alla I. Conferenza Internazionale di Servizio Sociale a Parigi, dalla Dott. Tarugi stessa e di cui la sentii molte volte parlare in seguito.
Il Servizio Sociale di fabbrica dell’ONARMO
Non potendo quindi descrivere più esattamente il lavoro di Milano c di Terni, sono costretta a riferire subito su quello che nel ’23 iniziai io, nell’ONARMO, a Roma. Come documento mi rifaccio ad una relazione presentata alla Iª Conferenza Internazionale di Parigi – luglio 1928 – cioè ad un opuscolo in francese, di cui ho preparato la riproduzione dalla documentazione che ho nelle mie carte.
Il Servizio di Fabbrica svolto dall’ONARMO, vi risulta costituito da un insieme di Servizi Sociali promossi allo scopo di «creare dei legami umani nei membri dell’azienda, concepita come unità economica ». L’azione dell’Ente fu « di fortificare dal di dentro il senso dell’interesse comune, e la fusione di tutti gli elementi della produzione, considerati come cellule di un corpo economico unico, la cui salute reagisce diversa-mente a seconda delle diverse interrelazioni tra di loro, nella unità caratteristica dell’azienda, completa in se stessa, che bisogna però munire dei mezzi per una coesistenza possibile, anzi amichevole ».
Studiamo innanzi tutto la serie dei rapporti che l’ONARMO stabilì con l’importante impresa con la quale venne a contatto, e che si svolsero consapevolmente con successive chiarificazioni e precisazioni reciproche.
Relazioni dell’ONARMO con l’azienda a diversi livelli:
1° Con le sfere responsabili.
All’inizio (1923) un grande complesso industriale, al suo vertice, (amministratore delegalo) incaricò l’Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale agli Operai, dell’assistenza ai lavoratori dei propri stabilimenti. L Opera accettò ma propose l’istituzione di alcuni impianti assistenziali che riteneva attrezzature indispensabili per svolgere gli incarichi affidatele. I padiglioni assistenziali furono costruiti e la gestione fu affidata al1’ONARMO. Tale impostazione si ripeterà in seguito, per altri complessi della grande industria e di alcune aziende statali: e costituisce ancora la base della prassi vigente che regola l’assunzione di Servizi Sociali di Fabbrica da parte dell’ONARMO. subordinata ad alcune premesse.
Se è vero che le Amministrazioni rivolgendosi all’ONARMO mirarono e mirano, a fini morali, lo fecero evidentemente anche allo scopo basilare della produttività: e, subordinata-mente, a quelli di economia pratica. Dal vertice della società, si interpellò l’ONARMO e si stipularono con la Opera convenzioni sui programmi, piani e preventivi documentati, che presentò la Direzione Generale della ONARMO, la quale trattò a questo livello, ed a questo oggi ancor tratta.
2° Con la Direzione degli Stabilimenti.
La Direzione Generale ONARMO, stipulati gli accordi, entrò in contatto con la Direzione degli Stabilimenti, per l’applicazione dei piani e per l’inserimento dei propri tecnici, ai fini di stabilire la loro specifica attività, di determinare i locali che essi occupavano, i limiti del loro orario, e loro dipendenza amministrativa, nei vari servizi di officina, cantiere, miniera, etc.
Al Cappellano c alle Assistenti Sociali fu assegnato un ufficio, non imporla come attrezzato, interno alla fabbrica, ma proprio e libero.
3° Con impiegali e tecnici di officina.
I dipendenti delI’ONARMO stabilirono con il personale di questo livello, rapporti di collaborazione, su di un piano di parità morale, pur nella diversità dei ruoli e della dipendenza burocratica.
4° Con i lavoratori.
Tutta l’attività dell’ONARMO fin dall’inizio fu finalizzata al loro servizio sociale, ossia a facilitare la vita lavorativa personale, ed ambientale, degli operai, sia in senso orizzontale, come in quello verticale, sul piano pratico, su quello psicologico, spirituale e sociale.
Su questo genere di rapporti si stabilirono i servizi assistenziali impiantati e gestiti nel 1923 dall’ONARMO alla Viscosa di Roma, successivamente negli stabilimenti di Napoli, di Rieti, e gradatamente, nel seguito degli anni, in tutta l’Italia, nella grande e media industria tessile, mineraria, chimica, di alta meccanica, siderurgica, molitaria, chimica, cartaria e di Stato.
Prima assistenza sociale di fabbrica dell’ONARMO a Roma
I primi servizi svolti dall’Opera, furono quelli che introdussero nell’Italia Centrale e Meridionale (la quale a differenza del Nord, non le conosceva): le Mense Operaie, ossia la possibilità di un pasto caldo,
nell’interruzione del lavoro in stabilimenti che impiegavano da 2000 a 2500 operai; degli Spacci viveri economici aziendali; di convitti operai femminili (300 letti) e maschili (250 letti) dotati di ogni comodità, e direi gaiezza, per le maestranze immigrate da fuori Roma, anche in età minorile, come tutte le donne; le iniziative culturali, quali, di particolare interesse, i Corsi professionali, offerti agli operai circa i processi scientifici e meccanici della specifica lavorazione cui erano addetti; di meccanica applicata in tale lavorazione; ed i corsi per le operaie minori: di economia domestica, di taglio e cucito; la fondazione di biblioteche circolanti; l’instaurazione di attività ricreative: teatro, cinema, circoli, concerti e fanfara e di attività sportive: il campo di gioco e le escursioni.
Ed inoltre l’assistenza religiosa con Cappelle stabili e funzioni occasionali. Qui è necessario sottolineare infatti che l’Ente cui le aziende avevano affidato i servizi sociali era un Ente particolare: sociale e religioso che, sorto dietro gli esempi dei grandi Vescovi Scalabrini e Bonomelli, dichiarava di avere il fine principale di tentare di avvicinare Cristo agli operai, da cui essi si erano allontanati nella prima rivoluzione industriale, e di cercare di riproporre di nuovo, francamente, apertamente, il Cristo alle loro anime.
Lo spirito dell’ONARMO, dice infatti un lavoro che ne studia le origini e la storia « è quello eterno e sempre nuovo del Vangelo, che ci ha insegnato la teologia perenne imperniata sulla fraternità. Il Vangelo da annunziarsi di nuovo, a tutte le creature, ai minatori, ai fornaciai, ai guardiafili, ai calibristi, ai palombari, alle tessitrici, alle dattilografe, alle cernitrici di carbone, cercandoli tutti, se essi non vengono più in Chiesa; ma da predicare anche a coloro che amministrano il denaro delle imprese, delle miniere, ai direttori delle officine e delle industrie; poiché il disagio e lo sforzo del lavoro, come l’eccessivo denaro e le preoccupazioni degli affari, ostacolano le vie della spiritualità; mentre il Vangelo apre spiragli di insondabili speranze agli oppressi dalla fatica, come agli oppressi dalla ricchezza, ed è capace di sollevarli dalle loro sollecitudini, stanchezze, presunzioni e sfiducia, creando tra gli uni e gli altri una comunità fatta di identità interiore pacifica: nel senso della loro uguaglianza di fronte a Dio, e della loro insufficienza, fintanto anch’essi non giungano, come tutti, all’amore ».
Questi sono i motivi del Servizio religioso dell’ONARMO, svolto dai Cappellani del lavoro, che dettero vita all’Opera e che ispirarono il primo Servizio Sociale di Fabbrica, a Roma nel 1923; l’ONARMO li diffuse poi a tutto il paese e le isole; e, durante la guerra, lo prestò alle categorie lavoratrici nelle loro varie vicende di dentro le fabbriche, vigilate dagli stranieri, e di fuori delle fabbriche, nella fame e disoccupazione, quando, dagli stranieri, ne furono cacciate nel modo che tutti ricordano.
Documenti del Servizio Sociale di Fabbrica in Europa nel medesimo periodo: 1923 – 1929
A quanto ho detto sul Servizio Sociale di Fabbrica in Italia dalla sua origine alla 1ª Conferenza Internazionale di Servizio Sociale dovrei, secondo il tema, aggiungere notizie storiche sul medesimo servizio in Europa. Ma la unica documentazione ufficiale di questo periodo, proprio quella della medesima Conferenza, è introvabile, e purtroppo anch’io pur avendovi partecipato, non mi trovo in possesso che del 2° Volume degli Atti, interessantissimo d’altra parte, ma che contiene soltanto relazioni sulle applicazioni del Servizio del caso individuale. In esso perciò, quanto al Servizio Sociale di Fabbrica, non si legge che il rapporto di Monsieur Ferencz Rajniss, Segretario Generale delle Assicurazioni Operaie e Direttore di Scuola sociale a Budapest, in « Contributo del Servizio Sociale dei casi individuali ed attività umane» (vol. 2 pag. 462 parag. C) che vi comunico brevemente, essendo l’unica fonte antica ufficiale in mio possesso, sulla attitudine del Servizio Sociale di Fabbrica 30 anni fa!
Servizio Sociale nel lavoro
« Nell’industria il fattore umano appare oggi di una importanza sempre più considerevole. Gli economisti classici parlano dell’offerta e della domanda, della produzione e dei mercati, di certe ferree leggi che reggono la vita economica. Sotto la minaccia della guerra di classe, sotto l’influenza delle direttive della scienza e delle idee umanitarie moderne, cominciamo a parlare di dibattiti pubblici sui salari, di sindacalismo, di cooperazione economica, di consigli di azienda, ed agiamo in conseguenza. Studiamo i problemi dell’orientamento professionale, del riposo e della fatica, dello sciopero etc.
Da parte dei datori di lavoro non è certamente per effetto di un umanesimo nuovo, ma di un nuovo calcolo sul rendimento, poiché è una verità scientifica già riconosciuta, che si guadagna di più per l’apporto volenteroso e cosciente del salariato che per il lavoro delle macchine, che, prive del loro spirito animatore, non sono che ferramenta. La sintesi recentemente instaurata nell’industria si manifesta sul piano economico nelle colossali imprese moderne, i trust, i cartelli e tutte le vaste combinazioni « verticali » ed « orizzontali » dell’industria attuale: aggiungete a ciò la riorganizzazione e la correlazione attuale delle risorse finanziarie dei mercati; è evidente che viviamo in un’epoca di transizione dopo la quale il capitalismo avrà una portata sociale del tutto differente da quella che noi viviamo oggi. In rapporto stretto con questa trasformazione, ed appoggiata da essa, riforme importanti si attuano nell’ambiente della protezione dei lavoratori.
Più l’unificazione, la livellazione e la cooperazione d’ordine pratico ed economico progrediscono, meglio la legislazione sui salari, le giornate lavorative e l’igiene del lavoro possono riflettersi nelle officine o nelle masse operaie.
La storia economica dei paesi più evoluti dimostra che la sintesi non avviene in un solo campo : la società nel suo insieme può progredire verso una assistenza migliore.
C’è una dipendenza logica e reciproca fra la costituzione dei trust, la produzione su vasta scala e l’organizzazione dei datori di lavoro ed operai. A misura che si sviluppano sorge spontaneamente il servizio moderno di protezione del lavoratore che si adegua ai problemi particolari delle diverse industrie, senza allontanarsi dall’indirizzo generale seguito dal mondo industriale.
Per le Assistenti Sociali dell’assistenza al lavoratore, l’officina è una unità completa in sè. Le condizioni del lavoro, l’igiene, i servizi di soccorso agli infortunati, i servizi sanitari, l’assunzione, l’avanzamento, i trasferimenti e licenziamenti degli operai, le scuole ed i corsi per apprendisti, l’applicazione della psicologia del lavoro, i problemi relativi ai lavoratori adolescenti, le questioni generali dell’apprendistato, della disciplina, della ricreazione, degli sport, e lo spirito dell’autogoverno dei lavoratori e tutte queste materie
derivano da una sola e dalla medesima entità unità che progredisce verso l’efficienza, sotto la propulsione della sua anima viva. Come si può migliorare la società aumentando le iniziative individuali e fortificando nel medesimo tempo la famiglia, nello stesso modo si può fortificare ed umanizzare la vita industriale, attraverso le singole unità industriali considerate ciascuna a sè.
Questa tendenza sintetica nuova ha per risultato l’apparire nell’industria di nuovi specialisti e di nuovi operatori, che si pongono generalmente sulla linea che separa gli imprenditori dagli impiegati.
Direttori del personale, Assistenti Sociali, medici di fabbrica, Assistenti Sanitarie, istitutori, esperti psicotecnici incaricati dell’orientamento professionale e d’un nuovo trattamento dell’energia umana, tutti ispirati dalle idee nuove, hanno ormai conquistato le officine ».
Secondo Periodo, ’29 – ’39 – ’43. Organizzazione dell’Assistenza Sociale di fabbrica della Confederazione Generale Industria
Come conseguenza della Conferenza Internazionale di Servizio Sociale, del luglio del ’28 a Parigi, la quale ufficialmente registrava nel 1° volume l’esistenza di un Servizio Sociale di Fabbrica e l’esistenza di Scuole di Servizio Sociale, la Confindustria istituì nel 1929 l’Assistenza Sociale di Fabbrica, confederale, provvedendo, anche con il suo finanziamento, alla erezione della prima Scuola Superiore di Assistenza Sociale per la preparazione delle Assistenti Sociali di Fabbrica, scuola che doveva vivere fino al giugno 1943, e che nel periodo della sua vita diplomava n. 280 Assistenti Sociali specializzate.
Come ho accennato, organizzatrice e direttrice centrale di tutto il nuovo servizio e creatrice della cartotecnica relativa, ancora in parte in uso, fu la dott.sa Tarugi. In particolare, ella fu preposta alla sede di Milano: a Roma ed a Genova fummo chiamate rispettivamente io, che ero già al lavoro nelle fabbriche, e la sig.ra Margherita Grossmann, la quale aveva un diploma di Ginevra in Servizio Sociale. Avremmo dovuto preparare il campo di attività per le prime allieve diplomate dalla Scuola nel giugno del 1929.
Il nuovo servizio fu inserito dalla Confindustria nei suoi quadri direttivi di Roma, ove fu istituita la Sede Centrale àe\Y Assistenza Sociale di Fabbrica, con funzioni organizzative, ispettive ed amministrative. Le spettavano la promozione delle attività inerenti, il raccordo con le Associazioni Industriali, dette allora limoni Industriali, l’instaurazione del rapporto di lavoro con le Assistenti Sociali, e la loro direzione tecnica ed amministrativa. La direzione centrale presso la Confindustria fondò anche una rivista confederale, « Assistenza Sociale di Fabbrica», assai degna non solo per il formato, ma anche per il contenuto, di cui esiste soltanto una collezione presso l’odierna Confindustria, nella quale come nel n. 7 e 8 dei Quaderni Sociali Confindustria, maggio — agosto ’51, si trova la documentazione relativa alle notizie che riporto.
La presentazione del servizio, le trattative locali e l’attrezzatura degli uffici, erano affidate alle varie « Unioni degli industriali », competenti sulla giurisdizione territoriale delle varie provincie. Con il progredire del tempo, furono nominate alcune ispettrici per le varie regioni; e, poiché dopo alcuni anni, la Scuola inserì le proprie diplomate in parti uguali nella Confindustria come nella Confederazione dei Sindacati Lavoratori, la Dott.sa Turgi, nel 1935, passò presso questa 2ª Confederazione per curarvi l’organizzazione e le attività delle « Assistenti Sociali dei lavoratori ».
Caratteristiche del Servizio
L’Assistenza Sociale di Fabbrica della Confindustria assunse principalmente il carattere di servizio sociale individuale ai lavoratori dell’industria, e funzionò soprattutto quale consulenza tecnica assicurativa, mutualistica, burocratica, amministrativa, sociale ed assistenziale propriamente detta. Non si deve credere, come qualche volta si ritiene, che tale servizio sociale individuale rivestisse uno stretto carattere burocratico. Bisogna riflettere al tempo cui questo lavoro si riferisce, di transizione, socialmente parlando, in cui si preparava l’avvenire. Intanto, il blocco dell’Emigrazione all’Estero, aveva determinato il profilarsi delle correnti immigratorie interne, con direzione dalle provincie più povere di industria, éd in genere di lavoro, a quelle più provvedute, cagionando l’agglomeramento urbano, il superaffollamento delle abitazioni, Io stato precario e la scarsezza delle medesime, il basso livello di vita e della cultura dei lavoratori immigrati rispetto a quelli delle comunità recipienti. D’altro lato le innovazioni di carattere sociale che avvennero in questo periodo, quale l’istituzione della assicurazione tubercolosi, degli assegni familiari; l’unificazione delle mutue aziendali; la creazione dell’Enaoli e dell’Assistenza ai grandi invalidi del lavoro dell’Inail; consentono di comprendere la mole e l’utilità sociale del Servizio delle Assistenti che fu divulgativo, esplicativo e di adattamento dei lavoratori all’industria, e solo in apparenza burocratico; ma in realtà pazientemente didattico, educativo e riabilitativo.
Ogni Assistente Sociale di Fabbrica della Confindustria, dislocata presso le varie Unioni degli industriali. aveva la responsabilità di un gruppo di stabilimenti. Presso le Unioni, ove il lavoro esigeva più di un’A.S. si nominò un « Capo-sede » e si munì la sede di qualche impiegalo, in aiuto all’assistente sociale.
Dopo alcuni anni la Confindustria affidò alle proprie A.S., addette a grandi complessi industriali, quali la Montecatini, la Fiat e l’Ansaldo. la sorveglianza, ed in parte l’organizzazione di servizi sociali aziendali collettivi, sotto le direttive di un « Ufficio assistenza » delle Ditte medesime.
L’Ufficio Assistenza della Montecatini, sede centrale di Milano, descrisse un profilo professionale dell’Assi-sten te di Fabbrica che è molto interessante. L’Assistente viene considerata. nella sua giornata lavorativa, come collaboratrice del medico. Doveva presenziare all’ingresso degli operai per notare dal loro aspetto esteriore e dai tratti della loro fisionomia il loro stato economico e quello psicologico; collaborare con vigile attenzione a cogliere i primi sintomi delle malattie professionali e convincere i sospetti alla diagnosi precoce; aiutare moralmente ed economicamente le famiglie in necessità, e soprattutto in occasione degli infortuni sul lavoro; organizzare le colonie di vacanza dei figlioli dei lavoratori.
Compiti del personale degli uffici del lavoro, dei collocatori e dei corrispondenti comunali nel settore della previdenza ed assistenza sociale:
Per l’istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie gli uffici del lavoro adempiono i seguenti, compiti:
— comunicazione agli Uffici locali dell’Inam degli avviamenti al lavoro;
— accertamento, a richiesta degli Uffici locali dell’Inam, della concordanza fra i dati risultanti dalla documentazione in possesso dell’Inam e quelli risultanti all’Ufficio di collocamento, sulle assunzioni e cessazioni dal lavoro in determinate aziende;
— richiesta agli Uffici locali dell’Inam e consegna ai lavoratori appartenenti a determinate categorie o settori dei documenti di iscrizione all’Inam;
— convalida periodica dei documenti di iscrizione per i lavoratori predetti;
— raccolta a richiesta dei lavoratori interessati dei documenti per la iscrizione allTnam dei familiari a carico e per le variazioni de] nucleo familiare.
Per l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
— segnalazione alla competente sede provinciale dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di prestatori d’opera manuale, specificando il numero e la qualifica professionale delle persone richieste.
Per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura:
— raccogliere e inviare tempestivamente agli Uffici provinciali gli elementi necessari per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia che l’accertamento dei lavoratori stessi si attui con il sistema presuntivo sia che si effettui mediante libretti personali;
— fornire agli Uffici anzidetti ogni altra notizia richiesta nei riguardi dei lavoratori agricoli nonché gli elementi e i dati di cui possono venire in possesso per il reperimento dei nominativi dei coltivatori diretti assistibili dalle relative Casse di malattia e degli agricoltori soggetti al pagamento dei contributi unificati;
— raccogliere e trasmettere agli Uffici medesimi gli stati di fanti-glia e gli altri certificati occorrenti per la erogazione degli assegni familiari agli aventi diritto;
— distribuire a tempo debito agli interessati i moduli di domanda di indennità di disoccupazione, trasmettendoli poi con le eventuali osservazioni agli Uffici Provinciali dei contributi unificati;
— mantenere gli opportuni contatti con le Commissioni comunali di cui all’art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945 n. 75.
Esperienze. Incontro Collaboratori, Assistenti Sociali, Segretari Provinciali Rev.mi Delegati Onarmo di Toscana, 4, 1958, pp. 4-7.
Il Rev.do Sac. Vinicio del Perugia dopo una prolusione introduttiva ha presentato ai congressisti il Rev.do Don Giuliano Agresti, il quale ha tenuto una conversazione su « Spirito Soprannaturale del Servizio Sociale ».
Dopo aver definito il Servizio Sociale in ordine al sollievo delle insufficienze umane e alla positiva costruzione della personalità nella sicurezza sociale, Don Agresti considerava il bisogno umano come fondamento del Servizio Sociale. Bisogno che è connaturato all’uomo e che è aumentato dalla malizia del peccato. Diceva che l’Assistente Sociale cristiana solleva il bisogno con spirito scientifico, ma illuminato dallo « spirito cristiano », nella Verità e nella Carità.
In ordine al bisogno sarebbe vano condursi con una pura « solidarietà naturale »; occorre invece camminare nello spirito evangelico, nella carità soprannaturale.
Don Agresti affermava anche che è errato distinguere l’umanizzazione e l’evangelizzazione con un « prima e poi ». Noi umanizziamo evangelizzando, e perchè la natura decaduta ha bisogno di redenzione, anche per vivere umanamente bene e perchè, in concreto, molte crisi sociali sono effetto di crisi religioso-morali.
Don Agresti ricordava che lo Assistente sociale cristiano deve aiutare « tutto l’uomo » insistendo a rilevare i valori spirituali di esso, ma anche i valori bio-psichici per l’armonia dell’uomo in ordine al suo fine.
Si richiede quindi nell’assistente sociale dell’ONARMO una « qualificazione cristiana » in ordine alla conoscenza e alla vita, per far bene ed esattamente conoscere e vivere il cristianesimo dagli assistiti.
È importante che gli strumenti tecnici del Servizio Sociale, siano usati nello spirito soprannaturale.
Nel Servizio Sociale cristiano scienza, fede e morale si uniscono per il bene materiale ed eterno dell’uomo. La meditazione finiva con una riflessione sull’amore cristiano, perfezione di ogni agire fra gli uomini e per gii uomini ».
Ore 16. — Pensione ai Coltivatori Diretti e Mezzadri. (Legge n. 1074 del 26 ottobre 1957).
Il Signor Vignozzi illustra quali siano le categorie e quali requisiti siano occorrenti per avere diritto all’assicurazione invalidità e vecchiaia per la categoria degli agricoltori in genere.
Infatti risultano esclusi dall’assistenza quei coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno annuo di mano d’opera inferiore a 30 giornate.
Fa riferimento ai contributi necessari per ottenere le prestazioni da parte della Previdenza Sociale che consistono grosso modo in 5 anni di attività lavorativa in campo agricolo, di cui 104 contributi da destinarsi al capo famiglia e 52 ai componenti la famiglia, con tutte le eccezioni e le norme concernenti tale accreditamento.
Sig. Dominici di Arezzo — chiede delucidazioni sulla liquidazione pensione alle donne lavoratrici in agricoltura.
Sig. Vignozzi — illustra le modalità ed i requisiti necessari per il caso in discussione.
E per quanto riguarda i contributi da versare per 1e assicurazione, il signor Vignozzi, fornisce un’ampia e chiarissima spiegazione.
Con. Migliorati — A fine della discussione si dichiara d’accordo con il signor Vignozzi per quanto riguarda alcune risposte date ai convenuti circa obiezioni da essi sollevate a proposito di talune lacune o presunte ingiustizie della legge in questione.
Ruolo della Capo Sede
Ore 17,30 — La sig.na Annunziata Viganò, Caposede assistenti sociali di Firenze, parla alle Capo Sedi su « Compiti della Caposede Diocesana con particolare riferimenti ai Centri Sociali ».
Inizia dicendo che in un Ente di Servizio Sociale come l’ONARMO, le funzioni della Capo Sede sono rivolte ad una effettiva realizzazione degli scopi per cui esiste l’Ente.
La Capo Sede non svolgerà un Servizio Sociale diretto, ma arriverà ad assolvere il proprio compito e quello dell’Ente verso la massa degli assistiti solo attraverso le assistenti sociali. Detto questo, le molteplici attività della Capo Sede si possono dividere in due campi: quello amministrativo e quello di guida delle assistenti sociali.
1) Funzioni Amministrative. Esaminata la sua posizione tra le assistenti sociali ed i Delegati. Di fronte ai Delegati rappresenta le assistenti sociali. Li tiene al corrente del lavoro che svolgono, fa presente le loro difficoltà e necessità mentre di fronte alle ass. sociali rappresenta i dirigenti e fa da loro portavoce. Notato in in modo particolare come si debba far uso della nostra preparazione di assistenti sociali per far opera di persuasione da ambo le parti affinchè tutte le possibilità dell’Ente siano sfruttate e sviluppate.
Breve esame dei compiti relativi:
1) Compiti pratici variano a seconda della necessità e le diverse impostazioni delle Sedi, comunque si tratta dell’organizzazione della vita interna della Sede.
2) Responsabilità di integrare il lavoro dell’assistente sociale con quello dell’Ente e collegamento con le varie assistenti sociali (cercando di raggiungere attraverso riunioni periodiche una stretta collaborazione delle assistenti sociali).
3) Particolarmente sui rapporti con i Delegati partecipare alle considerazioni sulle assistenti ed il loro lavoro, portando il proprio giudizio, aiutando i Delegati a mantenere le loro decisioni coerenti alle necessità, sia delle assistenti che degli assistiti.
4) Rendersi conto e valutare attraverso l’attività delle assistenti sociali i bisogni presenti della comunità verso cui è rivolto i1 lavoro, comunicandolo ai Dirigenti.
Il compito di guida delle assistenti sociali si può considerare sotto due aspetti: consulenza e controllo.
Consulenza: considerando le difficoltà e i problemi che incontrano (ad es. le assistenti dei Centri Sociali) si può capire che la loro preparazione tecnica spesso non basta. Si sentono oppresse e se abbandonate a se stesse si lasciano andare; hanno bisogno di sentire dietro di sè che l’Ente le segue da vicino e le aiuta a risolvere i problemi più gravi e si assume certe responsabilità.
Così la Caposede durante le visite al Centro terrà dei colloqui con le assistenti mediante i quali potrà incoraggiare l’assistente sociale a formulare il piano di trattamento adatto al caso ed alle persone. Altro vantaggio, l’assistente sociale prova ad esaminare ed esprimere il proprio pensiero con un’altra persona, esaminando le validità delle ragioni che lo sostengono. La Capo sede inoltre aiuta l’assistente a divenire cosciente dei propri problemi quando questi interferiscono in qualche maniera nel suo lavoro. Non si deve trattare l’assistente sociale ma solo aiutarla a controllare le proprie reazioni emotive se esse interferiscono con la sua attività.
5) Infine è necessario sollecitare e trovare i mezzi perchè le assistenti sociali curino il loro aggiornamento e sempre un maggior perfezionamento tecnico del servizio. Il controllo delle attività poi sarà fatto periodicamente durante le visite ai Centri. Il controllo sarà prima di tutto di aiuto alle assistenti perchè metterà il punto al loro lavoro e darà loro modo di stabilire insieme alla caposede programmi a breve scadenza, ai quali poi sarà facile attenersi.
Interviene il Rev.do Don Remo Vaselli il quale si riferisce alla circolare n. 118 e conferma quanto è stato sopra illustrato dalla sig.na Viganò. Rileva il dovere delle Caposedi di attendere ad una qualificazione delle assistenti sociali e di aiutarle nelle loro difficoltà.
Si apre la discussione sul modo di attuare questi compiti e diverse Caposedi rilevano le difficoltà che incontrano.
Servizio Sociale di Fabbrica
Ore 18 — La sig.na Milena Boschi, Caposede di Prato, parla sul Servizio Sociale di Fabbrica.
Inizia spiegando che considera i compiti della Caposede di una unica natura, quindi non ripete quello che è stato precedente-mente detto dalla sig.na Viganò; ma si limiterà ad illustrare come sono stati organizzati da lei il Servizio Sociale di Fabbrica a Prato, prima, poi quello, in via di attuazione, alla San Giorgio di Pistoia.
Riguardo a Prato, dietro indicazione del Vescovo, ella si presentò ai vari industriali offrendo il Servizio Sociale Onarmo e stabilì con essi le condizioni base per un buon Servizio. Lo iniziò lei stessa e poi, superate le prime difficoltà, quando il lavoro si svolgeva ormai regolarmente, lo ha passato alle collaboratrici sociali.
Per quello che riguarda invece la sua nuova esperienza a Pistoia ha riferito le sue prime impressioni. Ancora non è un mese che la sig.na Boschi presta il suo servizio e quindi per ora la sua attività è rivolta più che altro ad uno studio d’ambiente. Ad ogni modo già si rivelano possibilità interessanti perchè già diversi organizzazioni interne di assistenza e di attività ricreativa hanno richiesto la sua collaborazione.
Dopo la conversazione della sig.na Boschi, si è aperta la discussione su alcune difficoltà che si incontrano negli ambienti di fabbrica e sul modo migliore di superarli. Si è anche trattato dei fondi inferni di assistenza e dei sistemi con cui vengono amministrati.
Funzionamento delle Segreterie Provinciali
Ore 17 — Rag. Usai, Segretario Prov.le di Livorno, illustra quale sia il funzionamento in genere delle Segreterie Provinciali.
Riferendosi poi alla circolare n. 118 della Direzione Centrale riassume i principali compiti delle Segretarie e Segretari Provinciali. Cioè quello di ricevere dalle varie Caposedi diocesane le pratiche, già revisionate, da portare agli Uffici provinciali. Provvedere all’ordinamento e funzionalità dell’Ufficio Segreteria in modo che tutto il carteggio sia protocollato, registrato, classificato e raccolto in archivio con la più scrupolosa attenzione.
Tende a precisare che i Segretari provinciali ed i loro collaboratori hanno funzioni esclusivamente attinenti al proprio ufficio, e non possono essere impiegati per altri servizi, salvo s’intende per ordine del Delegato.
Infine loro compito è quello di tenere contatti con gli Uffici di Previdenza e assicurativi; ed i rapporti con le Caposedi devono essere improntati con la più stretta collaborazione ed aiuto.
Can. Migliorati — chiede se in tutte le Sedi è stata fatta la distinzione fra Caposedi e Segretari Provinciali.
Rag. Usai – risponde che in tutte le sedi non è stato possibile, tenuto conto che la Direzione Centrale non ha provveduto con l’opportuna nomina a distinguere le due attività.
Can. Migliorati — risponde precisando che le nomine spettano al Presidente ODA in accordo con il Delegato Regionale.
Sartiani — Grosseto — rileva la necessità di una rivista a cura dell’Onarmo che compendi tutte le variazioni che si verificano di tempo in tempo nell’ordinamento legislativo riguardante il lavoro e la Previdenza Sociale, infortunistica e l’assistenza malattia. In tal modo si avrebbe in breve tempo un aggiornamento rapido e di materia già selezionato per cui il compito dei dirigenti del servizio di patronato sarebbe oltre modo facilitato.
Il can. Migliorati — prende atto di tale proposta e dichiara di associarvisi e di farne richiesta alla Direzione Centrale.
La riunione dei Segretari Provinciali termina aggiornando i lavori a domenica mattina.
Ore 19,30 — È intervenuta anche la Prof. Falorni, Direttrice della Scuola Superiore di Servizio Sociale ONARMO di Pisa, per un breve saluto ai convenuti e ha colto l’occasione per offrire la collaborazione della Scuola Onarmo di Pisa alle varie caposedi e ai Delegati per quello che riguarda un aggiornamento e una qualificazione tecnica del personale.
Sac. Del Perugia — a questo proposito ha chiesto se poteva dare alle Caposedi alcune indicazioni sui testi e manuali di servizio sociale da mettere a disposizione delle assistenti sociali.
Prof. Falorni — ha fatto notare che per quello che riguarda il Servizio Sociale di gruppo e di comunità ancora non è sfato tradotto che ben poco. La Scuola può invece preparare e distribuire delle dispense su questi argomenti.
Ass. Soc. Di Paola — Ha chiesto se fosse possibile inviare da parte della Scuola del personale qualificato per illustrare queste nuove tecniche alle assistenti e collaboratrici sociali.
Prof. Falorni — risponde che nei limiti del possibile farà in modo di inviare un monitore della Scuola presso quelle Sedi Diocesane che organizzeranno delle riunioni a scopo di studio.
Alle ore 20 è terminata questa prima parte del Convegno.
Domenica 26 Gennaio 1958
Ore 8,30 — S. Messa e breve meditazione tenuta dal Rev.do Don Vinicio Del Perugia su « Come il Padre ha mandato me, così io mando voi ». Gii uomini collaboratori di Dio nella salvezza delle anime. Nel corso dei secoli cambieranno forme e metodi ma il fine rimane sempre lo stesso.
Assistenza sociale è una di queste forme moderne. Assistente sociale è un apostolo — la sua opera un apostolato. È necessario quindi:
1) Spinto soprannaturale che è: a) Spirito di fede: nel soggetto (l’Uomo Figlio di Dio) nella missione (Collaboratore di Dio); h) Spirito di carità: amore verso Dio-Perciò vita di Grazia — vita sacramentale — amore verso gti uomini (per amore di Dio).
2) Senso di dignità: Siete i rappresentanti di Dio, nella Chiesa e dei vostri Vescovi.
Virtù che dovete conquistare: bontà — carità — giustizia – prudenza. Dignità nel contegno — Serietà nel vestire — Generosità — Spirito di sacrificio.
Conclusione: opera di apostolato quella delle Assistenti Sociali. Il risultato dipende dalla Grazia di Dio e dall’opera vostra. La Grazia di Dio sarà in proporzione alla vostra vita interiore e dalla generosità al dovere. Opera vostra che sarà in proporzione allo zelo — alla vostra serietà, alla vostra preparazione professionale.
Lavori di Gruppo
Ore 9,30 — L’assistente sociale Umberto Bulletti, parla sul « Lavoro di Gruppo ».
« I progressi notevoli di questi primi decenni del secolo delle scienze che hanno per oggetto uno studio sistematico della società e sociologia — psicologia sociale — antropologia — politica sociale ecc. hanno latto convergere l’interesse sul « gruppo » ritenuto come unità {ondamentale, dopo l’individuo logicamente, di tutta la struttura della moderna società ».
Sulla constatazione del bisogno essenziale dell’individuo di vivere in società per la soddisfazione delle sue esigenze fonda-mentali, per la maturazione della sua personalità e sulla importanza del gruppo per l’azione rilevante che ha sia sull’individuo, sia sulla comunità, sta il presupposto del lavoro di gruppo come tecnica di servizio sociale.
Premesso che il — group-work — è strettamente correlato alle altre tecniche sicché deve intendersi come parte integrale di una unica metodologia di lavoro, esso viene definito soprattutto rispetto agli scopi che sono principalmente quelli di un accrescimento della personalità per mezzo del gruppo – del migliore adattamento dell’individuo in qualsiasi ambiente umano – della sua preparazione a ricoprire ruoli di responsabilità e di direzione nella società e quello di un innalzamento del livello generale del gruppo in modo che dall’integrazione delle personalità che lo compongono, raggiunga un grado di omogeneità e di coesione, di maturità e di preparazione tali da far sentire il peso della sua azione in tutta la comunità.
Definito ampiamente nelle linee generali e con esemplificazioni pratiche il lavoro di gruppo, lo sviluppo della relazione ha messo a fuoco la figura dell’assistente sociale di gruppo con riguardo alla sua preparazione professionale specifica.
Preparazione di base intesa come approfondita conoscenza teorica delle varie dottrine che interessano il lavoro di gruppo e principalmente sociologia (metodologia di ricerche) psicologia sociale – psicologia evolutiva del comportamento; esperienza pratica di vita vissuta attivamente in gruppi od al servizio di gruppi organizzati.
In particolare una conoscenza dello sviluppo del senso sociale dell’individuo con i problemi connessi dell’educazione ed addestramento alla vita sociale, dei vari interessi e bisogni e quindi della varietà di attività programmate e di tipi di gruppi. Studio esauriente del gruppo, sistematicamente impostato sopratutto per la conoscenza delle principali leggi che ne regolano l’esistenza (processi di gruppo) e delle dinamiche interpersonali con addestramento particolare della tecnica dell’osservazione per la valutazione dei singoli e del gruppo, dei loro bisogni, dei loro interessi desideri, delle loro capacità, spingendo lo sguardo oltre il gruppo per esaminare le risorse della comunità ai lini del lavoro.
Ottima conoscenza dei principi basilari e delle tecniche di group-work. Particolare considerazione per il leader strumento di grande valore nel lavoro di gruppo. Quindi ricerca dei « capi » per la loro formazione e utilizzazione per la migliore funzionalità dell’organismo sociale, con riferimenti particolari alle esperienze di ciascuno. E particolare considerazione ai programmi, altro strumento di lavoro di notevole portata, altroché mezzo di valutazione diagnostica del gruppo. Programmi che devono nascere dalla base, condizionati ai bisogni reali del gruppo, ai suoi interessi, e non essere imposti dall’alto.
Occorre sapersi valere delle risorse della comunità per il rafforzamento del gruppo, e saperlo inserire nell’organizzazione più vasta. Questi rapidi accenni — è stata la conclusione — hanno presentato un quadro sintetico che deve essere sviluppato perchè si possa avere in questi settori una preparazione professionale adeguata, sia alle esigenze degli assistiti, sia agli scopi ed alla struttura dell’ONARMO.
Per questo è da proporsi un corso particolare per l’aggiornamento e la specializzazione di assistente nel group-work impostato sul metodo della discussione a gruppi.
Don Del Perugia — ringrazia l’ass. soc. Bulletti per l’esauriente relazione e prende nota di quanto consigliato dall’Assistente Sociale per una migliore qualificazione del personale dipendente dall’Onarmo.
Amministrazione
Ore 11 — Il Rev.do Don Del Perugia illustra ora uno schema per l’ordinamento dei Centri Diocesani, dei Centri Sociali e delle Segreterie Provinciali.
Fa presente gli obblighi delle assistenti sociali verso l’istitutodal quale dipendono, l’orario di lavoro come prescritto dal regolamento: orario settimanale di 48 ore suddivise razionalmente in ciascun giorno, lasciando (dove dire poco riguardo ai primi problemi di adattamento in quanto c’è necessità) delle ore per l’aggiornamento tecnico e discussione del lavoro; consiglia di tenere tali riunioni ogni 15 giorni. Le Capo-sedi hanno il compito dì rivedere l’orario di ciascuna e dove ci sono più assistenti sociali è necessario il registro per la firma. È inoltre necessario che ogni assistente o collaboratrice Sociale compili un diario giornaliero che deve essere fatto su fogli, e ogni settimana presentato alla Capo-sede che lo porterà al Delegato Diocesano affinchè prenda visione del lavoro svolto e apponga la propria firma ed il proprio giudizio. Ogni mese tali diari dovranno essere consegnati, insieme alle relazioni, al Delegato Regionale.
Chiede il parere ai Delegati regionali presenti e ne ottiene parere favorevole.
Illustra poi i compiti delle Capo-Sedi, come già presentati a Calambrone durante il Corso di aggiornamento.
Sac. Remo Vaselli — Fa osservare che tali compiti devono essere illustrati anche ai Presidenti ODA per ovviare inconvenienti che si sono verificati e da lui nuovamente appresi nella discussione avuta con le caposedi la sera prima. Propone quindi un convegno con i Delegati Diocesani inviando uno stralcio della circolare n. 118.
Don Del Perugia e il Can. Migliorati — approvano tale decisione e stabiliscono di fare un Convegno dei Presidenti ODA nel mese di Febbraio o ai primi del mese di Marzo.
Don Del Perugia — Continua parlando dei rapporti fra i Segretari Provinciali e le Capo Sedi che devono essere improntati nella massima cordialità e schiettezza per evitare contrasti noie e intralci al buon andamento del lavoro.
Rivela l’obbligo di far osservare alle assistenti e coll. soc. le registrazioni e le compilazioni delle schede (specialmente la scheda n. 30) affinchè siano aggiornate e tenute con scrupoloso ordine.
Per quanto riguarda poi la corrispondenza: nei Centri Diocesani la corrispondenza con gli Enti per la richiesta di documenti deve essere firmata dalla Capo Sede e nei Centri sociali isolati può farlo la collaboratrice stessa. I contatti con gli Uffici pubblici devono essere improntati con la massima delicatezza e serietà. Se sorgono inconvenienti con i vari Enti di Previdenza segnalarli o ai Presidenti ODA o ai Delegati Regionali i quali cercheranno tramite la Sede Centrale di risolverli.
Il comportamento degli assistenti e collaboratori sociali in ufficio e al di fuori dell’Ufficio deve essere improntato dalla più scrupolosa serietà. Spetta alla Caposede ad imporsi essendo lei responsabile, di fronte al Presidente ODA e alla Sede Centrale, sia del lavoro, sia del comporta-mento di ciascun assistente o collaboratore sociale.
Altro avviso: in caso di malattia gli assistenti avvisino, entro il terzo giorno; e nel caso si trattasse di un lungo periodo inviino tempestivamente il certificato medico; ciò per dar modo alla Caposede di sostituirli.
Termina raccomandando l’aggiornamento tecnico e spirituale di tutto il personale per una migliore qualificazione di esso e per una più approfondita visione di vari problemi che interessano il nostro lavoro. Fa presente che a cura dei Delegati regionali sarà predisposto un regolamento interno per il buon funzionamento del nostro Servizio Sociale.
Registrazione Casi
Ore 12 — Sac. Remo Vaselli — parla sulla registrazione dei casi.
Inizia illustrando la necessità e l’importanza della registrazione dei casi. Infatti nel registrare l’assistente sociale riesamina la situazione ambientale e sociale del caso trattato.
A titolo esemplificativo legge una registrazione redatta da una allieva della Scuola Superiore di Servizio sociale di Pisa.
Viene aperta la discussione sul caso in oggetto.
Fra i vari interventi da rilevare quello dell’assistente sociale Buletti Umberto, il quale rileverà che la registrazione letta non era abbastanza chiarificatrice di come sia da tenersi una buona registrazione.
Can. Migliorati —Conclude il Convegno dando alcune norme pratiche per un miglioramento tecnico del nostro lavoro affinchè possa rendersi sempre più efficace.
Esperienze. Relazioni umane e servizio sociale aziendale in Campania, 5, 1958, p. 2.
di P. Tofano
Il Dr. Franco quale Presidente di un complesso industriale (la Navalmeccanica di Napoli) e Presidente dell’LN.A.M. di Salerno, inizia una brillante discussione sulle « esperienze aziendali e le relazioni umane » in rapporto all’organizzazione dell’INAM stesso.
Per quanto riguarda il primo punto narra alcuni particolari della sua attività e . della sua esperienza e dice che il più valido aiuto nell’opera di penetrazione ira gli operai l’ha avuto proprio dalla collaborazione delle Ass. Soc. dell’ONARMO che, attraverso le visite domiciliari, gli hanno fatto conoscere le condizioni familiari degli operai, il sistema di vita ed il livello di educazione degli operai stessi e lo hanno quindi messo in condizioni di poter agire e quindi affrontare in pieno il problema di accostamento dell’operaio nell’ambito della fabbrica.
Ci esorta quindi a studiare la psicologia degli operai in rapporto alla società e rivolgendosi in particolare alle Ass. Soc. di Fabbrica, le esorta a seguire lo operaio, sul lavoro specialmente i nuovi assunti aiutandoli a superare lo stato di disadattamento, di prostrazione e di inferiorità in cui spesso vengono a trovarsi, e di divenire in effetti le rasserenatrici del loro primo lavoro.
Assistere l’uomo nella formazione della sua personalità e nell’affermazione della su a vita spirituale.
Uno dei mezzi può essere quello di avvicinarli attraverso la pratica previdenziale, ma il fine deve essere un altro: strapparli alla mentalità diffidente prerogativa della massa operaia.
Conclude affermando che con la perseveranza si può giungere al nostro intento ed al fine ultimo che è quello di avvicinarli al bene, alla fiducia, a Dio.
Sul secondo punto il Dr. Franco ha esposto prima in genere la organizzazione dell’INAM di cui è presidente ed in particolare si è soffermato su diversi punti:
Distinzione fra le due forme assicurative.
Chi ha diritto alla assicurazione: classificazione delle categorie assistibilù
A quali prestazioni hanno diritto i familiari degli operai.
Le varie forme di assistenza.
Rapporto dell’INAM con i medici e con i farmacisti.
Il Dr. Franco porta degli esempi pratici e le Ass. Sociali prendono parte attiva alla riunione ponendo dei quesiti che vengono chiariti e risolti.
Norme fondamentali :
1° Far sapere a ciascuno cosa si richiede da lui.
2° Dare a ciascuno il dovuto riconoscimento, nel tempo e nel modo appropriato,
3° Non far trovare nessuno di fronte a sorprese.
4° Valorizzare ciascuno al massimo delle sue capacità, e lasciare che ciascuno possa compiere quella carriera che si merita.
Storia del Servizio Sociale Aziendale in Italia e all’estero (II parte), 5, 1958, pp. 11-13.
di Virginia Delmati
Riporto come il solo esempio di cui dispongo, relativo al tipo di lavoro dell’A.S. di Fabbrica, la prima delle mie relazioni del Servizio a Roma datata del 20 gennaio 1930:
« Questa sede di « Servizio sociale di Fabbrica », iniziava le sue attività il 21 febbraio dello scorso anno; annovera ora, al 31 dicembre 1929, in 70 ore di servizio, negli stabilimenti « Viscosa », « Officina Gas », « Farmacologico Serono », « Tipografia delle Terme ».
« Fabbrica di Concimi Chimici », n. 953 richieste, le quali condussero a 576 prestazioni di cui 459 con risultato positivo, n. 60 ad esito in parte negativo; lettere scritte n. 990, arrivate 546, schedine di assistiti abitualmente n. 380. Le richieste e le relative prestazioni hanno avuto il carattere più vario, ma si possono sintetizzare: in pratiche amministrative e prestazioni sociali propriamente dette: Mentre le pratiche amministrative sono in massima parte costituite dalla produzione di documenti civili e militari — alcuni assai importanti o contestati — le prestazioni sociali furono prestazioni di appoggio in questioni inerenti al lavoro, o intervento, concesso dietro richiesta, in affari domestici o sussidi, o ricerca di alloggio operai. Ogni bisogno, ogni interesse, ogni aspirazione può rintracciarsi nelle numerose note a lapis dei nostri taccuini di fabbrica: dalla richiesta di una lezione di inglese dell’operaia D., che deve istruirsi la sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, a quella dell’operaio M., che vuole completare l’incartamento della liquidazione della sua pensione militare, da anni in corso. Le bambine C., della Viscosa, ci domandano di pacificare loro e la mamma con il padre operaio del Gas; 1’operaio L. ci richiede che la salma di suo marito venga tumulata, come merita, nel « campo d’onore » al Verano, togliendola dal campo comune, in cui riposa; l’operaio B. ci incarica di rintracciargli un cognato lolle, trasferito all’insaputa della sua famiglia che ne ha perduto le tracce, da un manicomio a un altro sconosciuto. L’operaio C. domanda la croce di guerra in ritardo, ma in considerazione della sua prerogativa di mutilato la ottiene; la famiglia D. desidera rintracciare a New York un figlio dimentico dei suoi; uno studente di liceo, figlio di un operaio, domanda gratuitamente dei libri e un professore di greco; l’operaio P. vuole, la cura dei fanghi ad Aqui; e poi vi sono le richieste continue di carta di povertà, ed i sussidi etc.
Passano nel nostro ufficio i casi più gravi; donne che hanno il marito disoccupato, i figli scalzi, la casa che è una baracca; altre le quali hanno in famiglia un male che insidia loro gli orfani; giovani operaie sole al mondo, malate per sempre, sgomente di fronte al problema dell’esistenza, donne abbandonate dai mariti che combattono sole la lotta della vita; madri nubili dimenticate dal padre dei loro figli, tutti gli aspetti, insomma della vita sociale.
Da questo nostro lavoro così intenso, affiorano alcuni problemi che per l’assurdità con cui si presentano nei vari ambienti, appariscono generali. Il più importante è il problema degli alloggi operai, richiesti con insistenza per le condizioni di disagio delle presenti abitazioni in alcuni quartieri poveri come ad es. Prenestino, Tor Pignattara, Marranella. Un altro grave problema che merita di essere segnalato, è la necessità, vivamente sentita, della più agile ed efficace collaborazione degli Enti assistenziali pubblici e parastatali, affinchè ciascuno di essi che contempla un a-. spetto particolare della vita pubblica o civile dell’assistito, insieme agli altri integrantesi e completatesi a vicenda, di fatto adempiano l’intera assistenza, senza duplicati ed antagonismi, e senza dimenticanze nocive ai comuni interessi. La coordinazione di un servizio all’altro, con il derivante scambio di prestazioni e di reciproco diritto e dovere di esse, è qualche cosa di assai desiderabile che potrebbe condurre all’istituzione di quegli uffici di assistenza sociale centrali, di smistamento e di controllo, la cui utilità è stata sperimentata più volte all’estero ».
La guerra ed il Dopoguerra
La parentesi tragica della guerra spezza, nel dicembre 1943, l’Assistenza Sociale di Fabbrica della Confindustria e pone fine quasi completamente al servizio delle A.S. a motivo della divisione dell’Italia ed, a riorganizzazione avvenuta, della aumentata indipendenza delle Associazioni provinciali degli Industriali, non molto propizie alla centralizzazione del Servizio a Roma.
Pochissime sedi rimangono ancora in vita, tra le quali a mia conoscenza, quella di Lecco, Torino, Firenze, Terni e Napoli. Le Assistenti di Fabbrica nei tragici momenti della guerra dettero esempio meraviglioso di fedeltà al dovere e di dedizione, rimanendo ai loro posti di lavoro nel travaglio terribile della guerra, senza rimunerazione, e continuando a visitare gli stabilimenti, rispettale anzi venerate da tutti, nonostante la confusione di partiti. Una di loro vi lasciò la vita, uccisa per mitragliamento in servizio.
Al 31 dicembre 1942 la Confindustria contava n. 273 AA.SS. e nn. 75 impiegati operanti in nn. 1308 ditte.
Scuola per la preparazione delle Assistenti di fabbrica
Qui occorre spendere una parola sulla Scuola Superiore di Assistenza Sociale del Governo, finanziata, come ho detto, della Confindustria, fondata nel 1929, finita nel giugno 1943. Il suo programma era orientato esclusivamente alla formazione delle A.S. di Fabbrica e si articolava in gruppi di materie propedeutiche — giuridiche, mediche ed economiche — e in quelle sociali propriamente dette, sviluppate soprattutto nel campo del lavoro industriale.
La scuola durava un anno. Le studentesse dovevano vivere nel pensionato per 8 mesi consecutivi, molto duri. Periodi prestabiliti erano dedicati alle esercitazioni a fianco della A.S. già al lavoro.
Da quella Scuola, che diplomò, ritengo, 260 A.S., uscirono molte delle professioniste più note attualmente che ricoprono posti di responsabilità, attuali direttrici e monitrici di Scuole di tutti i gruppi, tecniche degli Enti Assistenziali e dell’Eca, dei Sindacati, etc.
L’assistenza di Fabbrica Onarmo durante e dopo la guerra
Quanto all’ONARMO, nel periodo dal 1942, continuò come abbiamo visto, indefessamente la propria azione sociale.
L’opera fu insignita di medaglie al valore civile e militare per l’assistenza prodigata agli operai sul lavoro e disoccupati, a quelli sinistrati o degenti negli ospedali, agli sfollati, retati o rinchiusi nelle prigioni.
Il non aver perduto contatto con gli assistiti, consentiva all’Onarmo di assumere nel ’45 quei Servizi di Fabbrica che richiesero il suo intervento, e quelle Assistenti Sociali che domandarono di entrare a fare parte del suo personale.
Una statistica dell’Assistenza Sociale di Fabbrica dell’ONARMO nel 1945 presenta questi dati annuali, per Roma:
Stabilimenti in servizio n. 27
con prestazioni complessive » 13051
sopralluoghi » 3303
ricoveri » 721
Assistenti Sociali » 7
Le Assistenti Sanitarie pure operanti in Roma classificano come lavoro dell’anno:
Pratiche sanitarie n. 913
assistiti » 753
Visite domiciliari » 2270
ricoveri e spedalizzazioni » 23
Scuola di Servizio Sociale
Nello stesso anno 1945 I’ONARMO istituì la sua prima Scuola Superiore di Assistenza Sociale in Roma, sorta autonoma, prima di ogni altra nella nostra città, di cui vi riporto la prima parte del manifesto, il quale ha un certo interesse in quanto vi si esprimono chiaramente il motivo, lo spirito, il carattere della Scuola e vi si enumerano i settori di tirocinio che, con i criteri odierni, potrebbero ben definirsi validi, quanto al loro campo, anche se allora non esisteva una supervisione, come oggi si concepisce.
1945. Scuola Superiore di Assistenza Sociale ONARMO
L’Onarmo (Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale Operai) inaugurerà nel prossimo gennaio una Scuola Superiore di Assistenza Sociale per la formazione tecnica religiosa e morale di Assistenti Sociali specializzate la cui attività, adeguata ai metodi e sistemi più moderni della diagnosi e del servizio sociale, si ispira al Messaggio evangelico.
La Scuola ha grado superiore perchè intende valersi di metodi scientifici per la disamina accurata e profonda del malessere sociale, considerato nelle sue cause e nei suoi effetti, e dei mezzi adatti ad alleviarlo nei vari suoi molteplici aspetti. La Scuola ha carattere prettamente cattolico perchè si propone di illustrare il valore squisitamente sociale del Cristianesimo, della sua dottrina e della sua morale.
La Scuola infine è femminile perchè intende invitare e preparare le donne colte all’esercizio di una professione profondamente conforme alle loro più insite attitudini e virtù di dedizione, ed offrire ai loro studi un campo di utile applicazione.
Il corso, che ha la durata di un anno scolastico comprenderà lo studio delle varie discipline, base per un Servizio Sociale tecnicamente inteso, presupposti scientifici indispensabili; ed il tirocinio pratico, che verrà eseguito nei vari servizi di assistenza,
ossia:
A) — Assistenza sociale di contingenza
— campi
— accantonamenti
— posti ristoro stazione
— approvvigionamenti
B) — Assistenza Sociale Aziendale
— mense
— spacci di fabbrica
— servizio sociale di fabbrica
— convitti operai
C) Policlinico del Lavoro
D) Assistenza Ospedaliera
— Assistenza religiosa aziendale
— Conferenze S. Vincenzo de’ Paoli
— Ritiri Operai
— Apostolato della Preghiera
— Missioni
— Redazione giornale « Il Notiziario ONARMO ».
Lu scuola e esterna: la frequenza obbligatoria per l’ammissione agli esami ed all’esame di diploma che sarà rilascialo alla fine del corso.
Il programma scolastico é a disposizione delle allieve.
Titolo di studio: licenza magistrale superiore — licenza liceale — età — dai 25 ai 35 anni ».
Notizie internazionali sul Servizio Sociale di fabbrica
Infine per terminare questa storia, la chiuderò riportando le notizie su questo servizio raccolte negli Atti del Réncontre Internationale d’études à Bruxelles il 4 ed il 5 agosto 1946, che lo caratterizzano anche all’estero, come abbiamo tentato di farlo per l’Italia.
Il Servizio Sociale di Fabbrica vi si definisce come mezzo interessante la produttività e catalizzatore della unità aziendale, oltre che servizio individuale.
Dal « Rapporta présentés ù la Rencontre intcrnationale d’Etudes, organisée par l’Union Catholique Internationale de Services Social — da 4 au 5 aóut 1946 a Bruxelles ».
Il Servizio Sociale nell’industria belga di Mad.lle Van den Bruel extraits da « L’homme dans la Production » (pp. 82 e 55).
Nel ’46 il Servizio Sociale di fabbrica vantava in Belgio 25 anni di esistenza. Gli elementi di pura sentimentalità che avevano caratterizzato le sue forme originarie erano sparite gradatamente a mano a mano che la sua tecnica si precisava,
Il Servizio Sociale di Fabbrica è definito come un elemento importante per la direzione migliore e più scientifica dell’impresa. Benché una buona gestione non possa preoccuparsi soltanto di assicurare la produzione, ma deve stabilire le condizioni ed i metodi di essa, e special-mente il ruolo del lavoratore, l’adattamento a tale suo ruolo ed all’ambiente di lavoro; e, benché l’insieme industriale sia costituito dalle materie prime, dai processi di lavorazione, dai metodi di produzione e dalle strutture industriali, ciò nonostante la direzione di un’impresa consiste soprattutto nel guidare esseri umani.
Per l’A.S. belga, la necessità di una collaborazione nel seno di una azienda è viva : capi e dipendenti ne sono responsabili nella stessa misura; ma in realtà «la persona che detiene la responsabilità iniziale e determinante nell’impresa, è il datore di lavoro » (S. Lewishon « Les relations industrielles » pag. 54).
Quando uno speciale servizio o persona viene incaricato, dalla direzione dell’impresa, della soluzione di difficoltà individuali, molto frequenti nell’azienda, e viene incaricato anche dello studio di tali situazioni in relazione con la comunità di lavoro, un primo passo e fatto verso una migliore intesa tra dirigenti e lavoratori. Questo servizio è il Servizio
Sociale di Fabbrica, la persona è l’Assistente Sociale. Inoltre per la relatrice belga, lo scopo del Servizio Sociale di Fabbrica sarebbe di assolvere in certo modo i, doveri, degli, imprenditori, rispetto alla mano d’opera umana.
Il posto del Servizio Sociale di Fabbrica nella impresa, deve essere quello che consenta una condizione di autonomia reale, pur supponendo la collaborazione con gli altri servizi, non la dipendenza di essi. Infatti mentre i servizi tecnici mirano tutti al potenziale problema di produzione, il Servizio Sociale mira all’uomo, fattore della produzione. Da questa differenza deriva la collaborazione tra i due servizi, i quali sono più che indipendenti, interdipendenti tra di loro.
Secondo questa relazione il Servizio di Fabbrica non si dovrebbe chiamare « servizio del personale », ma servizio sociale perchè sociale è tutto quanto riguarda il rapporto umano.
Direzione del Servizio Sociale
Si distingue tra piccole, medie e grandi aziende. Nella piccola « lo imprenditore » svolge direttamente e personalmente il suo compito sociale ed è lui capo del suo servizio sociale; nelle aziende medie, il proprietario affida il Servizio Sociale ad un capo-servizio, che si trova allo stesso livello degli altri capo servizio tecnici. Nelle grandi imprese la direzione del Servizio Sociale sarà affidata a persone con nomina di Direttore Sociale. Difficilmente questi incarichi sono ricoperti da Assistenti Sociali e più raramente ancora da donne Assistenti Sociali. Occorrerebbero assistenti di marcata personalità e di maturo equilibrio per sostenere tali grandi responsabilità.
Storia del Servizio Sociale Aziendale in Italia e all’estero (III parte), 6, 1958, pp. 11-12.
Servizio Sociale industriale nel Canada di P. Emile Bouvier S. J. (1946):
« L’industria canadese considera le relazioni tra il capitale ed il lavoro da tre punti di vista diversi : Servizio del personale, Servizio delle relazioni industriali, Servizio sociale industriale;
a) per servizio del personale in Canada e negli Stati Uniti si intendono le relazioni tra l’operaio e la impresa, per quanto riguarda l’assunzione, le promozioni, i trasferimenti, le sospensioni, i licenziamenti, la rotazione della mano d’opera, le assenze, l’educazione, l’addestramento tecnico e la sicurezza sociale, ossia l’operaio in fabbrica ;
b) per Servizio delle Relazioni Industriali si intendono le relazioni tra lavoratore ed impresa, in quanto concerne i problemi biologici, i problemi morali, i problemi economici e sociali degli operai, l’operaio come membro della società;
c) per Servizio Sociale Industriale si intende l’organizzazione e mantenimento delle condizioni di vita che convengono al personale ed assicurano ai lavoratori il conforto materiale, l’occasione di adoperare le loro attitudini, i mezzi per sviluppare le loro risorse naturali.
Nella concezione americana le industrie devono applicare quasi esclusivamente il Servizio del personale ed il Servizio delle relazioni industriali.
Il Servizio Sociale industriale è considerato invece come servizio ausiliario, aggiunto, diretto e condotto dall’« ufficio del personale » o da quello delle « relazioni industriali ».
Questo è il concetto delle industrie Canadesi di lingua inglese; invece quello di lingua francese danno importanza al « Servizio Sociale industriale ». Il direttore delle « relazioni industriali » o l’Assistente Sociale, sono le persone che costituiscono ufficialmente il legame tra il capitale e il lavoro. In certi casi le Assistenti Sociali cumulano le loro mansioni e quelle di direttori del « personale » e delle « relazioni industriali ». In altre la officina ha un direttore « del personale » ed un « Assistente Sociale ».
Quanto ai Servizi Sociali del Canada sono costituiti da mutue, cooperative edilizie, cooperative di credito, casse di risparmio, attività dell’abitato, giornale di officina, sala di lettura, mense, bar, vestiari, organizzazioni ricreative, servizi legali, doni.
Purtroppo gli scopi dei servizi dice il relatore, sono di diminuire la fluidità del personale, rendendolo più stabile, per mezzo di migliori condizioni di lavoro.
II vero spirito dovrebbe invece essere la cura di umanizzare e cristianizzare l’operaio.
Questa relazione porta anche il profilo dell’A.S.; gli affidano 300 o 400 operai da assistere, ed ella rappresenta un legame tra lavoratori ed imprenditori. Ha un piccolo ufficio, all’interno dell’officina, la cui porta è sempre aperta.
Simpatica, avvenente e popolare (si parla di donne), ella conosce bene i suoi e li ricorda; controlla l’assunzione dei lavoratori, compila le loro schedine anamnestiche, segue i progressi degli apprendisti. Qualche volta dà consigli su di un bilancio, altra volta redige il giornale di officina. Si occupa del vestiario e delle mense. Fa propaganda per il risparmio, la previdenza e l’organizzazione delle casse operaie. Partecipa all’organizzazione degli sport come dei divertimenti.
In Canada è in vita, dal 1943 una « Associazione Professionale tra Assistenti Sociali di Fabbrica ».
La formazione professionale delle assistenti di fabbrica è affidata ad una Scuola della Facoltà di Scienze Sociali della Università di Monreal, che dal ’45 presenta una Sezione di « Relazioni Industriali » ed una di « Servizio Sociale Industriale ».
La Scuola dura 3 anni e Pallieva deve fare durante essa ben 270 ore di pratica. È impegnata nelle industrie principali (op. cit. pag. 76-81)».
Servizio Sociale di fabbrica in Francia (1946). Relazione di Mad.Ile Denyse Delsarte:
Questa relazione mette in evidenza il carattere tutto particolare di democrazia del Servizio Sociale di Fabbrica in Francia.
« Poiché nel Paese le masse popolari accedono (sic) « alla maggiore età », da tutte le parti sorge, nella classe operaia, non solo il desiderio di migliorare, ma anche quello di arrivare a tale miglioramento da soli.
Ne deriva l’iniziativa operaia, che reclama la sua parte nell’organizzazione della vita economica e nella gestione dell’impresa.
Il Servizio Sociale di Fabbrica, è sorto in Francia durante e dopo la I guerra mondiale, si è inserito nell’impresa capitalista in una determinata maniera. Ma bisogna prevedere i mutamenti che avverranno quando la struttura dell’impresa acquisterà i caratteri comunitari e democratici.
Intanto tutto ciò che fanno gli A.S. di Fabbrica francesi per facilitare l’accesso dei lavoratori alle responsabilità sociali, per dar loro occasione di esercitarvi le loro capacità di responsabili, per provocare insomma una educazione alla riflessione ed alla iniziativa, certamente và nel senso della futura evoluzione, che costituirà una liberazione.
Il decreto del 2 novembre 1945 sulla modalità d’esercizio dei Comitati di Impresa, definisce il profilo delle Assistenti Sociali. Esse prendono il nome di « Consigliere del Lavoro ». Esercitano le loro funzioni di consigliere tecniche per le questioni sociali, nel Comitato Aziendale (composto dei rappresentanti di tutti gli ordini del personale: operai, impiegati, dirigenti); possono essere incaricate da tale Comitato della organizzazione e direzione dei servizi sociali devolutigli dall’imprenditore, attuando il Servizio Sociale nel luogo stesso del lavoro (art. 12 del Decreto).
La relazione crede di riconoscere nei costumi e nelle istituzioni del mondo industriale, un dinamismo tendente a far partecipare alla marcia dell’impresa tutti i membri di questa società economica,’ certamente i lavoratori.
Il Servizio Sociale di Fabbrica cerca, attraverso i suoi molteplici servizi, di attuare la promozione operaia, affrettando l’apertura dei responsabili industriali ad una concezione larga delle loro autorità; questo incontro degli uni e degli altri, nella ricerca e nella realizzazione del benessere comune della società, perfezionerà l’impresa.
Quando l’A.S., in luogo di prendere l’iniziativa o la direzione di organismi, si contenterà di essere al servizio di tutti le resterà certo ancora completamente un suo ruolo ».
Alcuni punti orientativi per il Servizio Sociale di fabbrica, 8, 1958, pp. 12-14.
di Virginia Delmati
1° PUNTO. Ambiente in cui si svolge Il Servizio Sociale di Fabbrica
— La realtà nella quale il Servizio Sociale di Fabbrica opera è l’azienda o una entità economica. Entità economica cioè un complesso di forze regolato da leggi di diversa natura:
— alcune riguardano gli scopi da raggiungere, e sono leggi economiche;
— altre i mezzi da adottare per raggiungere tali scopi: sono leggi fisiche;
— altre i soggetti chiamati ad adoperare quei mezzi, sono gli uomini; le leggi che li regolano sono: biologiche, psichiche, sociali e morali. Il convoglio delle diverse forze concomitanti alla produzione, nell’armonico giuoco delle rispettive leggi, costituisce l’unità aziendale da raggiungersi e la sua efficienza vitale.
Ormai si sono sistematizzati i dati di questa vita aziendale in elaborati, in dottrine o scienze particolari, relative alla « organizzazione aziendale », alla attività produttiva, alla « direzione di azienda », alle « relazioni umane », alla « psicologia industriale ». Bisogna prepararsi su queste materie come ci si prepara con una inchiesta d’ambiente preventiva, avanti di iniziare qualsiasi lavoro.
2° PUNTO. Che cosa è necessario che l’assistente sociale conosca
Il piano di forze cui il Servizio Sociale, ossia lo assistente sociale si rivolge, è quello dell’uomo, assai più delicato di ciascuno delle altre componenti della produttività.
a) Le tecniche professionali
— L’assistente sociale di Fabbrica è un eSne dell’adattamento umano, ossia dei metodi n facilitare nell’uomo, quando si senta, o si riveL disadattato al gruppo sociale in cui opera V promozione all’equilibrio tra le sue risorse endogene, mal dirette, o inattive, o bloccate e quelle esogene dell’ambiente o società in cui egli vive senza soddisfazione.
Tali metodi l’assistente sociale applica nei confronti del disadattato, usando tecniche appropriate di stimolo, di obbiettivazione e di attuazione di sè, basando il rapporto professionale con lui, sul rispetto per la dignità della persona umana, e sulla fiducia delle ricche possibilità di essa.
— Questo servizio considera il singolo uomo nella fabbrica, il lavoratore, in quanto disadattato, ossia nella sua realtà di disagio. Si sa che tra gli uomini che lavorano, certamente, il disagio economico, ossia delle cose, è talvolta grave; ma in genere tra i lavoratori, il disagio più preoccupante è quello psicologico. Si tratta di una situazione aspra, materiata di scontento e di rivendicazione, stillante impazienza ed ostilità. In tali limiti agisce il casework, tutte le volte che l’ambiente, la fabbrica consentirà di stabilire il rapporto personale tra assistente e lavoratore, e di applicare le tecniche relative.
b) L’origine della mentalità operaia e di qu dei datori di lavoro.
— Ma prima, occorre che l’assistente sociale renda conto di che cosa sia una massa industriale costituitasi un secolo e mezzo fa, derivata dal ceto artigiano o contadino, strappalo dal lavoro casalingo, o da quello della campagna e trasferita, accatastata, in agglomerati industriali.
Il superaffollamento, la denutrizione, la disoccupazione, hanno prodotto ben presto, in auesta massa, la tubercolosi, l’alcoolismo, la miseria, ed i tristi portati della ignoranza, della delinquenza minorile e di adulti, e della prostituzione.
Questo sormontare di bisogni, da un lato ha sviluppato lo spirito esplosivo di esasperazione e quello classista, per reazione e per spirito di solidarietà; e, dall’altro, in un secondo tempo ha suscitato, nella società, il senso positivo della correlazione tra le condizioni del singolo e della comunità, e quindi il senso di responsabilità e questo è anche positivo.
Il Servizio Sociale rappresenta un lato di questa consapevolezza.
Perchè il Servizio Sociale sia efficace, dunque deve basarsi sulla conoscenza della classe operaia in tutta la sua caratteristica e più profonda natura, che le deriva dalla sua storia; ed insieme conoscere a fondo le reazioni o conseguenze che questa particolare storia ha prodotto negli uomini, i quali l’hanno vissuta. Nei lavoratori da una parte; nei loro dirimpettai, i datori di lavoro, dall’altra.
È tutto un mondo di fatti umani, sociali, culturali, in cui bisogna internarsi, seguendone tutti i meandri molteplici, sotto i punti di vista più vari; ed i loro sviluppi graduali, sino ad oggi.
Per rendersi conto della mentalità operaia, bisogna risalire al retroterra della frustrazioni, degli sforzi che sono alle origini della presente psicologia di scontento, profonda, dovuta in gran parte al passaggio dalle condizioni alla libertà, sicurezza e dignità artigiana e rurale, lavoro collettivo, monotono, incolore, spesso senza genio, delle fabbriche; all’affollamento di esse, ed al grigiore delle abitazioni operaie. E insieme al vuoto, portato dalle interrotte abitudini religiose del villaggio, dalla perdita della famigliarità della parrocchia,
della sua vicinanza, se in località remote dalla chiesa, oltre a quella della confidenza, che deriva dall’esservi conosciuti sin dal momento del Battesimo.
— Tutto ciò ha contribuito all’inaridirsi della mentalità operaia, inpoverita di fantasia, di capacità umana, e di fede.
— Tutto ciò ha prodotto il bisogno dell’accostamento dell’uno all’altro, l’identificazione del numero con la forza, facilitata dai metodi della prima organizzazione industriale.
Così è nata la collettività operaia, fatta di lavoro, estenuante spesso e di mortificanti condizioni di vita.
Che cosa questi germi abbiano prodotto nella mentalità odierna, e come reagiscono ancora alle trasformazioni industriali; come si presume reagiranno di fronte all’automazione, sono le realtà che bisogna conoscere nei termini esatti della « psicologia sociale », della « sociologia industriale », e della « organizzazione industriale ».
— Ed altrettanta necessità di conoscere lo sviluppo, nella industrializzazione, degli investimenti dei capitali individuali, il costituirsi delle fortune degli industriali in passato, il loro uso eccezionale, dato l’enorme rendimento, contrapposto alla miseria collettiva degli operai; ed il riflesso delle iniziative industriali nella formazione della mentalità speciale del capitano di industria, e di una nuova classe dirigente, ben diversa da quella nobiliare tradizionale della terra o della città.
E, nel processo dei tempi, l’attuale economia delle società anonime, della spersonalizzazione del capitale, dell’attuale volto della produttività, e di ciò che la finanza, e purtroppo il perdurare del conflitto.
3° PUNTO Quel che c’è da fare
— Su queste due opposte realtà, da Marx in poi, si susseguono i profeti della classe operaia; su questo terreno concreto, noi dobbiamo lavo-
Punti orientativi del Servizio Sociale di Fabbrica
rare da profeti, nel tentativo di contribuii e anche noi alla ricostruzione di questa particolare società e nella convinzione di poterlo fai e, che ci deriva dalla fede nella Redenzione di Gesù.
Certamente lutto quanto abbiamo cercalo di delineare non sarebbe avvenuto senza il deteriorarsi della filosofia, e cioè senza 1’affermarsi delle successive filosofie: razionalista, materialista, idealista, determinista.
— C’è anche il fattore della volontà umana da considerare, che poteva credo condursi meglio, in uno sforzo di fedeltà alla verità di Dio ed alla sua ricerca.
In ogni caso dobbiamo contribuire a rialzare :
— la dignità della persona umana
— la retta filosofia
— l’educazione del popolo che lavora.
Con quali mezzi?
— L’azione sociale. Bisogna rifare le strutture invecchiate ed insufficienti e togliere i disagi che esistono tuttora in troppo vasta scala
— nell’azione sociale, deve aver luogo il servizio sociale, piccola parte di essa, diretto alla persona umana
— l’educazione
— l’apostolato
Quale l’apostolato di fabbrica?
— Saper sottolineare la validità dei valori fonda-mentali in mezzo agli operai, inanzi tutto con l’esempio
— prestare servizio nella bontà, operando un bene disinteressato e dimentico di sè
— amici della verità, nella lealtà
— con umiltà sincera
— con fede viva in Dio
— e serena fiducia nella Provvidenza.
Questa la mentalità vivente da opporre come una realtà tangibile, quale invito alla mentalità desolata di odio che reclama amore.
Esperienze. Il Servizio Sociale in atto nelle Marche, 8, 1958, pp. 15-16.
La caposede
Cantieri di Lavoro
II servizio presso i Cantieri Scuola, Cantieri di Lavoro, e di Rimboschimento, si adegua alla caratteristica propria dei lavoratori in essi occupati e nella sua evoluzione ha seguito l’importanza che i Ministeri hanno dato a tale loro attività.
Dai Cantieri, il servizio spesso si è spostato alla Parrocchia, più vicina, perchè quando il Cantiere ha esaurito le giornate stabilite, la popolazione limitroia ha ormai bisogno dell’Ass.S. a cui si è affezionata, in quanto ne ha conosciuto la bontà, la capacità e lo aiuto che può dare. A centinaia sono i Cantieri che hanno avuto ed hanno il nostro S.S.
Circa il Servizio in favore delle Categorie, possiamo ritenere assai efficiente quello prestato ai Pescatori. In via di affermazione quello ai Lavoratori della Montagna, e Pastori.
Il Servizio Rurale è invece ancora una aspirazione che vorremmo poter tradurre in realtà, data l’alta percentuale nelle Marche della popolazione rurale. Ci è mancato sino ad oggi il personale specializzato, di cui ora invece, possiamo con sicurezza disporre.
Una recente istituzione dell’ONARMO sono le Segreterie Provinciali, che devono garantire il buon funzionamento della parte burocratica del nostro lavoro. Es-
se devono curare il coordinamento in sede provinciale, di vari servizi diocesani (la cui autonomia in questo porta serie conseguenze) raccogliere e perfezionare le pratiche di Patronato, presentarle a-gli Istituti di Assistenza e Previdenza, seguendole sino alla soluzione. Le segretarie devono anche organizzare il servizio medico – legale ed istruire i ricorsi. Rendersi responsabili, in una parola, di fronte agli Enti Pubblici di tutte le pratiche trattate dall’ONARMO. I nostri Uffici hanno cominciato a funzionare con scarsissimo personale. Però questo primo anno di vita, è servito sì a dar prestigio alla nostra organizzazione ed a collocarla fra i primi Patronati nelle Provincie di Ancona e Macerataa noi è costato un grandissimo sacrifìcio e non ha soddisfatto molto le Ass. Soc. le quali non hanno trovato nelle Segretarie, l’aiuto loro promesso.
Poiché, come è noto, il settore di Patronato è sotto controllo del Ministero del Lavoro, che vi compie ispezioni annuali, la Sede Centrale intende che gli Uffici Provinciali siano efficienti e rispondenti allo scopo da perseguire.
È perciò disposta ad accordare il personale necessario, come ha fatto recentemente ad Ancona, dove si è potuto sistemare tutto il lavoro sospeso.
La normalizzazione delle Segreterie dipende anche dall’efficienza delle Sedi Diocesane, che, special-mente quando hanno parecchio personale in azione, devono necessariamente seguire alcuni criteri organizzativi, comuni ad ogni ufficio ordinato.
La circolare n. 118 in data 11 luglio 1957 della Sede Centrale prevede la nomina di una responsabile, nella persona di una A.S. ritenuta più adatta delle altre ad assumere l’incarico di Capo Gruppo.
Questa pur operando alle dipendenze della Diocesi e pur svolgendo attività presso i Centri a Lei affidati, dovrà osservare alcune mansioni, che rispondono a reali esigenze dei nostri Uffici.
Riteniamo elencare tali mansioni che verranno comunicate con circolare e dovranno essere conosciute da tutto il personale perchè le rispetti e vi si adegui:
1) Dare una impronta spirituale e professionale a tutto il lavoro operante nella Diocesi, compreso quello svolto lontano dal Centro.
2) Seguire l’andamento del Servizio nei Centri Sociali e nelle Aziende anche con sopralluoghi.
3) Seguire il personale meno preparato, armonizzarlo ed affiatarlo col gruppo.
4) Prendere la responsabilità di chiarire determinate situazioni che intralciassero il normale svolgimento del lavoro.
5) Curare i rapporti del Centro Diocesano con la Segreteria Prov. e sorvegliare la raccolta delle protiche di Patronato.
6) Curare ed evadere la corrispondenza con le altre Sedi e Delegazioni Regionali.
7) Interessarsi dall’archiviazione di tutta la corrispondenza, (protocollo) e della organizzazione dell’Ufficio.
8) Comunicare alla Delegazione Regionale ed al Presidente O.D.A. le necessarie variazioni di orario, spostamenti di personale, assenze, permessi ecc. onde averne quando è possibile, la preventiva autorizzazione.
9) Fare la raccolta delle circolari e della stampa della Sede Cen.le e Segreteria, diffondendola alle colleghe nelle Riunioni Diocesane.
10) Organizzare d’accordo col Presidente O.D.A. le Riunioni periodiche Diocesane.
11) Inviare entro i termini prescritti (non oltre il 5 di ogni mese) alla Delegazione Regionale le relazioni e le note mensili delle spese, dopo averle sottoposte cri parere del Presidente O.D.A., Parere che la Sede Centrale vuole conoscere. Occorre anche inviare, sempre in duplice copia e con sollecitudine le copie dei verbali delle Riunioni locali.
Servizio Sociale Onarmo agli Emigrati in Germania, 9, 1958, pp. 8-9.
Hildèshèim, luglio ’58
L’Assistente italiana, sig.na Teresa Delpero, è tornata nella nostra sede nell’aprile 1958, prendendo immediatamente contatto con i due Missionari italiani della zona, con i Consolati di Hannover e di Amburgo e con l’Ufficio Regionale del Lavoro. In apposita riunione si è stabilito il programma generale di lavoro e la collaborazione con la nostra Caritas, i Missionari italiani ed i rappresentanti degli Uffici del Lavoro.
Per i tre gruppi di italiani di cui dobbiamo tener conto nella nostra opera di assistenza ossia per:
a) quelli rimasti nella nostra zona durante l’inverno;
b) quelli che tornano presso i datori di lavoro nei posti già occupati Io scorso anno;
c) quelli che vengono per la prima volta con contratto non nominativo;
è stato concordato il metodo di informazione e l’acccoglienza all’arrivo ad Hannover (Centro Regionale).
In tal modo è stato possibile che ogni convoglio venisse ricevuto unitamente dalla Caritas (Bahnhofsmission), dalla Assistente Sociale, dal Missionario, oltre che dall’incaricato dell’Ufficio del Lavoro e da un rappresentante del Consolato Italiano.
Gli italiani che arrivano nella nostra zona (in maggioranza protestante), vengono così, fin dall’inizio, a conoscenza del fatto
che la Chiesa vuol essere vicino anche qui, e che ha meg * a loro disposizione persone ed organizzazioni a cui potersi, volgere nelle loro difficoltà. Tutti gli italiani che hann0 trovato lavoro nella nostra zona sono registrati in apposito schedario e confrontati con gli elen. chi giacenti presso i locali Uffici del Lavoro ed in possesso sia dell’Assistente Soc. signorina Delpero presso il nostro Ufficio Caritas, come presso Don Angelo, il Missionario italiano.
Ogni italiano riceve al suo arrivo il piccolo « vademecum » con gli indirizzi del Missionario e dell’Ass. Soc. — nonché un piccolo notiziario mensile, anch’esso fatto in comune dal Missionario e dall’Assistente.
L’assistenza agli italiani in questa vasta zona viene fatta in primo luogo grazie al concentramento di un gruppo presso una .parrocchia per la S. Messa e successiva riunione informativo-ricreativa, guidata dall’Assistente. Ogni domenica e nei giorni festivi si svolgono due di queste riunioni, mattina e pomerig010> in località differenti. Ogni lavoratore della zona viene invitato a partecipare a tali riunioni con una lettera personale. La preparazione ed organizzazione delle riunioni vengono affidate alla Assistente Sociale insieme al segretariato della Caritas. Dall’allegato diario dell’Assistente sociale, si può rilevare, a seconda delle distanze, che almeno 100 italiani hanno partecipo ogni volta alle riunioni il che rappresenta un ottimo risultato, pensando che in tutta la zona gli operai italiani non superano i 1000, sparsi però su migliaia di Km. Spostandosi di zona in zona, sarà possibile organizzare almeno due volte tali riunioni per i più sperduti, tre o quattro volte per quelli più facilmente raggiungibili.
Il secondo compito che viene assolto dalla sig.na Delpero è costituito dagli interventi d’urgenza in seguito a chiamate dei segretariati parrocchiali o locali della Caritas, dell’Ufficio del Lavoro o anche dai datori del lavoro, che ormai sono abituati a scrivere o telefonare alla nostra 6ede per domandare la visita dell’Assistente in caso di difficoltà con gli operai italiani da loro ingaggiati.
Queste visite a domicilio o al luogo di lavoro, molte volte fatte a notevoli distanze, richiedono molto tempo ma sono di grande importanza dal punto di vista psicologico e pratico. Per questo particolare aspetto della sua attività, l’Assistente Sociale a volte si unisce anche al Missionario italiano. Se ciò è necessario l’A.S. discute delle condizioni di lavoro, col rappresentante dell’Ufficio del Lavoro e questi sempre con una delle colleghe della Caritas Tedesca, addetta alla zona.
Nella nostra zona della Bassa Sassonia, tutti i lavoratori italiani si trovano in una doppia solitudine: perché isolati l’uno dall’altro e disseminati in numerosi piccoli villaggi e perché la zona è prevalentemente protestante.
Servizio sociale di fabbrica, 1, 1959, pp. 10-11.
di Virginia Delmati
Il Servizio Sociale di fabbrica è un servizio svolto e attuato in un ambiente di lavoro comune, dove individui di condizioni sociali, morali, economiche eterogenee, di educazione e carattere diversi, vengono ad incontrarsi e devono collaborare per un unico fine.
È dunque un servizio svolto in un ambiente eterogeneo, dove gli individui sono per forza maggiore a contatto fra loro e dove questi individui, il più delle volte, devono sottostare ad una rigida e quasi militaresca disciplina, dove purtroppo devono, a volte muoversi controllando essi stessi i loro personali movimenti, per evitare l’inutile dispendio di energie e per il maggior rendimento nel lavoro!
Questo si nota specialmente nei grandi complessi nei complessi strutturalmente meglio organizzati, dove la tecnica ha raggiunto il massimo sviluppo, dove la mania dalla disciplina imposta e male accettata e la cavillosità si sono incanalate tanto capillarmente da rendere ogni essere, ogni cosa, ogni oggetto, strumenti di un determinato piano regolatore predisposto minuziosamente, dalla azienda.
Non si vuole fare una critica prettamente negativa dell’ambiente di fabbrica, ma si ritiene opportuno fare notare una delle piaghe comune a mio parere più profonde, o meglio più dolorose, dell’ambiente in cui si deve lavorare.
Lo stato di cose sopraesposte è uno dei motivi principali per cui l’uomo, essere ragionevole e dotato di intelligenza e anche di amor proprio, può reagire adottando mezzi apparentemente inconcepibili inveendo contro i datori di lavoro, ribellandosi a questo stato opprimente, odiando quasi il lavoro, perdendo così la tranquilla e la serenità personale, stati indispensabili per il miglioramento dell’individuo, per il benessere della famiglia, per il progresso della società.
Sembrerebbe umanamente impossibile che un’assistente sociale potesse svolgere un lavoro proficuo e positivo in un ambiente simile… Invece è possibile e proficuo. Si inizia dall’unico e poco simpatico mezzo a disposizione: « la pratica », « il documento », acquistando così il titolo non soddisfacente di « Signorina che fa i fogli »; poi, c poco a poco, si acquista un pò di fama grazie al risultato positivo ci una semplicissima pratica ed allora il campo si allarga sempre di più ed ecco che « alla signorina che sa fare tutto », vengono fatte le richieste più svariate, vengono posti i problemi più strani, vengono rese note situazioni incredibili; ed ecco che a questo punto si pu° parlare di case-work, di trattamento individuale, poiché l’accostamento comincia ad essere interessante ed a rendersi quasi indispensabile al cliente che comprende (anche se non manifestamente) di avere altri bisogni da soddisfare meno tangibili dei primi, ma non per questo meno intensi o trascurabili.
È 1’ora della visita domiciliare fatta solo se richiesta (anche implicitamente) comunque sempre da fare con molto tatto, delicatezza, per non correre il rischio di essere qualificati (anche ingiustamente) dei « gentili carabinieri ».
Contemporaneamente al lavoro individuale si può preparare il terreno per un proficuo lavoro di gruppo; infatti è necessario per questo chiedere e dare collaborazione alle varie organizzazioni interne (C.R.A.L., Fondo Interno di Assistenza, Commissione Interna), non dimenticando la Direzione stessa, poiché se da « trait — d’unione » si deve fare, è necessario che il ponte abbia sicuri i due estremi per il perfetto e concorde allacciamento. Non si deve trascurare che è necessario tatto molta pazienza e costanza con tutti.
Insomma non si deve mai dimenticare che il compito dell’Assistente di fabbrica consiste nella rieducazione integrale e armoniosa dell’individuo, qualunque esso sia, perciò bisogna comportarsi da vere Assistenti Sociali in ogni contatto, non solamente con il cliente, ma anche con le persone che occasionalmente e abitualmente è dato incontrare nel lavoro: questo è l’unico modo per crearsi un clima favorevole di azione e di conseguenza di collaborazione.
In riferimento ai rapporti fra Dirigenti e Dipendenti, non è facile, in vari casi, convincere ad un trattamento di relazioni umane; non bisogna insistere sul « maggior rendimento » ma nel valore positivo personale in un ambiente sereno tranquillo, dove ognuno sente il dovere come impegno e non come cosa imposta.
Attenzione a non correre il rischio della « burocratizzazione » del lavoro stesso, poiché la pratica è un mezzo di aiuto e non fine del Servizio Sociale!…
L’assistente sociale di fabbrica deve occuparsi di vari campi di attività che si possono sintetizzare in:
1) Nuovi assunti.
2) Infortunio.
3) Malattie.
4) Disadattamento al lavoro.
5) Casi individuali.
6) Opere Sociali.
7) Pratiche di varia natura.
Praticamente l’attuazione totale di questo piano è difficile: sia per la scarsa sensibilità ai problemi sociali da parte dei datori di lavoro e imprenditori, sia per il poco tempo di presenza dell’Assistente Sociale sul luogo di lavoro.
Per ovviare a queste difficoltà si crede opportuno proporre:
Corsi o convegni di aggiornamento per datori di lavoro e dirigenti di aziende sui problemi sociali e relazioni umane;
Aggiornamento frequente per le Assistenti Sociali.
Dispensa dell’Assistente Sociale da tutto il lavoro burocratico, che dovrebbe essere svolto da personale impiegatizio.
Attività dell’Assistente Sociale O.N.A.R.M.O. nel bacino minerario di Liegi, 4, 1959, pp. 2-5.
di Adele Magnaguagno, assistente sociale di Liegi
Come già all’inizio della mia attività in Belgio, anche in questi ultimi cinque mesi ho continuato a raccogliere elementi informativi riguardanti la situazione degli emigranti italiani nel bacino di Liegi, onde poter attuare un piano organico di lavoro assistenziale che sia veramente efficace.
A tale scopo mi sono servita dei seguenti mezzi:
1) colloqui individuali con gli operai durante le ore d’ufficio, che mi hanno permesso di conoscere le difficoltà personali di ciascuno nell’adattamento, nel lavoro, nelle pratiche assicurative;
2) visite domiciliari mediante le quali ho potuto constatare da vicino i problemi che riguardano gli alloggi e le esigenze della vita famigliare;
3) partecipazione a gite e festicciole organizzate dai Padri missionari o da altri organismi italiani, allo scopo di conoscere un maggior numero di connazionali;
4) visite agli ospedali e sanatori per conoscere le maggiori preoccupazioni e necessità dei degenti;
5) partecipazione alle conferenze del Centro di « études et documentatici sociales » per lo aggiornamento sui vari problemi sociali;
6) lettura di bollettini e giornali riportanti notizie sugli emigranti italiani: le loro esigenze, le loro richieste;
7) rapporti con i vari organismi italiani (Consolato, ACLI, Padri missionari, delegati delle Mutue c del Sindacato, CRI, e tutte le persone che per filantropia o per particolari circostanze si interessano degli italiani) ed organismi belgi (in particolare, con: Mutue, Dispensari, medici, infermiere visitatrici, Assistenza Pubblica, Ass. Sociali delle miniere e delle fabbriche, datori di lavoro, Ass. Soc. Charbonnages, O. N. de l’Enfance, Tribunal des enfants, direttori di Istituti, parroci, Istituzioni religiose, Caisse d’Allocation Fa-milial, Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro, Ufficio del Lavoro, Police des étrangers, Centro d’orientamento professionale, Centro di riadattamento professionale, Maison des sans logis, Maison d’accueil, ecc. ecc.).
Dalle rilevazioni fatte, ho potuto fissare i principali problemi che riguardano i nostri emigrati e stabilire un capillare piano d’azione. Premetto che il mio interessamento si rivolge sopratutto agli emigrati che per le più svariate circostanze, si trovano in condizioni di bisogno. Tuttavia se nelle relazioni espongo i casi che presentano maggiori difficoltà, tengo ad informare che gli stessi problemi si presentano più o meno per tutti gli emigranti, e che la maggioranza di tali problemi viene risolta in modo positivo.
Data l’impossibilità di sintetizzare in poche pagine tutta la complessità del lavoro svolto, mi limiterò a dare, in questa relazione, un breve quadro riassuntivo rispecchiante sia alcuni aspetti sociali dell’emigrazione, sia il mio contributo assistenziale per ogni singolo settore di lavoro.
Arrivo degli emigranti
Poiché l’emigrazione dei minatori italiani in Belgio è stata sospesa, la Federchar organizza attualmente solo i convogli per i familiari degli operai già qui residenti. Tali famiglie vengono richieste dai capi-famiglia mediante «atto di richiamo» introdotto presso la Direzione della miniera, con allegato l’attestazione della Polizia dichiarante che l’interessato alloggia in un appartamento sufficientemente vasto e salubre per ospitare le persone a carico. Molto spesso purtroppo, la dichiarazione della Polizia non viene preceduta da alcun sopralluogo, così che si trovano famiglie numerose in un ristretto numero di stanze.
L’anno scorso (1957) sono arrivati a Liegi due convogli:
1) il 7 febbraio con 42 famiglie e 105 bambini.
2) il 27 giugno con 53 famiglie e 142 bambini.
Attività dell’assistente sociale in questo settore
Avvertita dal Consolato no di Liegi, mi sono recala a ciascun arrivo di convogli presso la stazione di Vivegnis. Ho potuto così:
1) Assistere la famiglia in arrivo, in collaborazione con i delegati e le assistenti sociali delle miniere, affinchè la discesa dal treno avvenisse senza incidente alcuno;
2) procurare che i bagagli non andassero smarriti;
3) affidare le mogli e i bambini. in caso di assenza del capofamiglia. al delegato della miniera interessata;
4) vigilare affinché ogni famiglia trovasse posto, con i propri bagagli, nei camion appositamente messi a disposizione da ciascuna miniera;
5) conferire con l’infermiera vigilatrice del convoglio per eventuali casi di malattia o di gestazione avanzata.
Alloggi
Ebbi già occasione di esporre alcune osservazioni sulla questione degli alloggi. Su tale questione aggiungo ora le ultime informazioni: il Sindaco del Comune di Ans ha emesso, nel mese di giugno, un decreto per la distruzione delle baracche dei campi di Ans, Ans – Rocourt e Vivegnis dichiarandone l’inabitabilità. Alle famiglie che dovranno evacuare i campi, saranno assegnate le nuove case comunali che 6Ì prevedono pronte per i mesi di settembre e ottobre.
Riporto qui di seguito le statistiche dei suddetti campi:
Campo di Ans:
famiglie senza figli 2
» con 1 figlio 7
» » 2 figli 10
» » 3 » 14
» » 4 » 5
» » 5 » 3
Totale: 41
Campo di Ans – Recourt:
famiglie con 1 figlio 10
» » 2 » 10
» » 3 » 10
» » 4 » 7
» » 5 » 1
» » 6 » 1
» » 7 » 1
Totale: 40
Campo di Vivegnis:
famiglie con 3 figli 3
» » 3 » 2
» » 5 » 2
Totale: 7
Numero complessivo delle famiglie: 88.
Attività dell’assistente sociale in questo settore
In questi ultimi mesi ho cercato di seguire i propositi fatti precedentemente, svolgendo opera di educazione e di convinzione presso le famiglie collaborando con le assistenti sociali della Soc. An. Maison Bon Marche, appoggiando le domande presso i Comuni, intervenendo presso i proprietari di immobili.
Inoltre, con l’assistente sociale del Consolato, mi sono recata presso il Campo Ste Barbe di Ans ed ho distribuito, famiglia per famiglia, il decreto di inabitabilità tradotto in italiano. In questa occasione ho potuto ancora una volta informare i connazionali sulle formalità da svolgere per ottenere la concessione di un nuovo appartamento e parlare con loro su di alcune difficoltà di carattere individuale e pratico che si presentano in questa particolare circostanza, cercandone insieme la soluzione.
Per i casi singoli che si trovano provvisoriamente senza alloggio e senza mezzi (per es.: ammalati usciti dall’ospedale ed in attesa di lavoro; turisti: licenziati in attesa di sistemazione ecc.) mi sono rivolta alla « Maison des sans logis » ed al « Centre d’acceul » dove, per un periodo temporaneo, ogni persona di qualsiasi nazionalità può godere gratuitamente di vitto e alloggio.
Inadattabilità
La questione ambientamento presenta la maggiore difficoltà di esposizione, sia perchè le ragioni di inadattabilità variano secondo le circostanze e la formazione personale di ciascuno, sia perchè le cause stesse si riallacciano e si confondono con molteplici altri problemi che influiscono solo in maniera indiretta sull’emigrante.
Espongo quindi solo alcune osservazioni, mentre mi riservo di ritornare sull’argomento nelle prossime relazioni.
L’emigrante italiano, spinto dalla necessità lontano dalla Patria, rimane col pensiero e col cuore costantemente rivolto alla sua terra; già dal suo arrivo in Belgio egli non sogna che di ritornare in Italia e l’unico proposito comune è quello di sgranellare sufficientemente denaro per comperare la casa ed il campo nel luogo di origine. Convinto quindi di non restare in Belgio per sempre, non rinuncia né alle proprie abitudini né alle tradizioni e ciò gli impedisce, di conseguenza, di conformarsi alla vita del paese che lo ospita.
Inoltre, poiché la maggioranza degli emigranti partono da piccoli paesi di campagna fio ve vi è spesso miseria e preoccupazione e dove tutto trascorre con semplicità e monotonia, è naturale che in un ambiente così diverso dal loro, si trovino, specialmente nei primi tempi, un po’ disorientati. Tale senso di disagio si ripercuote sul loro comportamento cosi che si cicalio situazione difficili soprattutto se il senso di disagio degenera in uno squilibrio psicologico.
Altre cause dell’inadattabilità possono ricercarsi, oltre che nella mancata formazione personale di ciascuno: nel clima, nella differenza di lingua, di mentalità, di carattere, di principi, di usi e costumi.
Attività dell’assistente sociale in questo settore
Il problema dell’adattamento e dell’assimilazione è un problema generale che non può essere risolto dalla sola azione dell’assistente sociale, poiché richiede misure e mezzi più vasti, superiori alle sue possibilità. Comunque ho fatto del mio meglio per assistere i singoli ca6i di disagio psichico o ambientale, aiutandomi sia col metodo del Case-work, sia con l’utilizzazione di tutti i mezzi che sono presentati utili in ciascuna occasione.
1) Sono intervenuta presso gli Organi ed Enti responsabili per fare presenti situazioni di particolare disagio sia individuale che collettivo (per es.: ho informato Istituti ed Ospedali sulle abitudini alimentari dei connazionali, collaborato con direttori o assistenti sociali delle nuove case per la sistemazione e l’adattamento delle famiglie; intervenuta presso l’Assistenza Pubblica per il ricovero di bambini, per il pagamento di retto ospedaliere, per In concessione di sussidi ecc.);
2) ho indirizzato gli assistiti verso gli Enti competenti nella soluzione dei loro bisogni;
3) ho cercato di alleviare lo stato di ansia e di malinconia, caratteristico nella donna emigrata, diminuendo i suoi timori, infondendo fiducia, suggerendo soluzioni pratiche per la casa, consigli per i figli, per i suoi rapporti con i vicini e con i familiari;
4) ho cercato di equilibrare convinzioni errate o pregiudizi che possono aumentare le difficoltà di adattamento.
Ho in programma per i prossimi mesi, in collaborazione dell’assistente sociale del Consolato e della « Maison à Bon Marche », una permanenza settimanale presso la Cité « Campagne des Monts » à Herstal, per approfondire lo studio su tale situazione, raccogliere altri elementi e trovare nuove soluzioni.
Lavoro
L’insieme della mano d’opera italiana, oltre che nel settore più importante di produzione del Paese che è quello carbonifero, viene assorbita nelle cave di pietra e nelle grandi industrie metallurgiche. L’impiego negli altri settori (edilizia, artigianato, commercio, agricoltura e domestici) è quasi insignificante.
Nelle miniere, secondo le rilevazioni fatte dalla Federchar nei 28 pozzi esistenti nel Bacino di Liegi appartenenti alle 17 Società carbonifere, trovano impiego 9899 italiani, circa 1/5 della popolazione totale.
Per questi operai l’emigrazione significa speranza di un avvenire migliore. Come ho detto essi sono pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà ed ogni disagio pur di raggiungere in pochi anni il loro scopo: tornare in Italia con la possibilità di offrire alla famiglia una vita tranquilla, piccole comodità e qualche svago.
Per realizzare questo legittimo desiderio l’operaio italiano sottopone il fisico ad uno sforzo eccessivo pur di guadagni molto, mentre, per risparmiare non si nutre a sufficienza. Questi errori facilitano l’opera dannosa delle polveri e dei gas che si trovano, in abbondanza nelle gallerie e nelle taglie di carbone, finché fatalmente l’organismo viene colpito dall’ulcera, dalia silicosi, dalla pneumoconiosi e dalla tubercolosi.
Quando un minatore non ha più la capacità lavorativa del 100%, viene riformato dal fondo, o dal fondo e superficie secondo il grado di invalidità, e giudicato abile per i lavori leggeri. Naturalmente i lavori leggeri vengono affidati di preferenza ai belgi ed ecco quindi, le conseguenze per gli italiani:
1) difficoltà di trovare lavoro;
2) i salari fuori delle miniere e delle grosse industrie non sono molto alti, cosicché nel lavoratore abituato a guadagnare molto si crea uno stato di insoddisfazione;
3) quando un operaio si animala, viene per alcuni m assistito dalla mutua; in questo periodo di forzato riposo la Ionia si indebolisce per cui, momento di riprendere il lavoro, lo sforzo per riadattarsi nuova realtà, diventa maggiore.
Si forma quindi lentamente, una specie di « psicosi di malattia » nella mente del lavoratore che afferma: « Non posso più lavorare perché sono ammalato » e riferisce vivere stentatamente e girovagare tutto il giorno piuttosto che riprendere il lavoro. Analogo problema di lavoro si prospetta anche per i fortunati che resistono cinque anni in miniera senza ammalarsi e che, in possesso del permesso A, potrebbero impiegarsi altrove (il permesso A autorizza, dopo cinque anni di lavoro, l’impiego in qualsiasi altro settore). Infatti:
1) i minatori hanno diritto alla casa, proprietà della miniera che viene affidata a un prezzo minimo; a quintali 4 di carbone gratuito ogni mese e ad un certo numero di biglietti ferroviari. Tutti questi vantaggi permettono un certo margine nel bilancio familiare che invoglia il lavoratore a resistere alle fatiche del duro lavoro anche quando le condizioni di salute non lo permetterebbero;
2) molto spesso il lavoratore contrae dei debiti per l’arredamento della casa o per l’acquisto di un immobile. La paura di potere pagare le cambiali lo a esistere dall’impiegarsi in ai-settori dove i salari ed i vaneggi sono inferiori;
3) vi sono dei casi in cui il lavoratore non ha obblighi finanziari ma è abituato ad un tenore di vita a cui non sa più rinunciare. Per mantenere tale tenore di vita è quindi costretto a lavorare in miniera, dove il salario è più alto.
Attività dell’assistente sociale nel settore lavoro
Anche il problema del lavoro, come quello dell’adattamento, richiede mezzi e misure che competono più agli organi legislativi e governativi che all’assistente sociale. Tuttavia, nelle trattazioni dei casi individuali, non ho trascurato di interessarmi anche di tale problema, svolgendo sopratutto un’opera educativa preventiva contro le difficoltà che l’operaio può incontrare nell’avvenire se non si attiene a determinate regole di lavoro, di riposo e di alimentazione. Per completare l’opera educativa, con un aiuto positivo, ho segnalato all’Ufficio del Lavoro i nominativi di invalidi, scegliendo sopratutto i casi sociali in cui la modifica dell’ambiente può essere un elemento essenziale per la soluzione del caso; ho stretto rapporti con i datori di lavoro di piccole fabbriche; ho sollecitato e appoggiato le domande di permesso di lavoro presso il Ministero del Lavoro; ho aiutato connazionali e datori di lavoro nelle pratiche da svolgersi; ho infine sfruttato ogni occasione per dare le informazioni a riguardo. Al fine di rendermi personalmente conto di dove e come lavorano i nostri operai, spero nei prossimi mesi di potere visitare il fondo di una miniera e qualcuna delle grosse fabbriche.
Quanto ho esposto in questa relazione è frutto di attenta osservazione e di esperienza, ma temo che non rispecchia naturalmente il quadro completo dell’assistenza in tutti i suoi settori. Il problema delle madri, delle nubili, dei bimbi, dei vecchi, dei malati, delle vedove, degli scapoli sono altrettanti centri di interesse a cui mira la mia attività. Di questi come di ogni altra questione che potrà delinearsi in avvenire e interessare il problema dell’emigrazione italiana in Belgio, mi riprometto di esporre le mie impressioni nei prossimi mesi.
Ferdinando Baldelli e il suo lavoro sociale, 7, 1959, pp. 2-5.
di Virginia Delmati
Monsignor Baldelli nato a Pergola, il 4 settembre 1886 da famiglia di cittadini positivi e fortemente radicati nei principi e nella pratica cattolica allora molto rara.
Perduta nella infanzia la mamma, seguendo una precoce vocazione entrò nel Seminario di Urbino. Ricevette la Sacra Ordinazione il 25 luglio 1909.
I suoi primi anni di sacerdozio furono spesi nel Sacro Ministero Parrocchiale come Cappellano di S. Francesco, servizio il più adatto ad esercitarlo nella multiforme attività pastorale.
Organizzò nella sua città anche il partito popolare insieme all’On.le Bertini.
Inizio del suo apostolato sociale 1921
Nel 1921 chiamato da S. Eminenza il Cardinal Gaetano De Lai, Mons. Baldelli veniva a Roma in qualità di Ufficiale della Sacra Congregazione Concistoriale, addetto alla Assistenza Religiosa degli emigranti. Da questo momento comincia il suo apostolato con il quale la sua vita si identificherà completamente, in una progressiva attività sociale.
Già da allora occupa il tempo libero prestandosi nell’« Italica Gens » Ente privato di assistenza all’emigrazione presieduto dal Senatore Schiapparelli.
Per incarico della Sacra Congregazione è inviato, nel 1922, per sei mesi, a New York allo scopo di studiarvi presso l’Archidiocesi la situazione religiosa degli Immigrati Italiani, per l’assistenza dei quali il Cardinale Arcivescovo di quella città aveva di recente istituito « l’Italian Auxiiliary».
Comitato romano pro emigranti 1923
Come risultato dell’ampliate esperienze, tornato a Roma, Mons. Baldelli fonda la sua prima opera il « Comitato Romano Pro Emigranti », cui chiama a collaborare eminenti persone della società romana, della diplomazia e dell’Azione
Cattolica, offrendo loro, nella casa dell’Emigrante, a P.za S. Maria Maggiore, 6, ospitalità consulenza e sostegno morale al momento del passaggio da Roma per l’espatrio.
Fondazione dell’O.N.A.R.M.O. 1926
Bloccata l’emigrazione, e sostituita da spostamenti di masse migratorie nell’interno del paese, mons. Baldelli segue i movimenti dei lavoratori che affluiscono da ogni provincia a Roma ingaggiati dalle nuove industrie della capitale, e promuove per loro, presso le aziende assuntrici, sistemazioni di vita dignitose. Accetta la responsabilità di assumerne la gestione realizzata in impianti residenziali nuovi del tutto per 1 Italia Centrale e Meridionale, attrezzati con decoro e comodità: i convittioperai maschili e femminili, i refettori, le mense, i locali culturali, le scuole e le biblioteche di fabbrica, le cappelle, i campi sportivi, nidi ed asili per i figli degli operai, nell’ambito stesso degli stabilimenti.
In tale attività Mons. Baldelli si fa aiutare da alcuni sacerdoti, i « Cappellani del Lavoro » o di Fabbrica, mentre trasforma il « Comitato Romano Pro Emigranti » nell’« Opera Assistenza Religiosa e Morale Operai », confortato in ciò da S. Eminenza De Lai (lettere da Magliano Sabino il 23 luglio 26 e 28 agosto 1926). Lo schema essenziale di Assistenza nelle Fabbriche, data da allora; e, benché continuatamente aggiornato, esso rimane fondamentale per 1’O.N.A.R.M.O., operante nonostante i diversi avvicendamenti politici, anche oggi, con i suoi sac doti, in molte fabbriche da allora.
Sviluppo dell’opera 1926 – 1940
Dal 1926 Mons. Baldelli sviluppa le sue iniziative estendendo l’Opera ai complessi industriali più importanti d’Italia: la Viscosa, le Cotoniere Meridionali, le Miniere di Carbonia, quelle dell’Ansa, la Fiat, l’Italgas; a Palermo, a Bari, Lecce, Fiume, Pola, Trieste, Monfalcone, Genova, Milano, Lucca ed infine in Albania dietro i cantieri di lavoro italiani.
In questo periodo di intensa evangelizzazione delle masse operaie, in occasione del Giubileo del 1933, Mons. Baldelli organizza una prima adunata di lavoratori a Roma.
Comincia in tal modo a delinearsi la caratteristica operativa delle sue iniziative a largo raggio, in cui tutti i dettagli sono minuziosamente previsti, perché identificati come bisogni umani; metodo a cui lo porta una visione concreta dell’ampiezza dei problemi che si ripetono sino ad estendersi ad intere categorie, considerati nel singolo individuo.
Da tale visione, maturata in lui con lo sviluppare incessante della sua opera ha anche origine il sorgere e l’affermarsi sempre più potente in lui del senso di responsabilità sociale, allargato a quelli per i quali avverte il dovere, ed a cui ha il coraggio di giovare, in qualche modo perché lì vede il loro bisogno: anche se sono molti, anzi moltissimi.
Comincia cioè a sentirsi sempre più responsabile di tutto e di tutti.
Parimenti in questo periodo, nel dicembre del 1939 Mons. Baldelli inaugura a Bologna il Seminario di Santa Cristina, per la formazione dei Cappellani del Lavoro suoi collaboratori principali.
La guerra
La guerra trova Mons. Baldelli appena nominato Direttore Generale dell’ONARMO « ad triennium » (lettera della Sacra Congregazione Concistoriale 16 aprile 1940 n. 220/40 di protocollo), quasi la Chiesa volesse confortarlo nel suo avanzare nella vocazione di lavoratore sociale, sempre più decisamente.
Al principio della guerra egli inizia l’attività assistenziale di emergenza dai lavoratori richiamati occupandosi di loro nelle fabbriche ormai militarizzate, e delle famiglie dopo la loro partenza per il fronte.
Nel momento cruciale della Pentecoste, il 23 giugno 1943, alla vigilia dei tremendi eventi di quei giorni, Monsignore chiama una seconda volta a raccolta i lavoratori, al cui apostolato si dedica da 20 anni ed organizza la memorabile Udienza pontificia del cortile della Pigna, che radunò circa 27.000 lavoratori di ogni tendenza, provenienti da ogni regione d’Italia, intorno al Santo Padre, a riceverne il prezioso viatico.
Seguirono le organizzazioni di sostegno e di difesa dell’emergenza, durante la quale tutte le risorse affidate a Mons. Baldelli dalle molte aziende ove aveva svolto sino ad allora il suo apostolato, furono da lui utilizzate, nel nome del Santo Padre per il popolo che soffriva in molti modi; ed impiegate destramente nel settore dell’alimentazione, dei trasporti, degli aiuti alle città bombardate, ai sinistrati, agli 800.000 profughi rifugiati a Roma, agli ammalati, ai perseguitati, agli Ordini Religiosi, agli Istituti di ricovero, ospitalieri, pediatrici, ai sanatori etc.
La gestione di mense aziendali e popolari raggiunse l’acme di 540.000 pasti mensili.
Mons. Baldelli curò di persona durante l’occupazione e la prima liberazione, per incarico del Santo Padre, la riunione di famiglie separate incidentalmente fra cui i « figli degli Italiani all’estero » ; organizzò l’unico treno per il prelievo ed il trasporto dei prigionieri malati, allestì molti comandi di tappa per l’accoglimento dei reduci alla frontiera e nelle città di origine, prestò assistenza ai carcerati di diverso colore politico e curò persino il rifornimento della biancheria mancante ormai quasi del tutto, negli ospedali, nei sanatori, e nei brefotrofi.
Come collaboratori Monsignore scelse non solo i religiosi di molti ordini, che volontariamente, si posero al suo fianco, ma anche i lavoratori delle fabbriche assistite nell’ante-guerra che, nel novembre del 1943, si riunirono intorno a lui nella « Associazione Nazionale Lavoratori Cattolici »; ed infine le Assistenti Sociali diplomate.
Fondazione della P.O.A. 1944
Nel gennaio del 1944, per incarico del Santo Padre Pio XII, Mons. Baldelli istituì la « Pontificia Commissione Profughi » ricevendone dall’obbedienza la presidenza.
La nuova Istituzione rese più facile il rapporto tra Mons. Baldelli ed i rappresentanti della C.N.W.C. venuti in Italia al seguito della liberazione. Da questo momento Mons. Baldelli darà due indirizzi contemporaneamente alle sue attività sociali: l’uno di continuazione dell’O.N.A.R.M.O., opera specializzata nell’assistenza ai lavoratori, l’altro alla « Pontificia Commissione Profughi » divenuta « Pontificia Commissione Assistenza » e consolidata in « Pontificia Opera di Assistenza ».
La pontificia (dal 1944 ad oggi)
Assestamento Giuridico. La Commissione Profughi organo operativo, « de facto », di natura contingentale sviluppa ben presto nella « Commissione Pontificia Assistenza ».
Nel 1953 Mons. richiede ed ottiene la elezione giuridica della Pontificia Opera di Assistenza con Statuti approvati dalla Santa Sede, che la inseriscono ufficialmente nel diritto ecclesiastico.
Sviluppo Sociale. Pur mantenendo sempre la attrezzatura della P.O.A. in condizioni di prestare larghe attività di soccorso in qualsiasi momento di emergenza sociale, (1947 cessione di un bastimento di frumento all’Italia; 1951 e 1952 soccorsi alle popolazioni del Polesine e della Calabria in occasione dell’inondazione, 1953 – 1954 aiuti all’Olanda, Belgio, Austria, Salerno; 1953 intervento per il terremoto della Grecia,, 1955 spedizione in Ungheria), Mons. Baldelli organizza saldamente la sua opera sull’antico schema cristiano della carità : pauperes, juvenes, aegroti, migrantes, et in carcere positi; ossia articola la POA in servizi a base individuale : assistenza ai singoli, gioventù (Colonie), servizio sanitario, emigrazione, detenuti.
La importanza di tali servizi, perfezionati giorno per giorno, trovando anche giorno per giorno i mezzi adeguati, risulta dalla portata degli aiuti che essi concretizzarono, calcolati in termini statistici, economici, di quantità e valore dei materiali impiegati, e dal numero delle persone assistite, come da quello dei collaboratori volontari o assunti regolarmente in un organico fisso; sempre lasciando al Signor della portata spirituale.
Tale indirizzo di forme individualizzate di assistenza, è stato gradatamente da Mons.Baldelli allargato a sfere più larghe; come ad esempio alle categorie socialmente interessanti e non ancora sufficientemente integrate in un progresso spirituale e religioso adeguato a quello sociale della Nazione (Pie Unioni dei Pastori, Pescatori, Braccianti, Coltivatori). Mons. Baldelli cioè allarga la sua attività assistenziale educativa a queste categorie non ancora sufficientemente promosse sul piano sociale e spirituale.
Egli si rivolge poi a considerare lo sforzo di moltissime comunità periferiche o rurali, nella trasformazione delle strutture sociali, che avvengono quasi prima dell’adattamento della persona umana all’economia nuova.
Per aiutarle Monsignore istituisce i Centri Sociali oggi circa 3.000, per la promozione comunitaria delle popolazioni, affidati ad assistenti sociali, medici, maestri assistenti sanitarie ed alla collaborazione dei cittadini.
Il nuovo movimento delle « Relazioni Umane » attira l’attenzione di Mons. Baldelli che forma i Centri di Relazioni Umane a Dobbiaco, Quercianella, ed a Roma, inserendone le specifiche tecniche nel suo lavoro.
Le colonie di vacanza si specializzano in diurne, estive, e permanenti e si differenziano per Poliomielitici, cardiaci ed artritici. Sorge il Diabetario dei bambini unico in Europa.
Sempre più deciso l’indirizzo di specializzazione della mano d’opera si riflette nella P.O.A. con l’istituzione dell ‘Ente Nazionale Addestramento Professionale (ENAP) per promuovere il sorgere dei centri professionali, con lo scopo di incanalare la gioventù ad una vita più sicura (attualmente 48).
Dalla Comunità Nazionale Monsignore secondo lo Spirito della Chiesa, tende ad estendere la sua attività nella Comunità supernazionale muove il coordinamento delle « Caritas » in 43 paesi, nella « Cantas Intemazionale », i cui Statuti sono approvati dalla Chiesa e viene eletto presidente.
Una delle iniziative della Caritas Internazionalis e della P.O.A. è la Scuola Internazionale di Servizio Sociale per indigene dell’Africa e dell’Estremo Oriente.
Con il medesimo spirito Mons. caldeggia il sorgere del Movimento Internazionale della Lampada della Fraternità per la custodia delle tombe dei caduti su tutti i fronti, esteso a 25 nazioni.
O.N.A.R.M.O. (dal 1944 ad oggi)
Personale specializzato. Quanto all’ONARMO Mons. Baldelli cerca dopo la guerra, di tecnicizzare al massimo l’Opera, introducendovi, nel 1945, l’attività di Assistenti Sociali diplomate in coordinamento a quella dei Cappellani del Lavoro e delle Assistenti Sanitarie.
Istituisce perciò nel 1945 la prima scuola Superiore di Assistenza Sociale, iniziativa attualmente moltiplicata per 22 scuole di S. S. nelle diverse provincie.
Le Assistenti Sociali si uniscono sin dal ’45 nella loro Associazione AIASO.
Anche i Cappellani del Lavoro ricevono nel 1951 un loro Centro di studi sociali, presso il Seminario S. Cristina di Bologna.
Nel 1956 Monsignore istituisce a Roma la Scuola ONARMO per Assistenti Sanitarie, e Tanno seguente la inizia a Pisa.
Servizi. Ricominciata l’emigrazione nel 1946 Monsignore istituisce il Servizio Sociale agli Emigrati italiani in Belgio a Charleroi, Liegi, Mons; nel 1955 lo attua in Germania, nel 1957 nel Lussemburgo, nel 1958 in Francia ed in Tunisia.
L’assistenza Sanitaria ai lavoratori aziendali viene prestata dall’ONARMO nel Policlinico del Lavoro a Roma fin dal 1945.
Nel 1948, il 9 marzo si ottiene dal Ministero del Lavoro il riconoscimento del Patronato Assistenza ONARMO, Istituto che attua legalmente ogni prestazione previdenziale dell’Opera.
Nel 1949 si articola il Servizio Sociale ai Ferrovieri, ai Cantieri Rimboschimento in collaborazione con il Ministero del Lavoro e la Cassa del Mezzogiorno.
Anche in quest’anno s’iniziano le Scuole Popolari e di Avviamento Professionali, ed i Corsi di riqualificazione Professionale in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e del Lavoro.
La Casa dello Studente a Roma ed in altre città d’Italia è gestita dall’ONARMO.
Nel 1952 Monsignore organizza in larga scala per mezzo di un servizio rurale specializzato, l’assistenza a varie categorie dell’agricoltura, ed in particolare alle Mondariso, e subito dopo alle Raccoglitrici di olive e di uva.
Infine nel 1956, con lettera del 26 marzo della Sacra Congregazione Concistoriale (n° 266/56) Mons. Baldelli viene confermato nell’ufficio di Direttore Generale dell’Onarmo « ad nutum Sanctae Sedis ».
La documentazione di questa attività è normalmente affidata ad un organo di stampa per ognuno dei servizi : attualmente undici periodici.
Tutto questo lavoro, successivamente realizzato non è stato mai interrotto da soluzioni di attività nei trentasei anni del suo svolgersi.
Si può dire che nessuna delle iniziative O.N.A. R.M.O. e P.O.A. si sia esaurita ossia rimasta inerte. Tali risultati, se debbono attribuirsi a sagace impiego di forze spirituali, sociali, economiche, volontarie e retribuite, convergenti insieme sono però una testimonianza evidente di Grazia e di Provvidenza Divina, oltre ché dell’impegno di un’intera vita.
Dati statìstici del « Comitato Romano pro Emigranti »
Il Comitato aveva 70 letti ed ospitava 200 commensali. In sei anni ha distribuito 649.313 razioni ed ha accolto 46.000 emigranti.
anno 1923 12425
anno 1924 11636
anno 1925 11236
anno 1926 10763
Totale: 46060
Relazione del 1927
«I nostri uffici son quanto di più dinamico si possa immaginare in materia burocratica; tedio, sonnolenza, convenzione, esulano assolutamente da essi. Tranne l’ufficio di ragioneria intenzionalmente mantenuto calmo e sgombro di pubblico, quello del direttore e la segreteria sono in continua attività. Ogni giorno si ricevono sequele di persone. La nostra anticamera è il luogo di raduno di ogni bisogno e di ogni necessità anche molto distanti dagli scopi dell’Opera. Qualcuno si ostina ad inserirvisi forzatamente ma qui c’è la buona consuetudine di non respingere nessuno e di dare un po’ di orientamento a chi ricorre a noi, per lo meno indicandogli l’istituzione o persona che fa per lui e dirigendovelo con una lettera. Sicché il servizio notizie e quello raccomandazioni sono i più sviluppati ed importano una quantità di corrispondenza giornaliera.
C’è poi il servizio produzione di documenti che pure esso è a gettito continuo perchè ininterrottamente ne richiediamo per chi non è capace di farlo da sé, o per chi ce ne prega: atti di nascita e certificati penali.
Alcune volte scopriamo molti segreti; ne usiamo con discrezione ma non li trascuriamo. Abbiamo così avuto occasione di far concludere matrimoni tardivi e riconoscimenti di figli naturali.
Il servizio di produzione documenti agisce assai anche per la preparazione degli incartamenti necessari ai ricoveri di fanciulli, vecchi e ragazzi presso i vari enti competenti.
Prestiamo poi questo servizio in particolar modo per gli emigranti e gli immigranti, le due categorie per cui il Comitato lavora ancora e mantiene normali relazioni con gli uffici del lavoro in Italia, con gli uffici dell’italica Gens, all’estero, e con l’Italia Auxiliary di New York che fa parte della nostra istituzione.
Vi è inoltre un ufficio di statistica e coordinamento delle nostre attività giornaliere ed annuali. Ogni sera, tornando dal proprio lavoro, i membri del Comitato si riuniscono in un incontro fruttuoso.
Asilo di mendicità — Viale Aventino 44
Ai piedi di uno dei più suggestivi colli di Roma, l’Aventino, ha sede provvisoria l’Asilo di mendicità, gestito dalla Congregazione di Carità ed il Governatorato di Roma.
Il suo carattere transitorio è la cagione principale della grande modestia dei locali, i quali però son residenza più che gradita alla povera umanità che raccolgono: 120 mendicanti. Son tutti vecchi, tutti stanchi, quasi tutti vinti nella vita; vengono da chissà quali vicende di miseria e di abbrutimento, e ne portano i segni impressi nei volti; quei volti quasi in nessun normali, ma paonazzi, ingrossati, o travolti dalla consuetudine della sofferenza, e quasi inebetiti dallo stordimento. Poveri esseri che la società respinge da sè: padri cui le porte dei figli rimangono chiuse; o a cui i figli, realmente affogati dalla miseria, non riescono a provvedere; capi di famiglia rimasti soli all’età che nei migliori vien circondata per lo più di venerazione e di agio. Per costoro sarebbe di vituperio senza la carità fraterna cui non ripugnano, e che viene loro incontro per rendere meno tetro il crepuscolo della vita. Nell’ultima parte del pellegrinaggio li inclina a riconciliarsi con gli uomini almeno pe rla loro tardiva pietà ed a riconciliarsi con Dio che solo può ispirarla.
Chi viene da una vita di disgrazie lo conosce provvidente, chi viene da miserie colpevoli Lo trova misericordioso.
L’asilo che strappa gli infelici alle asprezze della strada i letti puliti, la tavola frugale ma sana sono qui gli elementi fonda-mentali della nostra assistenza. Vi si aggiungono, come pane dell’anima, le pratiche della fede che circondano questa vecchiaia miserabile di una atmosfera di serenità.
La casa si compone di due grandi camerate per il dormitorio, con relativi stanzini di pulizia e per il barbiere che vi esercita la sua professione su tutti i ricoverati una volta la settimana; dei bagni, la cui frequenza è sistematica ed obbligatoria; e di un vasto refettorio a tavole di marmo con annessa cucina.
Vi è una piccola costruzione per l’alloggio del direttore e la direzione ed un’altra per le signorin del guardaroba ed il guardaroba.
Il direttore è assistito da un sacerdote, 4 inservienti per le pulizie, due signorine.
Il ricovero funziona ora solo da dormitorio e luogo dei pasti in comune. Un orario regola la giornata in base ad essi e disciplina la libertà: colazione alle sette, pranzo alle dodici, cena alle sei e mezza; dopo la cena nessuno può uscire di nuovo. Le ore libere sono quasi tutte dedicate dai vecchi inabili al lavoro alla passeggiata tanto faticosa ma pure indispensabile alla loro salute. I più validi vanno a lavorare.
Cucina di fabbrica della Peroni
« La cucina economica di imponenti dimensioni, animata dall’attività mirabile di cinque suore; comincia a funzionare alle nove del mattino per trovarsi alle undici e trenta in grado di servire i primi pasti. Montagne di legumi da mondare, enormi marmitte di sughi in ebollizione, cumuli di ritagli utili e di ossa spugnose per i brodi, comunicano immediatamente il numero dei commensali. E quando al fischio della sirena, nell’ora torrida lo stabilimento è nella massima efficienza, nella stagione calda, essi invadono le scale che conducono alle cucine ed ai refettori e si assiepano agli sportelli. Le Suore accaldate dall’ora e dai fuochi potenti fanno miracoli di buona volontà per servirli sollecitamente, a destra le donne, a sinistra gli uomini. Le più impazienti sono naturalmente le donne, che bisticciano fra loro per ogni piccolo incidente nato nella ressa e non si assoggettano facilmente all’ordine se non quando, ricevuto o meglio conquistato il loro piatto fumante, se ne ritornano al loro posto. Allora si seggono alle tavole lunghe del loro refettorio, sulle panche ugualmente lunghe e rimangono tranquille. Sono poche le ragazze; quasi tutte sono maritate; lasciano i loro figli a donne del vicinato, compensandole per il disturbo con piccole somme, qualche volta eccessive per le loro tasche. Se vi fermate con loro, vi raccontano le cose della loro famiglia, storie quasi tutte dolorose, perchè una donna sposata, anche se povera non lascia la casa senza penosa necessita: vi parlano dei loro mariti o disoccupati o beoni, o abbrutiti: delle loro figlie tisiche, fiori di grazia consumate dal terribile male. Ce n’è una che ha il padre ed il fratello ciechi e lei, che ha un figlio, ed ha anche lei gli occhi minacciati, è il sostegno di tutti compresa sua madre. Ce n è un’altra che è gobba; e deve mantenere padre e madre; il padre si ubriaca e non vuole lavorare; e le sue gracili spalle deformi debbono nutrire il suo ozio ributtante. Un’altra occupa in fabbrica il posto del padre che vi morì per un infortunio. Una ha in prigione il marito. Due o tre ne sono abbandonate con i figli e la miseria.
Nell’altro refettorio riservato agli uomini, vi è più silenzio perchè forse minori sono le miserie da raccontare. Quando il capo di famiglia lavora ogni povertà è meno crudele. Vi sono anche la i tipi curiosi. C’è un povero uomo tutto peli rossicci e solchi nerastri e due occhietti acuti, trasandato nel vestire, che tiene a ripetere continuamente che egli è fratello della buona morte in Verano ed enumera le processioni innumerevoli cui ufficialmente interviene.
C’è un Veneto tutto compito, come il dialetto, pieno di « x » e di « z » dolci, che pronunzia in punta di labbra. C’è un pensionato a cui la ditta offre il pranzo. C’è un padre che porta il suo ragazzo, operaio anche lui, a mangiare con sè; mangiano dalle donne perchè operaia anche la madre; e lo guardano affettuosamente seduto tra di loro. Ci sono tipi burberi e tipi gioviali, vecchi adusti e giovani vigorosi e son molti perchè il loro numero ascende nella stagione buona, a cinquecento e più.
Bianco e nero (ricordi di un’A.S. di fabbrica), 7, 1959, pp. 8-9.
L’A.S. della Romana Gas
È una mattina di maggio luminosa e tepida; e, benché siano solo le otto, già l’aria è gloriosa di sole; l’officina Gas ne è tutta inondata, dalle cilindriche moli enormi dei gazometri, potenti colossi quasi in riposo, alle sagome eleganti e ferrigne delle batterie attive, due delle quali emananti colonne violente di vapori. Sui mucchi altissimi di carbone minerale il sole scintilla, e scende lieve come una carezza sopra gli immensi depositi di cok, là dove non è impedito dalle ombre, ancora umide, delle strutture edilizie. I carro-ponti, così decorativi, nel cielo terso ed azzurro, si muovono lenti, con il loro regolare rumore di ingranaggi di ferro; dalle gru le benne scendono piano, si aprono e, cigolanti, risalgono continuamente. Il lavoro, nei suoi aspetti più grandiosi, quelli che, per la loro importanza, e complessità, non si interrompono mai, è in pieno sviluppo. Lo animano i piccoli uomini, vestiti di tela turchina, sempre la stessa in tutte le stagioni, divisa di tutti, dirigenti ed operai. La sottile, quasi impalpabile polvere di carbone, diffusa abbondantemente su tutte le cose, oggi sembra vinta dalla chiarezza dell’aria. Sui viali battuti di asfalto dell’officina, oggi hanno, dappertutto, versato una ghiaia sottilissima e quella rena color ruggine del Tevere, indice di visite straordinarie; hanno aperto il cancello grande, quello per il quale si avvia, giornalmente, l’enorme traffico dei trasporti che, oggi, domenica, sosta. Nello spiazzale su cui esso si apre, dove c’è la pesa per i rustici carri enormi, per gli autocarri ferruginosi, per gli autotreni immani, verniciati di nuovo, oggi c’è il parco delle macchine eleganti.
Gli operai sono già arrivati in comitive vivaci e numerose, con le loro famiglie, in abiti di festa, loro ed i loro bambini; anche i piccoli, anche i lattanti che non restan mai dimenticati dal buon popolo romano nelle case. Molti sono già entrati ed han già preso posto nel grande locale ove avverrà la cerimonia. Hanno trasformato il magazzino immenso, occupato abitualmente dal materiale più ingombrante del mondo: enormi pezzi di macchine, pezzi di ghisa, rottami di ferro ed involucri di ogni sorta e proporzione, per metri e metri quadrati, dall’alta, triplice soglia al fondo oscuro; con due ballatoi ai due lati lungo le pareti di profondità; l’hanno parato interamente di cremisi, di damaschi, di velluti a cimosa dorata.
La dolce Madonna ottocentesca, s’innalza sull’altare ben elevato, di stile del cinquecento. La polvere nera oggi è bandita sin dal pavimento, ove si stendono tappeti rossi e guide che smorzeranno il rumore delle sedie e delle panche, allineate su due file per tutta la lunghezza del magazzino, sino all’altare.
C’è un armonium, lassù sul ballatoio di sinistra, sopra l’altare ci sono vicine ragazze in vestito turchino, con colletto bianco di divisa, operaie di un convitto, che formeranno il coro. i Uno zittio improvviso percorre i la imponente adunata; son circa duemila persone nei banchi, tra piccoli e grandi; pure, al segnale del silenzio tutti si volgono all’ingresso ove è apparsa come una visione. Una processione avanza lentamente, come una teoria lieve di nuvole bianche, cosparsa di fiammelle lucenti ed agitate. Sono i veli bianchi delle bambine della Prima Comunione, che aprono il corteo. La piccola mano destra regge una candela accesa; i volti sono leggermente trepidi, quasi sentissero, senza vederli, tutti gli sguardi che fi cercano, che domandano di essere incontrati, che forse implorano ancora tacitamente un ricordo ed una preghiera. Dopo le bambine sono i fanciulli, le mani congiunte sul petto infantile ma già fiero. Il Vescovo, li segue lentamente; la sua mano si posa due o tre volte sul capo di qualche piccino in braccio della madre.
Il coro ha cominciato il suo canto. Chi avrebbe mai pensato che una cerimonia così intima e solenne avrebbe luogo qui, tra gli ordegni di un lavoro ciclopico, tra gente adusta, che porta sul volto i segni di una indefessa fatica? Che lo spirito qui avrebbe detto la sua parola, dove la macchina sembra dominare mostruosa il piccolo uomo che la guida? Qui le famiglie, dove il respiro regolare del lavoro non deve essere turbato da nessun elemento estraneo a quelli che giocano nella misurata armonia delle forze? Eppure siamo in chiesa in un tempio! Sull’altare il Rito si svolge solenne, grandioso, nell’aria c’è come il senso palpabile del mistero, delle cose mirabili che non si vedono.
Un vecchio operaio, appoggiato alla balaustra di uno dei ballatoio, sul quale forse si era nascosto nella penombra, piange; giù le madri sussurrano ai piccoli, con voce calda, le loro preghiere. Allineati nei loro banchi, le bambine ed i bimbi della Prima Comunione, hanno il volto chino fra le palme; sui loro capi abbassati, sulle madri trepide, sui preganti, lo Spirito discende.
I canti invocano il Divino: è il momento della Elevazione. Il silenzio ora è assoluto, quasi tutti trattenessero il respiro, sovrasta soltanto quell’indefesso ansare di motori lontani. Ed ecco levarsi un trillo d’uccelli, quasi desto dall’armonium e desideroso di emularlo; poi un altro ed altri ancora a gara; sono gli uccelli degli alberi del viale che intervengono alla festa.
Poi il Vescovo parla; è canuto, rivive l’innocenza dell’età che gli è dinanzi, e la profondità insondabile del mistero. Ecco il grande momento è giunto;. egli porta il Pane celeste ai piccoli con pietà e raccoglimento intenso.
Si fa il ringraziamento: Il canto delle operaie si spiega dall’alto festoso, poliforme, ed accompagna giocondamente la processione che si riforma di nuovo, stretta d’ambo i lati dall’impeto incontenibile dei parenti ed amici.
Domani i padri torneranno nel luogo santificato da tale cerimonia, domani l’officina avrà in se il ricordo della commozione intensa di quell’ora; la santità della fede, la dolcezza della famiglia lasceranno un poco di sè nella polvere nera che invaderà nuovo ogni più remoto angolo el magazzino; e rimarrà fuori nei viali d’asfalto, tra le mura affumicate e le pareti di metallo, un po della scia luminosa di quel biancore espressivo del candore delle anime. La notte, di guardia ai forni, i padri ripenseranno con tenerezza a quelle fiammelle mobili, così tenui che basta un soffio a spegnerle, nelle mani bianche delle loro piccine.
Scuole serali di fabbrica alla Viscosa
Nel refettorio si riceve assiduamente il pane del corpo e quello dello spirito, perchè da due mesi si fa qui la scuola serale di italiano, francese, e contabilità.
Dopo il lavoro spontaneamente c’è chi indugia in fabbrica per istruirsi, mirabile esempio per i neghittosi e svogliati di ogni rango. Vengono uomini adulti o ragazzi maturi, e si interessano alla formazione di un imperfetto, alla analisi di un periodo grammaticale, ad una riduzione decimale, che alle loro intelligenze avide di sapere acquistano il seducente aspetto della verità. C’è un mutilato di guerra fra gli analfabeti: ha il braccio destro anchilosato. Fanno i compiti con una perfetta ingenuità grammaticale, ma di rara profondità di pensiero: « la qualità che più mi piace in un uomo, scrive uno, è la serietà ». E l’altro offre alle meditazioni di chi gli insegna il seguente passo: « Mi piace chi fa il bene senza aver l’aria di farlo », ed un altro ancora: « Chi crede in Dio, crede in sè stesso ».
Teatro di popolo alla Cisa Viscosa
L’incaricato del teatro è un animatore; testa bruna, grossa, occhi grandi, muscoli facciali fortemente prominenti; barba forte, anche se rasata, corporatura massiccia e tarchiata; scarpe da alpino anima di fuoco. Il suo spirito pervade la sua attività, ovunque egli appaia nel convitto operaio, sbucando all’improvviso, con quel suo largo sorriso, indulgente, di anima buona. La settimana lavora con gli operai, la domenica vuole anche i bambini e le famiglie del vicinato, e ne raccoglie parecchi delle casette povere, raggruppate a centinaia vicino allo stabilimento, come una folla di umili in ozio. Egli è orgoglioso delle famiglie del quartiere, come un padre; le raduna, e poi le porta a teatro, ove le prime file sono riservate ai ragazzi. Il teatro che organizza lui, perché il teatro è uno dei compiti più caratteristici ed efficaci dell’opera sua.
Operai sono gli attori; e, coloro che assistono sono i loro compagni di lavoro e le famiglie proletarie dei dintorni, integralmente rappresentate. Sono padri, madri di famiglia, zie, ragazzi, lattanti; nessuno resta sacrificato a casa. Le parentele numerose intervengono intere, con la simpatica aria domenicale che infonde su persone e cose, il senso del riposo e della sosta. Sfilano dagl’ingressi gremiti, con impazienza, nel salone del convitto affollato, capace come una grande sala, di un grande cinematografo, di una grande città.
Il salone è già colmo di pubblico, il semplice pubblico senza pretese della gente che lavora, scarsamente preoccupato di convenzioni, capace però, lo stesso, di cavalleria, relativamente silenzioso, pur nel numero rilevante dei presenti, forse sospeso nell’ansia delle cose che vedrà.
Le file delle seggiole occupate non sono più regolari, e composte, come quando erano vuote. Hanno del mareggiare delle onde. I bambini salgono e scendono dalle ginocchia materne. I padri conversano con i gomiti appoggiati alle spalliere delle seggiole, per traverso. Le madri allattano il piccino.
Ed ecco si alza la tela. Ora palcoscenico e platea costituiscono una umanità indissolubile. Operai sono gli attori. La lingua è corretta, financo nella pronuncia, come esige la dignità della scena. Il gesto è misurato e l’arte, ossia la personificazione dei caratteri e situazioni è spontanea, aderenti a chi la vive per breve tempo. Rivela sensibilità ed oggettività che non mi sarei aspettata. Anche i costumi sono indossati con disinvoltura, con eleganza. Le mani grosse avvezze al contatto di corpi contundenti, degli acidi, della calce, nodose alle articolazioni, per lo sforzo continuo, mi fanno tenerezza. Qualche volta, le intravedo nei movimenti dei semplici attori, abbandonate sulle ginocchia, tese in atto di accoglimento, alzate in gesto appassionato.
Questa sera si rappresenta un figlio che torna a casa sua, dopo una lontananza colpevole, in seguito ad un pentimento rinnovatore e commovente. È un dramma semplice, umano, scene vere, della vita reale,
Parimenti gli attori recitano bene perché l’incaricato sceglie bene fatti della loro vita da rappresentare, ed i loro compagni sono lì ad ascoltarli. Assegna le parti e studia i caratteri facendoli coincidere con quelli del dramma, artista, in questo, anche lui.
Intanto, l’attore giovane, quelle che rappresenta sempre il figlio scapestrato, quello di cui le madri tremano, e le ragazze, dai begli occhi luminosi, deprecano, per i suoi portamenti, sulla scena, e venuto da me. Vuole spesare. Qualche lagrima sgorgata recitando, forse dai suoi occhi, terse da quelli dell’operaio anziano che fa così bene, cui senza gli artifizi dell’inverosimile. L’arte ne sgorga facilmente educatrice.
Un palpito di commozione invade l’uditorio. Gli uomini non parlano più; le madri fissano la scena con le pupille ferme, chinandosi a custodire i piccoli, senza muovere lo sguardo, i petti occupati, da qualche cosa di simile al singhiozzo.
I colloqui della scena, drastici tra un padre parco ed onesto ed il figlio avido di piacere, gli alterchi tra i due fratelli in disaccordo, l’agitazione incomposta che segue un furto, muovono brividi di emozione, quasi sensibili nel silenzio attento degli ascoltatori. Che sollievo alla vittoria della onestà sulla calunnia, che soddisfazione dinanzi alla generosità del perdono.
Senza nascondersi, gli spettatori piangono, con una convinzione tanto più viva in quanto gli attori sono dei loro.
Parimenti gli attori recitano bene perché l’incaricato sceglie bene fatti della loro vita da rappresentare, ed i loro compagni sono lì ad ascoltarli. Assegna le parti e studia i caratteri facendoli coincidere con quelli del dramma, artista, in questo, anche lui.
Intanto l’attore giovane, quello che rappresenta sempre il figlio scapestrato, quello di cui le madri tremano, e le ragazze, dai begli occhi luminosi, deprecano, per i suoi portamenti, sulla scena, è venuto da me. Vuole sposare. Qualche lagrima sgorgata recitando, forse dai suoi occhi, forse da quelli dell’operaio anziano che fa così bene, cui vengono sempre assegnate le parti del padre di cuore, hanno suggerito, con una didattica tutta sperimentale, che doveva mettersi a posto. Nella vita, oltre che sulla scena, regolarizzare cioè il suo matrimonio. L’impresario di occasione ma di passione con il suo teatro non poteva aspettarsi premio migliore!
Ferdinando Baldelli: l’uomo, 7, 1959, pp. 11-12.
di Lorenzo Bedeschi
A misurarlo con la nomenclatura normale Mons. Baldelli passa per un ometto piccolo. A occhio e croce secondo me non dovrebbe superare i 160 centimetri. La cicatrice sopra l’occhio sinistro gli deriva da una caduta che fece sullo stipite del focolare sul finire del secolo scorso. Due occhi trivellatori e roteanti. I capelli cono neri.
È un marchigiano e viene dalla gavetta. Non dimenticate che è figlio di mugnai. Forse gli deriva da questa origine la rapidità con cui egli oggi può valutare il grano occorrente per riempire un vagone o la farina necessaria per sfamare gli alluvionati di Benevento.
È nato a Pergola, ha studiato nel seminario di Urbino.
Della sua regione marchigiana ha assimilato le tre qualità positive e cioè : la nettezza, la cocciutaggine e l’attività. A vederlo lindo dentro la tonaca netta potrebbe sembrare perfino un mons. di Curia. Anche la cocciutaggine però ha ereditato dalla sua terra. Se lo riconosce egli stesso. Anzi, la chiama tigna. Proprio come nella risposta del soldato marchigiano decorato di medaglia d’oro. Gli chiesero: perchè hai avuto la medaglia? Rispose: Per la mia tigna. Mons. Baldelli va diritto ed imperturbabile allo scopo dovesse anche rompersi la testa.
Il cappellano della parrocchia di San Francesco a Pergola nel 1921 va a Roma. A chiamarlo fu il Cardinal De Lay. Andò come semplice impiegato della Congregazione Concistoriale. Ed ancora oggi Mons. Baldelli (malgrado tutto quel po’ po’ di scompiglio tra la Pontificia Commissione e l’ONARMO) resta quel semplice ufficiale della Sacra Congregazione col relativo stipendio mensile.
A Roma, dopo le ore di ufficio, gli restava libero quasi un pomeriggio. Poteva mai star fermo quel pretino dall’argento vivo in corpo?
S’intruppò a fianco del senatore Schiapparelli torinese nella «Italica Gens». E l’« Italica Gens » era una specie di associazione o di comitato per l’Assistenza agli emigranti.
A quest’epoca Mons. Baldelli aveva 35 anni. Le ossa erano già fatte. Il periodo di prova l’aveva collaudato ed aveva rivelato un cervello organizzato, una umanità ed una tenerezza verso i doloranti. Il Viatico agli ammalati, per esempio, lo portava sempre lui.
In carcere andava lui a confessare. Anche oggi il Natale e la Pasqua li fa o in un Ospedale romano o tra i carcerati. Vuol dire che allora portava una bottiglia di vermouth ed oggi porta la carità del Papa.
La convivenza col senatore Schiapparelli nell’« Italica Gens » non dura a lungo. Ne esce e crea lui stesso un « Comitato Romano Pro Emigranti ». Questo nel 1922. E dentro questo Comitato vi mette i nomi più grossi di Roma: il Principe Ruffo, il Barone di Giura, la Duchessa Amalia Torlonia, il Duca di Rivera ecc. L’iscrizione, s’intende, non era soltanto onorifica e voi m’intendete bene.
Fatto si è che l’attività prò emigranti crebbe, fu trovata una sede in una ala del vecchio ospedale di San Antonio. Fu adattata a dormitorio, a cucina, a mensa e a sala di ricreazione. Un bel giorno il Comune di Roma vende l’Ospedale e Mons. Baldelli viene sfrattato. Tenace e imperterrito punta i piedi. Niente da fare. Lo fanno sloggiare con la polizia. Fu allora che andò ospite del parroco di Santa Maria Maggiore. È importante questo particolare perchè da quell’epoca l’ONARMO ha un quadro e cioè la Sacra Famiglia. E la Sacra Famiglia è la protettrice della grande organizzazione baldelliana.
In questo tempo, per il suo ufficio alla Concistoriale (non dimenticate che tutta questa attività marginale era soprannumeraria) va in America, proprio a New York. Sei mesi sta laggiù. Ecco, ora vi spiegate tutto. Vi spiegate la concezione a grande respiro, l’intelaiatura organizzativa, il giro di milioni, la tranquillità imperturbabile dell’uomo.
Col fascismo cessa l’attività prò emigranti, perchè l’emigrazione viene chiusa e Mons. Baldelli si butta all’assistenza agli operai e nelle fabbriche.
Nacque cosi per caso. Come tutte le cose buone del resto. Il Barone Fassini stava per impiantare la « Viscosa » a Roma, Rieti e Napoli. Aveva bisogno della manodopera. Si rivolse a Mons. Baldelli come uomo pratico e Mons. Baldelli si impegnò a procurargliela purché gli fosse lasciato il diritto dell’assistenza.
Fu così che ottenne dagli Industriali l’assistenza di un sacerdote e con le assistenti sociali.
Gli Industriali cercarono di stancarlo con lunghe ore di anticamera. Niente da fare. Il marchigiano è tignoso. Non molla. Ed eccoci alla guerra.
A portar la carità del Papa sul posto dei bombardamenti fu inviato Mons. Baldelli. Qui la sua irrequieta nervosità si esibì al completo. A Torino come a Milano, a Napoli come all’Aquila. Lo schiaffo alla guardia palatina lo diede a Castel Gandolfo. Avvenne così. Mezz’ora dopo il bombardamento era sul posto comandato personalmente dal Papa. Morti, feriti, sinistrati tutto incanalò. Alla sera non ti arriva bel bello il federale. Baldelli, nella tensione nervosa del momento ti lascia andare uno schiaffo sonante ad una guardia che chiedeva cosa insipida così a nuora perchè suocera intenda.
Nel giugno 1943 quando tutto andava a rotoli, ti organizza la grande adunata di 22 mila operai ai quali Pio XII parlò nel cortile San Damaso: « … nè soltanto lo stato sociale dei lavoratori e delle lavoratrici domanda ritocchi e riforme, ma tutta la intera e complessa struttura della società ha bisogno di raddrizzamenti e di miglioramenti profondamente scossa com’è nella sua compagine ». Da notare che il Governo non voleva questa adunata che temeva. Baldelli ottenne il permesso dopo esserne reso personalmente garante. Infatti mandò via da San Pietro ogni genere di polizia. Lui stesso diresse l’incontro.
Durante l’occupazione di Roma fu la vera organizzazione Todt della carità papale.
Un episodio alla Viscosa nel marzo ’44 osò entrare sotto lo sguardo dei tedeschi con due valigie in mano. Smontò le filiere di platino e con questo immenso capitale nelle valigie se ne ritornò. Aveva con sè miliardi di lire. La fabbrica potè riprendere a lavorare subito dopo la liberazione. Ecco Mons. Baldelli.
Il miracolo (7 giugno 1945), 7, 1959, p. 14.
Sulla parete esterna del nostro Posto di Ristoro, allestito con mezzi di fortuna, in quel poco di muratura che si è potuta trovare tra i relitti della vecchia stazione Termini, sotto una pensilina contorta e scrostata, sono inchiodate, a circa un metro e mezzo da terra, centinaia di fotografie di militari dispersi in guerra.
Gli occhi di quelli di cui non si sa più nulla, sembrano fissarsi ignari sulla teoria interminabile e movimentata dei reduci, soldati, rastrellati, partigiani, profughi, sbandati, provenienti dal nord e dal sud, che ogni giorno muove verso di noi.
Vengono all’Ufficio Informazioni ove le suore, con i rappresentanti di comitati cittadini, e con i militari, li aiutano a disbrigare le loro pratiche. Ovvero vengono direttamente al refettorio dove apparisce un po’ di grazia e di nitidezza, per quei tavoli turchini, spesso ornati di fiori freschi. Qui i reduci, dai volti pieni di stupore, solcati da una sofferenza e da una stanchezza invincibile, si alternano continuamente.
La soglia è accogliente; il nostro bracciale è bianco-giallo, ed i reduci lo riconoscono per quei colori che seppero raggiungerli attraverso l’impenetrabilità dei fili spinati: i colori del Papa.
I giovani entrano, bene accolti, si allineano, come grandi ragazzi, a sedere sulle panche, per mangiare a tavola, finalmente, dopo tanto tempo che non usano farlo più.
Spesso questa gioventù è minata dal male, contratto a piccoli sorsi, nell’interminabile serie di sofferenze, oppure sopravvenuto di colpo, violentemente. Ci sono i tubercolosi, esangui, che non riescono a tirare il respiro dai petti esili; i mutilati, fatti maldestri dalla nuova incapacità. Sono subito incontrati dalle sorelle di Croce Rossa che lavorano con noi.
Ne ho veduto un giorno qui uno, privo di ambo le braccia, entrare cupo, contrariato, rifiutando di sedersi e di mangiare; i poveri moncherini, quasi paralizzati, nelle tasche della giacca color tela d’Africa.
« La vita è amara e cattiva, ridotti così ». E il giorno dopo l’ho incontrato di nuovo, mentre veniva timidamente a visitarci; e l’ho visto tentar di muovere i moncherini per mangiare da solo.
Ricordo un tenente, estenuato e consunto dalla malaria, lo sguardo smarrito dietro le lenti, ed un filo di voce, con il quale si lamentava di non aver più la forza per continuare il viaggio e per ritornare da sua madre. Si è poi lasciato convincere, ha obbedito, s’è ristorato e si è deciso a fermarsi qualche giorno, per riprendere vigore.
Il refettorio diviene così sala di soggiorno, di convegno, di fiducioso abbandono. Neirambiente semplice che accoglie tanta umanità maltrattata, c’è un’atmosfera serena e lieve. Sembra quasi che la soave paternità del Papa, ardente di carità, sia presente, delicatamente, e che conforti, invisibile.
Qualche volta occorre, oltre il cibo, distribuire un indumento d’urgenza, o scarpe, dopo il tanto cammino consunte, o coperte, per diminuire le sofferenze ai feriti che debbono proseguire il loro viaggio in treni merci.
Non tutti passano: qualcuno si ferma, qualcuno ritorna, come il marinaio napoletano, riccio, scuro bello, pur nel viso sciupato, e che non parlava più. Il miracolo, sta’ volta, l’ha fatto la sua mamma; ed al comando di lei di chiamarla, la voce, da tanto tempo taciutasi. è dischiusa in un prodigio di amore! Ed è venuto a ridircelo perché quel prodigio sfiorasse anche noi!
Tante volte essi sono tornati a parteciparci, con timido pudore, i loro dolori: la casa distrutta, la famiglia dispersa; qualche volta un più insopportabile tradimento. Monsignore ascolta, comprende, cerca di confortare; e così trascorre la nostra giornata di bene.
Sulla parete esterna del nostro Posto di Ristoro, allestito con mezzi di fortuna, in quel poco di mura-tuia che si c potuta trovare tra i relitti della vecchia Stazione Termini, sotto una pensilina contorta e scrostata, sono inchiodate, a circa un metro e mezzo da terra, centinaia di fotografie di militari dispersi in guerra.
Passano alcune volte reduci folli, lo sguardo fisso in oggetti inesistenti, la voce monotona che ripete le medesime parole; «voglio la frutta » diceva uno di loro molto giovane, con il viso illividito dalla demenza. Povera mamma!
E vengono profughi e famiglie sfollate, confuse nelle tradotte dei reduci, e ragazze sperdute che si devono assistere, ed orfani da accompagnare a casa.
E per tutti si cerca una parola di coraggio, un gesto cordiale, un invito a sostare un attimo prima di riprendere la via, un auspicio perché il futuro accolga il palpito di speranza che qui arrise, pur brevemente.
Gli spiriti di quelli che tardano a tornare, che forse non torneranno più, di quelli che sono fotografati ed inchiodati là, dalla tenace speranza dei loro, sembrano anche essi esser presenti ai commiati traterni dei reduci, sopratutto al momento della preghiera, quando, tra i calcinacci e la baracca del Posto di Ristoro, si celebrano per tutti i Santi Misteri della Messa.
Tappe del dolore dietro la linea gotica
Siamo al campo di Rossignano Solvay, oltre la linea di demarcazione, installato nei locali assistenziali dello stabilimento industriale che ha dato il nome al paese.
La prima cosa che ho notato è il contrasto tra il nuovo e l’antico, la sovrapposizione delle vicende che cambiano faccia alla terra. I locali della scuola materna, già ricchi di infanzia gioconda e spensierata, sono oggi asilo ai profughi, in una squallida nudità. Tre o quattro famiglie vi dormono con i pagliericci in terra, in una medesima stanza, la misera biancheria sciorinata sulle corde tirate lungo le pareti. Vi sono anche i piccini; ma non sono soli, e molti di loro indossano un abito con il cappuccio, i polsi ed i calzini a maglia dei bambini americani.
C:è una scuola anche ora qui: ma che riunisce tutte le classi, costruita ad anfiteatro, la sola aula rimasta della scuola industriale. E fa impressione vederla popolata di allievi, bambini tutti, benché di età diversa. Quel giorno mancava l’insegnante e la sostituiva una crocerossina, dallo sguardo timido e sottomesso, i capelli biondi divisi sulla fronte, la quale ci aveva ricevuti.
Tutto aveva un aspetto di eccezionalità, di guerra, perché la guerra non era molto lontana: ne avevamo inteso tutta la notte l’eco, nel fragore dei motori degli aeroplani e degli autocarri, che si erano inseguiti senza tregua, sulla strada nazionale.
Bambini ne abbiamo trovati anche nell’infermeria, anzi neonati: piccoli visi paonazzi ancor più rimpiccioliti dalle cuffiette chiare, fiori vivi, letti stretti alle madri, nei lettini brevi delle stanzette nitide; c’è ne uno nato nel campo, abbiamo visti i bambini anche nella grande Cappella in cui si trasforma il salone del refettorio, che fu, forse, officina scuola, con il pavimento di cemento squallido, le molte scalcinature delle pareti, e con i tavoli e le panche dalla vernice ormai sudicia.
L’atiare, eretto fra rami di palma, con la bandiera di sfondo, dalla quale il Crocifisso pende, è anche un altare di guerra. Soltanto sulle panche davanti c’è una moltitudine di fanciulli, ignari del combattere, ma che già conoscono il patire. Hanno pregato insieme a voce alta, come fanno la domenica, radunati da un cappellano militare, con le donne e gli uomini del campo, in un insieme quanto mai eterogeneo per l’origine, l’età, l’aspetto, ed il più uniforme, per la comune condizione di profughi. Sono essi il simbolo della Patria, della precarietà del momento che viviamo, il grido vivente delle nostre necessità, la condanna della guerra, di tutte le guerre. Perciò abbiamo pregato anche noi con fervore, il cuore invaso da una emozione indicibile, perché Dio avesse pietà di loro e di noi.
Dolore ne abbiamo trovato un po’ dappertutto, oltre che nel significato delle cose, anche nelle persone. Ricordo una distinta signora anziana, profuga di Livorno da molti mesi, ormai, esausta da tanto pellegrinare, con un figliolo giovinetto, ben vestito, ma con le scarpe senza tomaia. Ricordo anche una popolana avvilita, arrivata la sera prima; il marito malato di malaria, seduto sul letto con la testa fra le mani, ed una figlia che proveniva da un sanatorio, dal quale, certamente, aveva voluto uscire per sfuggire la malinconia. Chissà se la sentiva ancora di più nello stanzone nudo, con i letti piccoli ed a terra, alcuni dei quali però, assettati e composti più che letti ben fatti di un buon albero. Monsignore che accompagnavamo si soffermò a lungo con lei. cercando, forse, di infonderle un po’ della fiamma che lo anima nel suo apostolato.
Ma più impressione mi fece un mutilato delle mani e delle gambe per mitragliamento : la carrozzina di invalido attraverso la stanza, ed una nidiata di figli — sette — intorno a lui. Portava con lo strazio delle carni, una indicibile compostezza di rassegnazione. Come si può sopravvivere così?, mi domandavo.
Eppure, nonostante queste miserie, il campo non era lugubre. La vita vi raffiorava in mille modi, nelle grida dei fanciulli innocenti, nell’operosità delle donne, anche se si posava stanca nei lineamenti dei sofferenti. Quel tanto di solidarietà umana ch’esso rappresentava, non era vano. Sembra che l’uomo ridotto così ai minimi termini, possa ancora risorgere per una insospettata insita energia. Basta che qualcuno si chini su di lui, e gli offra il breve albergo di un tetto e lo sfami, con un cantuccio di pane e lo ricopra un poco. Purché non si lasci spegnare del tutto il suo vigore, la speranza per lui risorge. Basta che vi sia chi Tassista! Monsignore, quel giorno, non ha soltanto dato offerte, ma ha detto anche parole. Eppure pareva che il suo passaggio segnasse una scia luminosa. Egli rincorava tutti, i profughi, i medici, le crocerossine; e mi parve, ad un tratto, che il profìlo della crocerossina bionda e quello del cappellano alpino e piemontese, si moltiplicassero improvvisamente, per quanti erano i profughi e sostassero lievi dietro ciascuno di loro, proteggendoli dolcemente. E se il portento potesse davvero avverarsi, al divino prodigio evangelico, certamente quei cenni di vita si moltiplicherebbero meravigliosamente, e la pena umana sarebbe più ampiamente confortata dalla speranza.
A Zoccoli, frazione di Castel Fiorentino, ci segnalarono un ragazzetto che studiava sempre. Nel camerone, già granaio, con i letti a due posti che un tempo si adoperavano per i bachi e che ora servivano di sostegno ai pagliericci per gli uomini, aveva messo un banchetto di scuola, chissà dove rinvenuto; l’aveva riempito quasi letteralmente di libri e di quaderni, ordinatamente disposti. Incurante di tutta la vita che ferveva intorno a lui, il piccolo profugo bolognese aveva cosi forte volontà e capacità di raccoglimento, da rimanere per parecchie ore del giorno assorto sui suoi libri. Non si accorgeva della confusione, e pareva non accorgersi della primavera incipiente nella smagliante campagna, né del suo richiamo all’aperto.
Voleva farsi prete. Ce lo disse la mamma, aggiungendo che lei non voleva. Monsignore, che accompagnavano, posò la sua ma no lungamente sul capo dell’adolescente, e, guardandolo, gli rispose: « Noi siamo soldati, bisogna che ti avvezzi a fare del bene!
Il fanciullo non rispose la madre non fiatò.
Assistenza Religiosa di fabbrica 1946, 7, 1959, p. 16.
Immutata la portata del numero dei Cappellani del Lavoro. La loro attività segue l’impulso di un apostolato coraggioso, tenace, bene accetto, perchè immedesimato con l’amore e il sacrificio.
Le Conferenze Aziendali di San Vincenzo enumerano ben 3005 visite ad operai ammalati.
S. S. — Lo statino del Servizio Sociale nel 1946 esprime la sua progressiva efficienza.
Mese N° Stabil. Operai assistiti Ore di servizio Pratiche espletate
Gennaio 30 11.110 147 2.045
Febbraio 30 9.310 149 1.865
Marzo 38 13.660 188 2.450
Aprile 38 12.340 180 2.607
Maggio 38 13.940 204 2.762
Giugno 38 14.000 229 2.492
Luglio 38 14.000 229 2.938
Agosto 38 15.500 230 2.322
Settembre 39 15.450 230 2.448
Ottobre 39 17.270 379 3.193
Novembre 49 17.273 379 3.515
Dicembre 49 16.991 379 3.366
Totali 2.932 32.003
Le Assistenti Sanitarie visitano 41 Stabilimenti ed annotano, nel 1946, n° 12.729 prestazioni, tra le quali cure di malati a domicilio, distribuzione di medicinali, di viveri, indumenti e pratiche varie.
Le Mense aziendali sono 530 con 2.300.000 conviventi.
I viveri forniti sono per un complesso di kg. 2.250.000.
Le integrazione Sepral di kg. 172.100.
Servizio Sociale di Fabbrica, 11-12, 1959, p. 16.
L’Assistenza Sociale di Fabbrica è un insieme di servizi sociali promessi allo scopo di creare legami umani nei membri dell’azienda, concepita come unità economica. La sua azione pertanto e volta a fortificare dal di dentro il senso del comune interesse e la fusione degli elementi della produzione, considerati come cellule di un corpo economico unico, la cui salute reagisce diversa-mente a seconda delle diverse interrelazioni tra di loro, nella unità caratteristica dell’azienda, completa in se stessa, che bisogna però munire dei mezzi per una coesistenza possibile, anzi amichevole.
L’Assistenza di Fabbrica
Si distingue da ogni altra iniziativa, nell’interno della fabbrica, per il suo scopo intrinseco di Servizio, ossia di pratica prestazione, utile concretamente.
Professionalità e specializzazione dell’Assistente Sociale di Fabbrica
L’Assistente Sociale di Fabbrica è un esperto dell’adattamento umano, ossia dei metodi per facilitare nell’uomo, quando si senta, o si riveli, disadattato al gruppo sociale in cui opera, la promozione all’equilibrio tra le sue risorse endogene, impedite, mal dirette, o inattive, e quelle esogene dell’ambiente o società in cui egli vive senza soddisfazione.
Tali metodi l’Assistente Sociale applica nei confronti del disadattato, usando tecniche appropriate di stimolo, di obbiettivazione e di attuazione di sé, basando il rapporto professionale con lui, sul rispetto per la dignità della persona umana, e sulla fiducia delle ricche possibilità di essa.
Inoltre, 1’Assistenza Sociale di Fabbrica è un Assistente Sociale specializzato nella conoscenza scientifica dell’organizzazione aziendale », degli scopi specifici della « produttività », dei principi di a psicologia industriale », della « psicologia di massa » e delle « relazioni umane ».
L Assistente Sociale di Fabbrica ha la specifica funzione di applicare, alle prassi del Servizio Sociale individuale e di gruppo, i dati delle suddette scienze aziendali, nell’ambiente di lavoro.
Inserimento dell’Assistente Sociale di Fabbrica nell’Azienda
L’Assistente di Fabbrica opera all’interno degli stabilimenti:
— nell’ambito della disciplina aziendale
— subordinato alla gerarchia in essa vigente
— inserito, normalmente, nello schema produttivo
— al livello delle sue turioni di concetto
— A tale inserimento amministrativo dell’Assistente Sociale di Fabbrica nello stabilimento, dovrebbe corrispondere un suo inserimento concreto nell’azienda, e cioè egli dovrebbe:
— occupare un posto determinato ove svolgere il suo lavoro (ufficio)
— avere un tempo determinato in cui normalmente svolgere tale lavoro (orario)
— avere la possibilità di incontrarsi con con gli elementi attivi della comunità produttiva aziendale (dirigenti, impiegati, lavoratori)
— avere la possibilità di svolgere servizi sociali, approvata dalla Direzione di azienda sul piano culturale, ricreativo, interessanti soprattutto le categorie degli apprendisti, donne, gli anziani, ed anche le famiglie, con la partecipazione attiva dei lavoratori stessi.
Deontologia della Assistenza Sociale di Fabbrica
La deontologia più appropriata per il serri: sociale di fabbrica, è la morale cristiana fondere sulla fiducia, nei valori umani da raggiungere con l’uso attivo dei talenti ricevuti, assunti cere responsabilità della vita, ordinati al conseguimento del destino ultimo dell’uomo e della Società questa morale l’Assistente di Fabbrica ispira:
a) nel suo comportamento personale
b) nel suo lavoro professionale
come al mezzo più valido per giungere, per quanto è possibile, alla realizzazione de comunità umana, sintesi della correlazione fatto, reciproca, di fusione cui anche l’azienda, di fatto tende.
A tale scopo la Assistenza di Fabbrica dell’Onarmo integra il proprio Servizio Sociale con l’azione dei Cappellani del Lavoro, cip spiritualità e di fede negli ambienti di lavoro.
Scuola di Roma. Tesi « Assistenza Sociale di Fabbrica nell’Ente Onarmo» della candidata Maria Ciolli, 1, 1960, pp. 6-7; 2, 1960, pp. 13-16; 3, pp. 10-12; 4, pp. 14-16.
Nata e cresciuta in ambiente operaio, ho sentito nella mia adolescenza il peso materiale e morale dei problemi riguardanti questa categoria, ed ho altresì nutrito per questi problemi un crescente interesse intellettuale. Oggi nel mondo, e segnatamente nel nostro Paese, la questione operaia non appare ancora perfettamente chiarita, e mi pare perciò non inutile di contribuire, con un tentativo anche modesto, a precisarne qualche aspetto. Del resto sappiamo che la Repubblica Italiana fu fondata proprio sul lavoro (ce lo dice l’art. 1 della nostra Costituzione); i cittadini salvo qualche sussistente eccezione traggono dal lavoro le risorse per vivere, e non da privilegi antichi o da redditi internazionali. Ogni sera quando mio padre tornava dal lavoro, sentivo ciò che raccontava dei suoi compagni, dei suoi dirigenti; ascoltavo attenta i suoi giudizi, generalmente di malcontento per la paga non sempre giusta, per il lavoro spesso troppo faticoso; e sullo sfondo c’era l’assillo continuo della paura di restare disoccupato. Mi venivo chiedendo il perchè del continuo conflitto tra operai e datori di lavoro, e acquistavo confusamente coscienza del fatto che un morbo morale incatena gli uomini, facendoli essere incontentabili epperò odiatori gli uni degli altri.
Quando poi ho studiato a scuola che esistono condizioni obbiettive (per es. l’economia basata sulla concorrenza) per le quali si determinano disparità crescenti fra le classi, ciò non mi ha impedito di pensare che, anche in tali condizioni, possono essere esercitate la solidarietà umana e la Carità cristiana, e inversamente che, anche in condizioni diverse, può la vita corrompersi per l’invidia dei figli di Adamo.
Ho notato per esempio che quando in un gruppo lavorativo esiste una collaborazione tra operai e imprenditori, in quanto lo operaio partecipa agli utili, se questi superano un minimo stabilito, egli si sente più soddisfatto e si sforza di fare sempre meglio. Ancora più contento è quando si sente compreso dal suo padrone nei momenti tristi e di maggior disagio.
Ora che ho avuto la possibilità di fare questo studio sull’ambiente di fabbrica attraverso l’apporto delle notizie che le A.S. hanno inviato dalle varie fabbriche delle città d’Italia, posso esaminare con maggiore obbiettività la vita degli operai nell’interno dell’azienda, il rapporto con gli altri operai, con i dirigenti, con le varie organizzazioni (sindacati, commissioni interne, enti assicurativi, etc.): vita operaia complessa e spesso nel lavoro dolente per le molte difficoltà; spesso carica di tensioni e scontenti dovuti a incomprensioni interne e ad esasperazioni esterne; spesso oscurata, come tutto questo mondo, operaio e no, dalla mancanza di pace interiore. Una componente di grande importanza, direi assai utile – non dico sufficiente – per il miglioramento dell’individuo e della vita di gruppo in tale situazione ambientale è l’assistente sociale (uso il termine al genere femminile non soltanto in considerazione della prevalenza numerica ma anche e soprattutto ritengo che tale professione addica meglio alla donna che all’uomo). Ella con la sua colare sensibilità per i probi sociali, con la conoscenza della psicologia individuale e di gruppo, con la preparazione tecnico professionale, e con una umile e intelligente tesaurizzazione delle esperienze proprie ed altrui, può capire le ragioni profonde del problema operaio e dei problemi degli operai, e può efficacemente contribuire all’equilibrio morale dei suoi assistiti.
Esperienze delle Assistenti Sociali dell’ONARMO nelle fabbriche in Italia
Alla fine dell’anno 1958, l’Ufficio Coordinamento Scuole Onarmo ha rivolto a tutte le A.S. che lavorano alle dipendenze dell’ONARMO, in 795 fabbriche, sparse nelle città d’Italia, un questionario, per effettuare uno studio sul Servizio Sociale di Fabbrica già in atto.
Fino ad oggi sono giunte soltanto le risposte che riguardano 230 aziende, a delineare il quadro generale del servizio sociale di fabbrica svolto dall’ONARMO.
Il prospetto seguente mostra il numero e la provenienza delle notizie raccolte.
Le 229 fabbriche contano 78550 dipendenti, di cui 58311 (75 %) operai, 12191 (17%) sono donne; 3159 (4%) circa sono tecnici, 4888 (6%) sono impiegati amministrativi.
Raffrontando poi il totale del personale con il numero delle assistenti sociali ad essi addette, risulta che, sui 78550 dipendenti, lavorano appena 120 assistenti sociali, con il rapporto di 1/650.
Ogni assistente sociale dunque ha in media 650 operai (quadro A):
Abruzzo 18 assistenti sociali in 4 fabbriche
Calabria 5 assistenti sociali in 5 fabbriche
Campania 12 assistenti sociali in 9 fabbriche
Emilia Romagna 52 assistenti sociali in 26 fabbriche
Lazio 23 assistenti sociali in 11 fabbriche
Piemonte 19 assistenti sociali in 40 fabbriche
Puglia 4 assistenti sociali in 4 fabbriche
Sicilia 22 assistenti sociali in 12 fabbriche
Toscana 17 assistenti sociali in 12 fabbriche
Questionario per le nostre Assiste Sociali di Fabbrica
1) Qual’è l’organizzazione e la struttura della fabbrica presso la quale prestate servizio sociale?
2) Quale il numero degli operai?
3) Quanto tempo settimana!, mente siete presenti in fabbrica? In quali ore del giorno?
4) Siete presenti nei vari reparti oppure solo nel vostro Ufficio?
5) L’Ufficio di cui disponete è facilmente accessibile agli operai?
6) Tenete rapporti di collaborazione con i Dirigenti? In che cosa consistono?
7) La vostra azione è rivolta alla comunità di lavoro o alle singole persone?
8) Che tipo di rapporti avete instaurato con gli operai?
9) Come l’Assistente Sociale è vista, sul piano professione ft dall’operaio e come dai dirigenti?
10) Esiste il Cappellano di Fabbrica? Quale collaborazione gli prestate?
11) Quale la maggiore attività svolta (casi individuali, pratiche assistenziali, aiuti economici o in natura, ecc.)?
12) Che tipo di assistenza svolgete in caso di malattia o di infortunio e di nuova assunzione?
13) Per svolgere il proprio lavoro, avete un piano formulato in base agli interessi e ai bisogni reali della comunità di fabbrica?
14) Quali sono le difficoltà maggiori riscontrate nella Vostra attività? Che cosa proponete per rimediarvi?
15) Quali suggerimenti avete da dare per un sempre più proficuo lavoro nel mondo degli operai, ai quali già prodigate la Vostra azione sociale?
Questionario per Assistenti Sociali addette a Centri Sociali nella cui zona sorgono fabbriche
1) Conoscete le caratteristiche della zona in cui lavorate? In che modo potete riassumerle?
2) Avete mai lavorato in collaborazione con altri tecnici per la rilevazione e soluzione dei problemi di principale interesse per il luogo ove è in atto il Centro Sociale?
3) Siete in rapporto con le persone più rappresentative della zona (Autorità Religiose, Civili, Scolastiche, Dirigenti di Enti Assistenziali, Educativi e Ricreativi? ecc.).
4) Sono stati richiesti ed accolti Vostri pareri ed interventi?
Analisi delle risposte pervenute al questionario
1. Organizzazione e struttura dello stabilimento in cui si svolge il servizio sociale
Le fabbriche in esame sono, per la maggior parte, di media e piccola industria. Fanno eccezione le grandi aziende della Montecatini (6 in tutto), della Palmolive S.p.A. (1 di Anzio), dell’AGIP (4), delle FF.SS. (6), della Navalmeccanica di Napoli, delle grandi miniere di salgemma e di zolfo (Sicilia), delle società elettriche (3 S.R.E., 1 SHE, 2 SEEE, 3 SELT Valdarno), dell’OMSA (1), che assorbono un gran numero di personale, ed hanno una struttura molto complessa. Segue poi un numero abbastanza rilevante di piccoli complessi industriali nati dall’artigianato e che contano un esiguo personale, esistenti nella regione dell’Abruzzo: 11 ad Aquila, 6 ad Avellino e uno a Teramo, e quattro nella regione della Campania, nella città di Avellino.
Ogni azienda è strutturata in una gerarchia piramidale, più o meno complessa secondo la grandezza della fabbrica.
Vi sono: uffici tecnici, con il direttore e il vice direttore, con gli ingegneri, i disegnatori, i chimici; gli uffici amministrativi, con l’ufficio mano d’opera e paga; gli uffici commerciali, con i magazzini.
Gli addetti a tutti questi uffici costituiscono il numero dei dirigenti esistenti in genere in una azienda.
Dalle notizie inviate dalle assistenti sociali, risulta che, nelle 230 fabbriche in esame, sui 78.550 dipendenti, vi sono soltanto 5350 dirigenti, di cui 2191 sono i tecnici e 3159 sono gli impiegati amministrativi: la proporzione mostra bene da quale parte si debbano trovare in più grande numero i problemi legali, economici, burocratici – e in definitiva, umani – che l’assistente sociale deve contribuire a risolvere.
2. Tipo d’industria a cui lo stabilimento appartiene
Le fabbriche che hanno accettato l’intervento dell’assistente sociale, sono di vario genere e anzitutto 30 fabbriche, (il 14%) industrie per la costruzione di materiali edili, con la quantità massima nel Piemonte (N. 12 a Casale M.) e nel Lazio (5), e, in minor numero, in Emilia (3), Romagna (2), Sicilia (3), Abruzzo (2), Toscana (1), Calabria (1), e Campania (1). Sempre in ordine di maggioranza relativa, seguono 28 industrie meccaniche (13%), soprattutto in Piemonte (9), e, in Emilia (14); 27 industrie chimiche (13%), 24 industrie tessili (11%); 16 industrie alimentari (7,7%); 16 miniere (7,7%), con prevalenza in Sicilia (10); 12 industrie elettro-tecniche (5,8%); 9 industrie di trasporti e motorizzazione (4,5%);8 piccole fabbriche (4%) tutte dell’Abruzzo (Aquila); seguono poi con la medesima percentuale (1,4%) le industrie di calzature, siderurgiche, nautiche, cartarie, lavorazione di legno, del tabacco, radio T.V.; dell’1% scatolifici, industria per la lavorazione del vetro, laterizi, per l’abbigliamento, e petrolifere, del 0,4 % le industrie molitorie, commerciali, ceramiche, bonifiche, etc.
Tra queste si disegnano significativamente p. es. le solfatare siciliane. Un’assistente sociale vi si reca una volta alla settimana; per la mancanza di trasporti, vi si reca con una macchina messa a disposizione dal Cappellano del lavoro, e quando la macchina non è libera, si serve di mezzi di fortuna. Dagli operai delle miniere, l’assistente sociale è molto ben voluta; essi l’aspettano numerosi, perchè hanno bisogno di lei, della sua presenza: hanno da chiederle molte cose; ed ella non si dà pace finchè non ha esaudito le loro richieste. Un altro quadro significativo è quello delle fabbriche tessili (11% rispetto al totale delle fabbriche esaminate): il personale è quasi tutto femminile (4103 donne contro 812 uomini, cioè l’83% del personale totale di queste industrie).
C’è da tener presente che le differenze tra una fabbrica e l’altra, dovute al tipo dell’industria, incidono molto sui lavoratori, sulla loro psicologia e sul loro stesso modo di vivere e di comportarsi. C’è differenza tra l’operaio di una fonderia, costretto a sentire i rumori assordanti, dalla mattina alla sera, con la sua tuta sporca, sempre davanti al pericolo, e l’operaio di un’industria chimica (p. es. la Palmolive di Anzio) con il suo camice bianco, sempre pulito, in ambienti silenziosi e tersi, dedito ad un lavoro calmo. Tra i due c’è un modo diverso di lavorare e di reagire agli stimoli esterni. Ciò nonostante i problemi fondamentali umani sono quasi sempre gli stessi, dovuti al fatto che sono operai che lavorano, subordinati alla volontà dei dirigenti, costretti ad un certo orario, con questioni familiari e morali che li preoccupano.
Nelle fabbriche dove è più sviluppata la prassi democratica, dove esiste il rispetto per la dignità dell’operaio, il clima di lavoro è più tranquillo, e c’è maggiore produzione.
Inoltre il conflitto fra datore di lavoro e lavoratori in genere si fa sentire meno pesante.
L’assistente sociale cerca tutti i modi di placare le ostilità, individuandone le cause, chiarendo le idee, cercando di persuadere a rispettare la personalità vicendevolmente, di persuadere tutti da ambo le parti, dei reciproci diritti e doveri, e soprattutto del dovere di comprendere l’altro quando questi venga a trovarsi in particolari condizioni di spirito.
3. Numero dei dipendenti dell’azienda
Come ho già accennato precedentemente, il totale generale dei dipendenti delle fabbriche in esame è di 78550, di cui 58.311 sono operai (= 75%), 12191 (= 17 per cento) sono operaie, 3159 (4 per cento circa) sono tecnici e 4888 (6%) sono impiegati amministrativi.
Si rileva che nelle regioni centro-settentrionali si ha un numero maggiore d’industrie, e quindi più lavoratori assistiti. Facendo il rapporto tra le assistenti sociali addette 120, e il totale del personale, si giunge al rapporto di 1/650, abbastanza rilevante, con un massimo di 1’a.s. per 1202 lavoratori a Bari, e con un minimo di 1’a.s. per 67 lavoratori a Sarsina.
Escluse le eccezioni, in linea generale ogni assistente sociale Onarmo ha un elevato numero di lavoratori da avvicinare nella fabbrica, soprattutto nelle regioni meridionali (Campania, Puglia, Calabria) e un po’ meno nella Sicilia. A ciò si accompagna spesso lo scarso numero di presenze settimanali, e talvolta la cura di un Centro Sociale nella zona con più fabbriche da visitare.
4. Ruolo dell’assistente sociale nella fabbrica
Da qualche anno il servizio di fabbrica pone problemi di regolamenti, di ruolo e di metodi (per questi argomenti cfr. “I nuovi orientamenti del servizio sociale nelle imprese e le relazioni umane” in questa rivista al n. 11, 1958, pp. 4-6). Esso subisce una evoluzione e si sviluppa in direzioni che non sono sempre convergenti. Bisogna infatti distinguere: da una parte i problemi che si pongono nei paesi in via di rapida industrializzazione, dove i lavoratori hanno un livello di vita ancora basso, la legislazione sociale non è sufficientemente sviluppata, né le organizzazioni dei lavoratori sono
in grado di migliorare la situazione; da un’altra parte i problemi che si pongono nel quadro di una prassi già notevolmente sistemata, in regioni altamente industrializzate. In questo livello di vita dei lavoratori relativamente elevato, l’assistenza materiale è meno necessaria; la legislazione sociale, gli istituti di previdenza sono perfettamente sviluppati; le organizzazioni dei lavoratori rappresentano una forza attiva e curano di salvaguardare l’indipendenza di essi di fronte agli interventi dei datori di lavori sotto forma assistenziale; e infine vi sono servizi del personale; con scopo economico-sociale, con l’incarico di amministrare il personale della fabbrica e di incrementare il piano per la soluzione dei piani umani del lavoro. In considerazione di questi nuovi dati si fanno sforzi in molti Paesi su di un piano nazionale e internazionale per rinnovare il compito del lavoratore sociale di fabbrica, il suo regolamento e i suoi metodi.
Il IX Congresso dell’UCISS offre la possibilità di un largo confronto e scambio di idee e di esperienze in questo settore.
È stato diffuso in quella occasione dall’UCISS un questionario destinato a preparare i lavori del gruppo di discussione, e si è arrivati a formulare parecchie concezioni del Servizio Sociale di Fabbrica nei differenti Paesi del mondo. Queste formulazioni si potrebbero ridurre a tre: le prime due provengono dall’Europa e l’America latina, la terza America del Nord. Nelle prime due il servizio sociale è organizzato nella fabbrica o mira a organizzarvisi, concepito come un settore della direzione del personale.
La prima forma comprende numerosi servizi sociali che effettivamente si occupano poco dei problemi del lavoro propriamente detti. Sono servizi incaricati di fornire nell’interno e all’esterno della fabbrica un aiuto (economico, medico, sociale, morale) al lavoratore e alla sua famiglia. Questa assistenza di fabbrica ha la responsabilità anche di opere educative.
In tali circostanze i lavoratori sociali sentono il bisogno di assicurarsi una posizione indipendente, come a margine della fabbrica, per salvaguardare l’autonomia del cliente ed il segreto professionale.
Ma tale situazione limita l’opera loro alla fabbrica e non permette loro di agire sulle strutture dell’azienda, che in modo superficiale.
La seconda forma comprende i servizi sociali che intendono occupare un ruolo sociale organico, nell’impresa riguardo al lavoro, e sviluppare un’azione nella azienda, al livello del gruppo e del sottogruppo. Se le assistenti sociali conservano sovente, all’esterno della fabbrica, funzioni di assistenza, esse lo fanno a titolo supplettivo e nella misura in cui l’organizzazione sociale è insufficiente.
Questa concezione urta contro una difficoltà: la definizione dei compiti specifici del « servizio del personale » e del « servizio sociale ». Infatti le preoccupazioni di questo servizio sociale sono anche quelle del servizio del personale, quando esso non si limita a funzioni puramente amministrative.
Terza forma, il servizio sociale non è sistematicamente organizzato nell’impresa. Al servizio del personale o « Direzione Personale » è affidato il compito di amministrare il personale, di promuovere buone relazioni umane e di favorire 1 incremento dei lavoratori nell’impresa.
L assistenza di fabbrica è organizzata al di fuori della fabbrica ed assiste il lavoratore e la sua famiglia che si trova in difficoltà.
Le assistenti sociali ONARMO che hanno risposto al questionario, affermano per la maggior parte (117 su 230) di svolgere un servizio simile alla prima forma sopra riportata.
Tale forma di servizio è svolta nelle fabbriche del nostro Paese da circa il 50% delle assistenti sociali che hanno inviato la risposta al questionario relativo. Il ruolo dell’assistente sociale si svolge a margine della fabbrica.
L’impostazione del servizio sociale nelle aziende è, per la maggior parte determinata dall’atteggiamento mentale dei vari imprenditori e di conseguenza, dalla concezione che i medesimi hanno dei compiti dell’assistente sociale nella propria azienda. Secondo i questionari molti degli industriali, per la maggior parte nelle piccole e medie industrie, sono favorevoli al servizio sociale soltanto dal punto di vista del disbrigo di pratiche burocratiche, e tutt’al più dall’assistenza al caso individuale (per queste notizie, ho attinto dallo scritto di Rampini Marcella: Relazioni sul servizio sociale di Fabbrica, in « Il Congresso Nazionale ONARMO», pagg. 4 segg.).
Gli aspetti del Servizio Sociale attinenti al fattore umano, all’educazione del personale, alla distensione dei rapporti dei membri dell’azienda, anche quando vengono presentati sul piano della reale convivenza agli effetti della stessa produzione, rimangono ancora una formulazione teorica che non fa presa sulla mentalità di tali datori di lavoro, i quali sono convinti di concedere ai propri dipendenti un servizio che, in base alla pura logica, non sarebbero tenuti a fornire. Questo soprattutto perchè tali datori di lavoro non avendo seguito lo sviluppo del progresso sociale, sono portati solo ad interessarsi dei problemi, che ritengono essenziali dal punto di vista della produzione.
Si preoccupano infatti dell’efficienza del macchinario, del ritmo di produzione, del collocamento della merce sui mercati, e sono continuamente assillati dalla concorrenza degli altri produttori.
Con questa limitata concezione del servizio sociale, l’industriale circoscrive il servizio stesso a determinati compiti, privandolo della sua efficacia, spesso anche in buona fede e con la sicura aspirazione di volere dimostrare ai lavoratori la benevolenza dell’azienda.
Quando il Servizio Sociale è inteso così, si è ben lungi dal considerarlo nella sua essenza, perchè finisce per essere un’attività marginale, anzichè inserirsi nell’impresa per stimolare e risolvere i problemi sociali connessi al lavoratore.
L’assistente sociale cerca di agire indipendentemente da qualsiasi influenza e subordinazione, per quanto riguarda l’applicazione della metodologia e della tecnica professionale, pur collaborando con quanti sono interessati alle attività sociali esistenti nell’azienda.
Si rileva dalle notizie raccolte dal questionario, che il 6% delle assistenti sociali svolgono un ruolo organico nell’impresa, applicano cioè la seconda forma di servizio sociale di cui prima ho parlato.
Questa forma si rivela attuata soltanto nei grandi complessi industriali come la TETI, la RAI, la MONTECATINI, ove i datori di lavoro hanno raggiunto un’elevata sensibilità sociale, o nelle piccole aziende, ove l’imprenditore stesso si fa promotore del benessere degli operai.
Ella riesce ad organizzare il lavoro di gruppo, il quale si rivela utile ad un perfezionamento delle capacità degli operai; affianca le altre istituzioni aziendali come la cassa mutua interna, il medico di fabbrica, il comitato aziendale di sicurezza sociale; favorisce l’istituzione delle mense, dei corsi di istruzione popolare e delle biblioteche.
Secondo questa forma, il ruolo dell’assistente sociale è organico nella fabbrica e opera all’esterno, solo quando mancano istituzioni ad hoc.
La terza forma di servizio sociale, è attuata dal 22% delle assistenti sociali che hanno inviato le risposte al questionario (quadro E).
Secondo questa forma il ruolo dell’assistente sociale è indipendente dall’azienda, la direzione personale si occupa di amministrare il personale, di fornire l’inserimento del lavoratore nell’impresa e di promuovere buone relazioni umane.
L’assistente sociale offre la sua collaborazione dando pareri e partecipando alle riunioni indette dalla direzione stessa. Dà suggerimenti quando si avvede di deficienze sia riguardo ai lavoratori, sia ai dirigenti.
5. Accessibilità dell’Ufficio di cui si dispone
L’assistente sociale assiste il lavoratore nella fabbrica e fuori della fabbrica ed anche la famiglia di lui qualora si trovi in difficoltà.
Secondo questa forma il ruolo dell’assistente sociale è indipendente dall’impresa: è ella riconosciuta quale funzionario, professionista, che si occupa in particolare di soccorrere i bisogni degli operai in rapporto a loro stessi e all’ambiente di lavoro, e studia e agisce per il miglioramento generale dell’impresa.
Il datore di lavoro riconosce l’assistente sociale, la sua realtà professionale e collabora con essa accettandone i pareri e agendo per una maggiore elevazione morale dell’ambiente operaio.
Infine risulta dalla risposte al questionario che il 22% delle assistenti sociali di fabbrica svolgono un ruolo del tutto proprio, ispirato al buon senso e all’esperienza personale. Alcune si occupano in particolare di casi individuali, svolgono attività in prevalenza fuori dello stabilimento; altre sottolineano la collaborazione con il servizio da parte del personale, che fornisce indicazioni e segnala i casi degli operai che vengono a trovarsi in difficoltà, per malattie o infortunio, e orienta i lavoratori verso l’assistente sociale.
6. Collaborazione tra il Cappellano e l’assistente sociale
Dalle risposte dei questionari risulta che il Cappellano di fabbrica dell’ONARMO collabora con l’assistente sociale, segnalandole casi difficili da risolvere e informandola sulla psicologia dell’operaio.
Dove esiste questa collaborazione il servizio si sviluppa con più facilità: assistente e Cappellano collaborano per lo stesso fine (il bene dell’operaio) l’uno sul piano pratico, l’altro sul piano religioso-morale. Nelle 78 fabbriche ove esiste il Cappellano del lavoro, 65 assistenti sociali collaborano con il cappellano, almeno in parte, e cioè l’84 %, mentre l’8% esclude ogni possibilità di collaborazione lavorando ciascuno per proprio conto, camminando su due binari vicini e l’8 % delle assistenti non rispondono a questa domanda per non dare giudizi e quindi non si può sapere quello che desiderino su questo punto.
Il desiderio di non avere rapporti di reciproca collaborazione è espresso soltanto da una assistente sociale di C. Monferrato, due di Modena, due di Piacenza e due di Fiesole.
È importante notare come le regioni del Sud siano più fornite di Cappellani e come sia più facile l’integrazione della sua opera con quella complementare dell’assistente sociale. Per dimostrare questo riporto qualche esempio di risposta più significativo :
Assistente sociale di Cosenza: « La collaborazione si attua così: l’assistente sociale, indica i casi che hanno bisogno di assistenza religiosa e morale ».
Per qualche assistente la collaborazione è molto limitata come ad esempio nel caso del collaboratore di Mileto, che afferma:
« esiste il Cappellano, ma eccessivamente occupato; la collaborazione consiste nell’assistenza alla Messa domenicale, con lettura del testo in italiano».
Un’assistente delle FF.SS. di Bari anzichè di collaborazione, parla di dipendenza e così afferma:
« esiste un Cappellano compartimentale e non un Cappellano ausiliario che dovrebbe essere delegato per il lavoro specifico nella sede di Bari.
Sicchè al primo è devoluto l’uno e l’altro incarico. Quanto alla collaborazione gliene offro la migliore possibile, tanto più perchè ho l’ufficio in comune con lui. Perciò spesso mi capita di sostituirmi al suo eventuale segretario per quello che concerne il suo lavoro di corrispondenza e le sue varie attività onarmistiche. Per la precisione ogni attività di lavoro in questa sede è sotto le sue direttive, quindi la mia non può chiamarsi collaborazione, ma dipendenza».
Qualche assistente ha capito la validità della collaborazione e dice: « tra me e il cappellano intercorrono ottimi rapporti dal punto di vista lavorativo; infatti spesso risolviamo casi che trattati da soli, resterebbero insoluti. Spesso collaboriamo nel senso che gli sono di aiuto per le iniziative a sfondo religioso».
Si può rilevare che quando c’è molto entusiasmo e molto spirito di apostolato da parte del Cappellano, è facile per l’assistente sociale collaborare. Questo l’ho notato bene nella città di Caltanissetta, dove quattro assistenti sociali diverse in quattro fabbriche differenti hanno lo stesso sacerdote come cappellano del lavoro, e ciascuna di esse afferma di attuare un’ottima collaborazione con il Cappellano. Esse rispondono così: « Al Cappellano di fabbrica prestiamo una collaborazione completa. Lo aiutiamo in tutte le attività: Apostolato della Preghiera, Conferenza Aziendale di S. Vincenzo de Paoli, e, per ragioni di ambiente disimpegniamo anche mansioni di segreteria. Inoltre ogni domenica assistiamo alla S. Messa, che il Cappellano celebra per gli operai, dando ad essi maggiore possibilità di avvicinarmi ».
Secondo me le funzioni de Cappellano e dell’assistente sociale sono distinte, ma non si eliminano, anzi si integrano a vicenda, proprio perchè il fine è lo stesso. Le assistenti sociali che non hanno la possibilità di attuare questa collaborazione, perché manca il cappellano nella fabbrica (66%) desiderano averne la presenza, specialmente nei casi più difficili quando il giudizio del cappellano e la sua veduta sovrannaturale, contribuirebbero efficacemente alla risoluzione dei suoi problemi.
7. Suggerimenti circa una quarta forma di servizio sociale, propria dell’ONARMO, in cui l’assistente sia a disposizione del Cappellano
Dopo aver conosciuto sommariamente quale sia oggi il ruolo dell’assistente sociale di fabbrica, è stato chiesto alle assistenti sociali, quale forma particolare di servizio sociale si potrebbe svolgere; se si può ottenere una forma propria dell’ente ONARMO, in cui l’assistente sociale sia a completa disposizione del Cappellano del lavoro, affinchè si adoperi ad integrarne l’azione, oppure invece sia del tutto indipendente da lui.
Considerata la finalità del servizio sociale e in particolare del servizio sociale cristiano il quale fa sì che l’assistente sociale differisca da un’altra per l’attitudine interiore, lo slancio lavorativo e la comprensione per la debolezza umana, si comprende l’affermazione della maggior parte delle assistenti sociali (il 29%) le quali affermano di svolgere una attività in stretta collaborazione con il Cappellano del lavoro.
Questa forma permette un’assistenza completa, che tiene conto delle esigenze non solo materiali ma anche spirituali in ogni uomo. La stretta collaborazione in cui vengono a trovarsi l’assistente sociale ed il cappellano, non significa invasione dell’altrui campo lavorativo ma una integrazione costruttiva delle distinte attività assistenziali.
A ragione l’assistente sociale G.A. di Bertinoro (Romagna) afferma: « Sono del parere che non si possa stabilire una quarta forma di servizio sociale standard, perchè ogni ambiente richiede dei particolari accorgimenti, ed un orientamento diverso, sia che si tratti di un piccolo] complesso situato in un ambiente! ristretto (es. un paese), sia che si tratti di un grande complesso. Tenendo presente la ideologia politica della maggioranza, si può stabilire a priori se la collaborazione dell’assistente sociale col Cappellano, debba essere più o meno prudentemente aperta. In ogni caso assistente sociale e cappellano debbono collaborare». L’assistente sociale B.L. di Cesena (Romagna), dice: «Il contatto quotidiano con i minatori fa sentire sempre di più la necessità della collaborazione con il Cappellano, che può raggiungere e risolvere situazioni, specialmente in campo morale, che l’assistente sociale può solo rilevare.
Quindi occorrerebbe che vi fosse mutua collaborazione e non sovrapposizione, ove l’assistente sociale sia di valido aiuto al Cappellano e viceversa, avendo ciascuno ben presenti i limiti della propria attività, per evitare spiacevoli sconfinamenti».
Una fervente assistente sociale ci mostra con un esempio la necessità della collaborazione tra il cappellano e l’assistente sociale: D.S.M. dalla Sicilia: “Secondo me l’assistente sociale e il cappellano no devono essere due rette parallele che non s’incontrano mai, lavorando ognuna nel proprio campo senza mai comunicare, bensì due rette, formanti un solo binario, su cui deve passare il convoglio che è la comune idea, lo scopo comune.
Quindi l’opera dell’una deve integrare quella dell’altro e viceversa, perchè mancando una ideale rette, non c’è binario e quindi il transito del treno non è possibile.
Così il nostro Ente, venendo meno una delle rette, non ha binario, e non raggiunge la sua politica sociale».
Deve esistere quindi una collaborazione attiva tra Cappellano e assistente sociale, perchè l’assistente sociale se non è fine a se stessa, e quella propugnata dall’ONARMO vuol essere mezzo efficace per portare l’operaio a Cristo, affinchè la sua anima senta e viva con quella della Chiesa.
Soltanto il 6% delle assistenti sociali affermano di svolgere una attività di limitata collaborazione con il Cappellano o addirittura indipendenza di lavoro. A proposito riporto una giustificazione, la più significativa fra le altre, dell’assistente sociale: A.G. del Piemonte: « Non ritengo adatta una forma di servizio sociale in cui l’assistente sociale sia a completa disposizione del Cappellano del lavoro, perché verrebbe a crearsi la stessa difficoltà di impedire al sacerdote di avvicinare gli operai di idee politiche e religiose contrarie alle sue. Ora a mio giudizio l’assistente sociale ha il compito di avviare a questi inconvenienti pertanto è ottima, ai fini del servizio, la collaborazione.
Ritengo utile riportare ancora quest’altro esempio di risposta: assistente sociale R. L. M. Piemonte: « l’assistente sociale in molti casi deve agire da sola, perchè tutti sanno che l’opera sua è indipendente dal colore e dalle idee degli operai. Essi si rivolgono con fiducia a lei per chiedere assistenza, proprio perchè sanno che la sua opera è disinteressata e si svolge indipendentemente dalle loro idee».
Secondo il mio modesto parere ritengo che sia necessaria una reale collaborazione tra assistente sociale e Cappellano, perchè l’assistenza sia più completa e più efficace.
Spesso ci si accorge che la maggior parte dei Cappellani, molto dotti nelle dottrine ecclesiastiche non hanno e non devono avere, in analoga misura, conoscenze tecniche assistenziali.
Di conseguenza hanno direttive tecniche, diverse da quelle dell’assistente sociale, perchè non si attengono solo ai principi del servizio sociale.
Risulta ancora che il 63 % delle assistenti sociali non hanno dato nessuna risposta a questo quesito o perchè nella fabbrica manca il Cappellano, per cui non possono avere una esatta visione della funzione di lui o perchè non ritengono opportuno pronunciarsi in materia.
8. Quanto tempo è presente settimanalmente in fabbrica l’assistente sociale e in quali ore del giorno
Le presenze settimanali dell’assistente sociale in ogni fabbrica sono per la maggior parte di scarso numero. Sulle 230 fabbriche si hanno 901 ore settimanali, e cioè in ogni fabbrica l’assistente sociale lavora tre ore e 55 minuti alla settimana, con un minimo di un’ora settimanale e un massimo di trentadue.
Tale numero di presenze è troppo esiguo in confronto alla quantità media degli operai, che spettano a ciascuna assistente sociale.
Circa questa scarsità del tempo che l’assistente sociale può trascorrere in fabbrica, occorre considerare anzitutto che buona parte del lavoro assistenziale di fatto nel nostro caso si svolge fuori, agli sportelli e alle anticamere degli uffici che l’assistente deve continuamente frequentare per il disbrigo delle varie pratiche, pur esistendo la Segreteria Provinciale. Tutte le assistenti sociali affermano di dover sbrigare pratiche, fare tutto quel lavoro burocratico, il quale porta via del tempo prezioso che si potrebbe invece utilizzare per svolgere veri trattamenti individuali e di gruppo.
L’assistente sociale dovrebbe riuscire piano piano ad abituare l’operaio a svolgere da solo le sue pratiche, a far valere i suoi diritti; è bene che l’assistente non si sostituisca a lui, ma lo indirizzi, lo guidi e lo stimoli ad agire da solo. Questa conquista ancora non è stata fatta praticamente dal servizio di fabbrica, per lo scarso sviluppo in cui ancora si trova il servizio, ed anche per una certa incapacità dell’assistente sociale a mobilitare agevolmente le risorse e le energie dell’operaio nei limiti dovuti ed opportuni: è più semplice e più facile lavorare noi che far lavorare gli altri. Si esige per questo un grande sforzo da parte dell’assistente sociale per riuscire a suscitare nell’operaio attività e prontezza di azione, lavorando anche lei.
Tuttavia il tempo trascorso in fabbrica è limitato ed è poco per i seguenti motivi.
Anzitutto l’assistente sociale può avvicinare gli operai soltanto dalle ore 12 alle ore 13 circa, cioè nell’intervallo che dovrebbe servire agli operai per rifocillarsi, e al momento dell’uscita, quando cioè l’operaio desidera tornarsene a casa: in ore poco propizie alla trattazione di qualsiasi questione e per di più “stans pede in uno” nel cortile o nella portineria (quadro A).
Inoltre, per la maggior parte dei casi l’assistente sociale ha quattro o cinque fabbriche da visitare, e queste sovente remote l’una dall’altra. Tale situazione si verifica specialmente dove si tratta di opifici con poche maestranze (per esempio Aquila; undici fabbriche, due assistenti sociali, due ore di presenze settimanali in ciascuna fabbrica, con la media di trentotto operai per ogni fabbrica). Per di più l’assistente sociale ha anche la responsabilità di un centro sociale con il connesso impegno di molte ore di lavoro.
In queste condizioni l’assistente sociale deve fare il possibile e talvolta anche l’impossibile: adopera il poco tempo con rapidi appunti, precisione, concretezza nelle domande e nelle risposte, poche parole e molti fatti; ciò sembrerebbe poco adatto alla donna, mentre ho già detto sopra che ella è più adatta dell’uomo per la professione di assistente sociale. Certo cosi l’opera dell’assistente sociale e molto complessa, ma l’importante e che ella si faccia vedere, che dissodi a mano a mano il terreno, facendo opera di persuasione presso i dirigenti, e opera di conquista presso gli operai.
Se svolge il lavoro con impegno, gli effetti non tarderanno ad affiorare; ma è necessaria molta costanza e le assistenti sociali in molti casi la mostrano e ne danno l’esempio.
L’assistente sociale nel breve tempo che avvicina gli operai, cerca di ascoltarli con attenzione e con interesse: rispetta le loro idee, i loro desideri; è discreta nel dare i consigli, la sua azione è stimolatrice e rispettosa della libertà individuale dell’operaio.
Anche se non trova il tempo di fare vero case work; fa case work rapido attenendosi principi:
del rapporto assistente-lavoratore attraverso il quale c’è reciproca integrazione e vicendevole scambio di idee, dinamica del colloquio, trattamento psico-sociale, sul piano del rispetto della dignità e personalità del cliente, della personalizzazione dell’assistenza, che la porta ad aiutare l’operaio a prendere le decisioni, a valutare oggettivamente i fatti, sapendo mantenere il segreto professionale;
dell’individualizzazione dell’operaio, rivolgendosi cioè a quello operaio che le sta dinanzi con particolari bisogni, con particolari esigenze e capacità, che può usufruire di alcune risorse e di altre no, usando un trattamento per uno, diverso da quello per un altro;
dell’accettazione dell’operaio come esso si presenta, senza condannarlo, senza dare retta ai pregiudizi, alle apparenze esteriori, al luogo da cui proviene, ma offrendogli una completa comprensione, sapendo dominare le reazioni prima di iniziare qualsiasi diagnosi, e assumere un atteggiamento sereno e comprensivo;
dell’autodeterminazione dell’operaio perché egli sia libero di fare le sue decisioni e di sceglierle, perché senta lui la responsabilità su di sé, limitandosi ad esser stimolatrice ed a rispettare la di lui libertà. Questo è importante ogni volta che l’operaio vuole risolvere anche una semplice pratica. Egli facilmente affiderebbe tutto all’assistente sociale « che invece in base ai detti principi lo guida a capire come deve fare », cioè ad agire da solo.
Nei brevi contatti con l’operaio i l’assistente sociale è sempre vigile e attenta, con l’attitudine interiore ad accoglierlo, a riceverlo, a interessarsi di lui; evita distrazioni e lo segue nei suoi gesti e nei suoi movimenti cercando soprattutto di metterlo a suo agio.
9. Disponibilità di un ufficio accessibile agli operai
Le assistenti sociali entrano dell’organismo della fabbrica e accettano la condizione concreta che trovano; non sempre sono bene accolte, e sia gli operai che i dirigenti mostrano diffidenza nei loro confronti.
Nonostante ciò, l’assistente sociale, mossa dal suo spirito d’azione, accetta quel che trova, poi cerca di avvicinare gli operai. Sa che essi hanno bisogno di lei, della sua pratica, di una buona parola, di un consiglio, di una – informazione. Rotto il primo gelo, gli operai a mano a mano si avvicinano a lei, perché si accorgono che l’assistente sociale rende loro dei servigi utili. È così? Che essi allora si recano spontaneamente all’ufficio di lei, le raccontano le loro preoccupazioni e chiedono dei consigli.
Dalle notizie inviate dalle assistenti sociali, risulta chiaro che esse non hanno sempre un ufficio personale; infatti delle 230 fabbriche esaminate, soltanto 136 (la metà) hanno un ufficio proprio e facilmente accessibile agli operai (Piemonte – Emilia – toscana). Delle altre 94 fabbriche 15 danno la possibilità all’assistente sociale di recarsi nelle mense aziendali, mentre gli operai consumano il pasto, 12 lasciano che l’assistente incontri gli operai in portineria (Piemonte 4, ROMAGNA 3, SICILIA 4, ABRUZZO 1); in 9 fabbriche l’assistente si reca nei reparti di lavoro, in 2 utilizza l’infermeria. Un assistente riceve nel CRAL aziendale, 9 assistenti condividono l’ufficio con la segreteria e con la direzione (Piemonte e ROMAGNA), una riceve gli operai nel magazzino, e le assistenti di 22 fabbriche, non avendo la possibilità di accedere in fabbrica, invitano gli operai al Centro sociale della zona, negli orari fuori lavoro (quadro A).
Tutto questo dimostra come il servizio non sia del tutto sviluppato, e fa vedere come la resistenza si incontri più dalla parte dei dirigenti, che da quella degli operai. L’assistente sociale che dispone di un ufficio facilmente accessibile agli operai, con più tranquilità svolge il suo lavoro: può attuare il rapporto professionale con i lavoratori, ne può conoscere i bisogni relativi a lui e alla sua famiglia. Dal canto suo il lavoratore, uscendo dalla massa, nell’ufficio si sente più a suo agio, espone serenamente le sue preoccupazioni e accetta l’aiuto che l’assistente gli dà.
Nelle fabbriche delle città di Torino, Parma, Modena, Arezzo, Napoli, l’assistente ha un proprio ufficio, mentre ha trovato molta resistenza presso le fabbriche di Siracusa, di Latina, di Gaeta, di Rimini, perché i dirigenti apprezzano ancora poco l’opera della assistente sociale.
Si spera che un giorno tutte le assistenti sociali possano disporre di un ufficio, ma per ottenerlo debbono fare appello alla comprensione dei dirigenti; occorre anche il « savoir faire » delle assistenti sociali, perché con la loro abilità professionale riescano ad ottenere l’adesione dei responsabili dell’azienda.
Riusciranno a ciò indirettamente, cioè lavorando a vantaggio degli operai, esaurendo le loro richieste, facilitando un clima di buone relazioni umane, di interesse al lavoro. Quando s’avvede di ciò, il datore, e il dirigente responsabile vede i benefici del servizio e può approvare volentieri la concessione di un ufficio, perché ne vede la validità. Molti dirigenti si chiedono che cosa faccia l’assistente sociale nella fabbrica e non sanno rispondere all’interrogativo che si pongono, magari perché agli inizi dell’attività dell’assistente è poco evidente. Quindi accettano che essa entri nella fabbrica, e aspettano di vederne gli effetti.
10. Formulazione di un piano di lavoro
L’assistente sociale che entra a lavorare in una fabbrica formula un piano organico di lavoro che rispetti i bisogni e gli interessi dei singoli lavoratori, delle esigenze di gruppo e della vita della comunità di fabbrica.
Dalle notizie inviate dalle assistenti sociali che lavorano nelle 230 fabbriche in esame, si rileva che in 133 di esse, le assistenti preparano un regolare e ordinato piano di lavoro, mentre in 46 non resta possibile formularlo per la limitatezza eccessiva del tempo.
Qualche assistente formula un piano annuale di lavoro valido per un certo tempo, ma nello svolgere la sua attività tiene sempre conto degli interessi degli operai. Riporto alcuni esempi, che stanno a dimostrare la diversità di iniziativa tra un’assistente e l’altra.
— una assistente sociale Torino:
« Formulo un piano annuale che prevede l’assistenza ordinaria, la assistenza straordinaria, le colonie estive, salvo le modifiche in casi di variazione della situazione ambientale (crisi di lavoro ecc.) ».
— un’altra assistente sociale Torino:
« Svolgo uno studio concernente i bisogni dell’individuo per giungere ad uno studio sui bisogni del gruppo e della collettività di fabbrica ».
14. Attività che maggiormente svolge l’assistente sociale nella fabbrica
Le assistenti sociali delle fabbriche in questione affermano di svolgere molto lavoro di patronato, di seguire casi individuali e di fare raramente lavoro di gruppo (quadro E).
Dalle loro risposte è difficile stabilire se usino il « case work » come metodo di servizio sociale, ne è possibile fare una percentuale precisa sulla attività maggiore che ciascuna attua.
Risulta chiaramente che svolgono in prevalenza lavoro di patronato, pratiche o documenti vari. Esse lo svolgono per servire l’operaio, e attraverso ad esso attuano concrete ed utili prestazioni.
Specialmente agli inizi del servizio sociale in una fabbrica, l’assistente sociale è per gli operai « La signorina delle pratiche », e si avvicinano a lei per risolvere una pratica di pensione, di affiliazione, di matrimonio, ecc. Da questi contatti, e molto spesso del contenuto delle pratiche, si rivelano problemi gravi del lavoratore, preoccupazioni tenute nascoste, dubbi e anche rancori che affiorano.
L’assistente segue numerosi casi anche relativi ai familiari, cercando di contribuire alla migliore soluzione possibile.
L’attività di gruppo è ancora poco sviluppata ed è resa più difficile per la scarsa disponibilità di tempo che hanno le sociali.
Corso residenziale sui problemi del servizio sociale di fabbrica
Organizzato dalla Direzione regionale dell’Onarmo, ha avuto luogo a Cagliari, dal 21 al 27marzo, un corso residenziale autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione al quale hanno partecipato venti assistenti e collaboratori sociali di fabbrica
Il programma del corso che riguardava “i problemi del servizio sociale”, comprendeva la trattazione dei seguenti temi: La vita di fabbrica – Psicologia del mondo operaio – Tecnica della discussione – Relazioni Umane e opera di formazione fra gli operai – Servizio sociale: la visita domiciliare. – L’apprendistato nell’industria – L’istituto di patronato ONARMO – Legislazione sociale – Prevenzione infortunistica e igiene d’ambiente – Attività culturale e ricreative di fabbrica.
Le lezioni del corso sono state tenute da esperti e specialisti delle rispettive materie.
La Direzione Generale dell’ONARMO era rappresentata dall’Ass. sociale signorina Marcella Rampini che ha tenuto alcune interessanti lezioni nel corso dell’intensa settimana di studi.
Il Servizio Sociale nell’impostazione della POA e dell’ONARMO, 6, 1960, pp. 2-5.
Il quadro del Servizio Sociale così come è stato concretizzato dall’ONARMO e dalla POA è talmente complesso che, se potrebbe sgomentare come oggetto di una relazione sintetica, osservandolo nel suo insieme apparisce uno strumento ricco di raccordi con la realtà sociale, costruito in maniera tale da poter toccare quasi tutti i settori della vasta fenomenologia del bisogno umano.
La denominazione unica di à« Servizio Sociale à» estesa alle varie articolazioni di questo complicato strumento, deriva dall’essenziale loro natura unica; ma i diversi dispositivi che consentono le varie differenziazioni di impiego, si configurano ai vari ambienti o categorie nei quali esso agisce.
Nomino subito questi settori del Servizio Sociale, nell’unica prospettiva che li collega uno col’altro, che forse non troppo spesso consideriamo.
Oggi il Servizio Sociale ONARMO-POA si ramifica in diverse articolazioni:
1. Servizio Sociale di Fabbrica;
2. Servizio Sociale Rurale;
3. Servizio Sociale Ferrovieri;
4. Servizio Sociale Ospedaliero. Ed in collaborazione con la POA:
5. Centri Sociali Parrocchiali ed interparrocchiali;
6. Centri Sociali Comunitari;
7. Servizio Sociale Scolastico;
8. Servizio Sociale PP.UU. e Comunità di Lavoro;
9. Servizio Sociale Emigranti che fa Segreteria burocratica per tutti questi Servizi della Segreteria Provinciale dell’istituto ONARMO di Assistenza Sociale, Patronato riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 9 marzo 1948, pubblicato il 20 marzo successivo sulla Gazzetta Ufficiale.
Tali Servizi fanno capo, in loco al Delegato Regionale e al Delegato Diocesano ONARMO; ovvero al Delegato Regionale e al Delegato Diocesano POA, ossia dipendono direttamente da loro.
1) Servizio Sociale di Fabbrica
Il Servizio Sociale di Fabbrica è certamente il più antico, e, direi, connaturale con l’Onarmo che nacque, si può dire, dando ad esso la vita.
Evidenti gli scopi del Servizio che si desumono dalla maestranza cui è rivolto, la quale solamente da poco tempo è stata riavvicinata dall’apostolato, dopo il grande “scandalo del secolo” ossia dopo la sua pratica separazione da esso. Ma la maestranza operaia permane ancora adesso base di manovra di una politica che ha avuto tutto il tempo di porre in essa radici più profonde, e che la pervade, purtroppo ancora alimentando in essa il conflitto e la lotta di classe.
Il proposito di entrare nel recinto aziendale a predicarvi il Vangelo, motivo essenziale del programma dell’ONARMO, fu veramente coraggioso; e, come tale, degno di raccogliere frutti straordinari quali il riuscire, là dove è entrato, ad inserirvi permanentemente il sacro Ministero dei Cappellani del lavoro.
Il Servizio Sociale ONARMO, che fiancheggia l’apostolato dei cappellani, viene svolto dalle assistenti sociali, e partecipa la medesima finalità. Esso avvicina gli operai, si mette a loro disposizione introducendo legami umani nell’azienda, rimasta ancora una entità economica, lontana dal divenire una comunità, per mancanza di fede nei mezzi autentici, sociali etici e spirituali di una esistenza possibile, anzi amichevole, in cui ambedue gli elementi della produzione possano considerarsi fondamentali, non solamente economicamente, ma anche come cellule di un medesimo corpo, la cui salute reagisce diversamente a seconda della sua sanità costituzionale, ossia integrale. Si parla oggi tanto, nelle aziende, di “Relazioni Umane”, e si praticano in esse. Tutti crediamo che il nostro metodo di assistenza di fabbrica debba limitarsi attualmente a tale metodo. Ma sembra insieme, della massi importanza che il Servizio Sociale conservi la sua nota fondamentale di differenziazione dalle “Relazioni Umane”. Differenza che si trova non tanto negli scopi, quanto nel contenuto caratteristico di servire, che è proprio dell’assistenza di fabbrica, ossia di consistere o, se volete, di fiorire in prestazioni utili, concretamente, praticamente.
Bene lo stabilire un clima favorevole nell’azienda, ma ricordiamoci che il clima favorevole, l’atmosfera di distensione, sono piuttosto conseguenze di azioni, e non premesse, ovunque gli animi non hanno predisposizioni reciproche benevole. I colloqui degli esperti di R.U. Sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratori sono possibili, sì, ma là, dove esiste già un dialogo, ossia ove è già in atto una conversazione con la maestranza. Conversazione la quale, i cappellani del lavoro lo sanno bene, è un frutto non tanto di una consuetudine, ma piuttosto di una fiducia determinata da prove concrete di lealtà, di interessamento, di bontà vissuta nel rapporto con i lavoratori.
Ecco perchè l’assistente sociale di Fabbrica svolge servizi sul piano della consulenza ammirativa, previdenziale, assicurativa, e sul piano assistenziale propriamente detto, secondo i metodi del contatto individuale; e svolge iniziative di gruppo sul piano culturale, ricreativo, con la partecipazione attiva dei lavoratori, allo scopo di facilitare la promozione dell’uomo operaio, al raggiungimento dell’equilibrio tra le sue risorse personali e quelle del gruppo prima, e poi della comunità in cui vive.
Si potrebbe parlare a lungo sull’argomento, ma lo spazio è poco. Questi metodi vanno di nuovo messi al fuoco dello studio, perchè divengano più coscienti e meglio finalizzati; ma essi, a livello diverso vengono, oggi nell’ONARMO applicati in 777 stabilimenti industriali, da 370 assistenti e collaboratori sociali, presso 28 Delegazioni Regionali.
2) Servizio Sociale Rurale
Il discorso non è diverso per il servizio sociale rurale ove in parte la storia dell’allontanamento delle persone da Dio è la medesima, almeno in alcune regioni d’Italia centrale, ove da più di 30 anni i rurali sono la base di movimenti anticristiani.
Scopo del servizio sociale rurale è anche qui di migliorare le Relazioni Umane, tra conduttori e lavoratori, con un’azione di accostamento personale non attuata mai, nel corso della storia, se non dalla Chiesa (vedi le profonde e documentate tesi del Manzoni sulla opera sociale di essa) che dall’epoca della caduta dell’impero Romano, ha sostituito in questo compito un potere laico etico, ricomparso assai più tardi. Azione di educazione, interrotta dallo stesso corso della storia, non ripresa più, se non in alcune Regioni d Italia (ad es. Lombardia), e non in altre, in qualche momento.
L’entrare delle assistenti Sociali dell’ONARMO nelle remote tenute o nei casolari dispersi, visitare le cascine dei proprietari di riso, durante la campagna della monda, non è Servizio Sociale meno nuovo di quello di fabbrica, anzi è assai più recente di esso.
Attraverso tale servizio si promuove l’elevazione sociale e culturale dei rurali e si collabora indirettamente al miglioramento economico del loro mondo, dopo averlo studiato accuratamente, stimolando nelle persone un ricorso intelligente alle molteplici, sue possibili piccole industrie marginali, familiari o artigiane; ed avviandolo all’addestramento professionale al quale non riesce sempre da sé ad orientarsi.
Il Servizio Sociale Rurale è svolto nell’ONARMO da 51 assistenti sociali rurali. Ogni anno per la monda sono utilizzate assistenti sociali le quali prendono contatto con le mondine, le seguono nelle cascine, le visitano in ospedali (cfr. n. 4 di Incontriamoci di questo anno).
3) Servizio Sociale dei Ferrovieri
Non so la storia di questo servizio; nè la fisionomia di questa categoria speciale mi era nota prima che l’ONARMO ne assumesse l’assistenza nelle officine meccaniche di costruzione e riparazione, nelle squadre rialzo dei binari, ambienti di lavoro non molto dissimili da quelli delle fabbriche e dei cantieri; ma anche nelle stazioni, con il personale il più mobile per definizione, il personale viaggiante, e nell’ambito così nuovo e così eteroclito del compartimento e del pubblico. Certo è il successo è stato tale da estendere il servizio da questi luoghi agli abitati dei ferrovieri, agli asili e doposcuola e colonie per i loro figlioli.
L’ONARMO lavora oggi in 14 compartimenti ferroviari, con 49 assistenti sociali, che fiancheggiano i Cappellani Compartimentali ed i Cappellani Ausiliari.
Nel campo delle ferrovie l’ONARMO ha affrontato il problema dei « Centri di Relazioni Umane » per la preparazione degli esperti di R.U. i quali debbono operare negli ambienti di lavoro con tale incarico.
A questo proposito desidero ricordare un’interessante studio propedeutico alla instaurazione delle R.U. nelle ferrovie, consistente in una tesi di diploma di un allieva di una nostra scuola, la quale ha analizzato una situazione di contrasto tra uno dei capi più stimati, ma avversato da tutto il personale dipendente del suo reparto. L’allieva ha studiato le ragioni del conflitto che esistevano in attitudini psicologiche, non armoniche di questo capo, nei vari momenti della sua direzione, le quali frustravano aspettazioni legittime e naturali dei suoi dipendenti, provocando reazioni veramente notevoli, che avrebbero potuto essere evitate facilmente.
Il lavoro è rimasto riservato, ma ha dato certamente un contributo alla questione della formazione dei capi.
4) Servizio sociale emigranti
Anch’esso è antico, ancor più del Servizio Sociale di Fabbrica nell’ONARMO; e gli emigranti, come lavoratori non facenti parte dell’unità aziendale impenetrabile, ma proiettati nella solitudine spaventosa della partenza e della lontananza, sono stati oggetto dell’apostolato dell’ONARMO sui lavoratori italiani.
Oggi la POA e l’ONARMO gestiscono servizi di sosta importantissimi a Roma, e di frontiera a Milano, Verona, presso il porto di Napoli e dirige con diverse attività di Servizio Sociale, Centri Sociali in Francia, Germania, Belgio, Tunisia.
L’assistenza segue l’emigrante dal momento della partenza, via via attraverso i posti di documentazione e di selezione sino al passaggio dei confini; e lo aspetta al luogo di destinazione all’estero. Lo segue attraverso l’azione diretta e minuta delle assistenti sociali mediante una esatta compilazione di schede personali e familiari, che avviene in Italia, e si completa al momento della destinazione da parte delle Commissioni straniere; schedina che viene poi ritornata sia al Delegato Diocesano ed al Parroco del paese di provenienza dell’emigrante, come all’assistente sociale ONARMO all’estero nella cui zona rientra il luogo di lavoro dell’emigrato.
5) Servizio Sociale Scolastico
È di recente istituzione e viene curato dal Prof. Manzia: lo definiscono con le espressioni stesse da lui adoperate:à« Scopi del Servizio Sociale Scolastico sono:
1) il recupero alla Scuola degli inadempienti all’obbligo scolastico e degli iscritti che disertano;
2) il contatto con i ragazzi al fine di aiutarli a superare le difficoltà che incontrano nell’adempimento del loro dovere scolastico, di seguirli nelle loro necessità familiari, sanitarie, sodali; di inserirli nelle attività invernali ed estive della POA al fine di sostenerli con adeguato servizio spirituale, sociale, morale e fisico;
3) la segnalazione alle Autorità locali di particolari necessita alle quali non può essere provveduto, diretta mente dalla Presidenza POA, ma che sono maggior rilievo da portare a conoscenza delle Autorità Centrali;
4) il collegamento tra l’attività a favore della gioventù che svolge l’attività della scuola ai fini di un armonico lavoro educativo ed assistenziale;
5) il contatto con le famiglie dei ragazzi affinchè la fraterna comprensione e la cristiana sollecitudine ne nell’aiutare i genitori nel risolvere alcuni problemi con maggior serenità, allontani anche cause turbamento dei piccoli, motivi spesso di insidia spirituale;
6) l’apostolato tra i fanciulli per il loro impegno, per la serenità delle loro famiglie. A questo servizio sono addette 44 maestre comandate dal Ministero P. I.
Seminano sul Servizio Sociale di impresa delle Assistenti Sociali di Fabbrica ONARMO, 7-9, 1960, pp. 3-36.
La redazione, Roma, 1-10 Settembre 1960
Il Servizio Sociale di Fabbrica dell’ONARMO è un’attività adeguata ai metodi professionali del Servizio Sociale ed alle tecniche razionali odierne. È adeguata ad essi nella sua concezione, come nell’organizzazione e nel rendimento. Ma lo spirito che l’anima è quello eterno e sempre nuovo del Vangelo, che ci ha insegnato la teologia perenne, imperniata sulla fraternità. Il Vangelo da annunziare ai poveri, da predicare a tutte le creature, ai minatori, ai fornaciai, ai guardafili, ai calibristi, ai palombari, ai pescatori, alle dattilografe, alle modiste, agli studenti. Ma anche a coloro che amministrano il denaro delle imprese, delle miniere, delle centrali elettriche; dei cantieri navali, agli agricoltori, ai commercianti, ai direttori di uffici, ed agli industriali. Poichè l’eccessivo lavoro come l’eccessivo denaro e le preoccupazioni del lavoro e del denaro e degli affari, ostacolano le vie della spiritualità; ed il Vangelo apre spiragli di insondabili speranze agli oppressi dalla fatica ed agli oppressi dalla ricchezza, sollevandoli dalle loro sollecitudini, stanchezze, presunzioni e sfiducia ; crea, tra di loro, una comunità purificata nel senso della eguaglianza di fronte a Dio e della loro individuale insufficienza, sin tanto che essi non giungano, come tutti dovrebbero, all’Amore.
Presidente del Seminario…S. E. Mons. F. Baldelli – Vescovo di Aperle
Vice Presidente del Seminario…S. E. A. D’Eufemia – Direzione Generale S. S. ONARMO
Direttore del Seminario…P. G. Santoro O. P. – Direttore Coordinamento Scuole S. S.
Produzione materiale tecnico – Dott.sa V. Delmati – Segretaria Generale Coordinamento Scuole Servizio Sociale
Assistenza Tecnica ai gruppi…Prof.sa T. Bosco della Direzione Generale S. S. ONARMO
Segretaria del Seminario…A. S. M. Rampini – Ispettrice Servizio Sociale di Fabbrica
Ufficio…Sig.ra Anna Sartori Scalco
Sig.na Oceana Summa
Programma
2 settembre – ore 9,30: S. E. Mons. Baldelli: parole di saluto alle partecipanti; Ing. Vito Santoro: à«Organizzazione Aziendale di uno stabilimento industriale moderno. Strutture funzionali ed amministrative, schema degli scopi diretti della produzione. Rapporti con l’elemento umano: i lavoratori ».
3 settembre – ore 9,30: S. E. Dr. Fiorentino Sullo, Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale: «L’incidenza delle risorse umane, tecniche ed economiche sulla attuale felice congiuntura italiana ».ore 11,15: On.le Bruno Storti Presidente C.I.S.L.: «Problematica sindacale attuale, determinata dallo sviluppo tecnico industriale».
4 settembre: Gita a Grottaferrata ed a Castel Gandolfo.
5 settembre – ore 9,30: Prof. R. Tommassetti: «Psicologia del lavoratore».
ore 11,15: On.le Silvio Gava: « Soluzioni italiane ai problemi economici e sociali che scaturiscono dall’automazione ».
6 settembre – ore 9,30: Dr. Giuseppe Petrilli, Presidente Gruppo Sociale Comunità Europea: « Mobilitazione della mano-d’opera e servizi sociali aziendali ». Ore 11,30: Varie Assistenti Sociali: discussione sul ruolo dell’« Assistente Sociale di Fabbrica ».
7 settembre – ore 9,30: Prof. Achille Ardigò: « Urbanesimo e lavoro industriale à». ore 9,30: varie Assistenti Sociali: « Caratteri particolari del Servizio Sociale di Fabbrica (responsabilità, compiti, rapporti)». «Metodi del Servizio Sociale di Fabbrica à».Continua la discussione di un gruppo di Assistenti.
8 settembre – ore 9,30: On.le Del Vescovo: «Inchiesta parlamentare sulla Fabbrica».
ore 11,15: Padre Policarpo: «Apostolato dei Cappellani del lavoro Onarmo ».
9 settembre – ore 9,30: Prof. Gaetano D’Anneo Primario Direttore Policlinico del « Qualche illustrazione delle possibilità di contenzioso in or del Patronato Assistenza à».
10 settembre – ore 9,30: Maria Ciolli: « Esperienze della più giovane assistente di Fabbrica
Conclusioni del Seminario.
Prolusione di S. E. Mons. Presidente:
Innanzi tutto mi compiaccio vivamente con voi che abbiate risposto al nostro appello di venire qui a Roma per approfondire la vostra missione negli stabilimenti industriali. Nessuno più di noi ammette grande importanza alla qualificazione e alla sensibilizzazione di coloro che sono addette al Servizio Sociale di Fabbrica.
Io credo che anche voi desideriate a-vere qualche notizia dell’organismo al quale già appartenete, organismo che ormai ha molti anni di vita (è dal 1923 che noi abbiamo iniziato l’attività negli stabilimenti industriali). La nostra Opera ha avuto varie evoluzioni durante il suo sviluppo. Ma se anche l’inizio è ormai molto lontano è anche molto costruttivo il fatto che io riferendomi ad allora non ho da cambiare la formula essenziale di quel programma. Noi siamo nati chiamandoci « Comitato Romano Pro-Emigranti »; successivamente, nel 1926, la nostra denominazione cambiò in « Comitato per l’assistenza religiosa e spirituale ai lavoratori ».Nel periodo 1923-1926 c’era una gran-corrente emigratoria transoceanica e a quel settore dedicammo specificante la nostra attività. Avemmo anche degli uffici presso il Consolato degli Stati Uniti d’America perchè il nostro pensiero era di non rimanere estranei all’azione degli Enti che incidevano profondamente nella vita della nostra popolazione. Fin da allora sentimmo la necessità di lavorare negli ambienti ove passava l’emigrazione per dare un tono decisamente spirituale e morale all’assistenza. Quando poi le condizioni interne dell’America cambiarono e si fermò la corrente emigratoria, la nostra attività in quel settore ebbe una pausa. Nel 1926 incominciò a svilupparsi l’industria nazionale e si pose la considerazione chiara e precisa di tutti i problemi che si accompagnavano al nuovo fenomeno: la mobilità di mano d’opera e quindi il problema della immigrazione interna e dell’adattamento delle nuove leve di lavoro alla diversa vita sia materialmente che spiritualmente. Quando a Roma cominciò a svilupparsi l’industria e cominci ad arrivare nella città molta gente per lavoro, presentammo ad alcuni operatori economici un programma di assistenza integrale agli operai, ponendo in luce tutte le loro esigenze; e la necessità di far rivivere nell’anima loro il Volto Santo del Signore. Quando ci presentammo agli industriali che chiedevano il nostro apporto alla loro azienda, aderimmo; ma curammo di mantenere sempre la nostra autonomia, ed i nostri principi. Ottenemmo sempre, negli stabilimenti, piena libertà di azione: eravamo noi che ospitavamo nei nostri recinti assistenziali gli industriali. Quindi costituimmo due Convitti: i primi nell’Italia Centrale. In quel tempo i nostri Convitti si chiamavano « Gabbie d’Oro » nel senso che la vita degli ospiti era regolata sotto tutti gli aspetti, sul piano dell’integrità morale, della salute fisica, e della vita educativa e culturale. Questi Convitti che, in definitiva, erano alberghi, avevano la nostra impronta, ma non avevano niente che reprimesse la libertà personale, ma anzi, la affrancavano. Qualche volta, all’occorrenza, abbiamo cercato di salvaguardare l’integrità morale delle persone e l’amore per le famiglie. Era bello vedere i lavoratori raccogliersi nella Cappella e recitare il Santo Rosario per chiedere al Signore la forza di agire bene. Era bello anche vederli ogni quindicina del mese, al momento della consegna della paga, chiederci di aiutarli a spedire una cartolina – vaglia per mandare il denaro alla famiglia (spesso non erano capaci di farlo da sé). Da quel tempo, dal 1926 in poi, noi pensammo che era possibile negli stabilimenti compiere una attività assistenziale a carattere umano.
Voi oggi siete Assistenti Sociali di Fabbrica, ma non potete e non dovete dimenticare l’Organismo al quale appartenete e quello che esso intende fare: svolgere una attività sociale che contempli integralmente le esigenze della persona umana. Tutte le sue esigenze noi dobbiamo considerare nei lavoratori affinchè essi possano trovare nel nostro organismo aiuto a soddisfarle. Voi AA.SS. di Fabbrica rappresenta un settore importante quanto mai; ma un settore che deve armonizzare la sua attività con quella dei Cappellani del Lavoro. Voi rappresentate un movimento di avanguardia, antesignano, di approfondimento di situazioni dei singoli, delle famiglie, delle categorie; ma in sincronia con tutte le attività di contorno.
Quale è la figura dell’Assistente Sociale negli Stabilimenti? È la figura del Missionario. Tutto quello che è tecnica deve servire per affinare lo spirito veramente cristiano. Cerchiamo di comprendere a pieno quella che è la missione alla quale il Signore ci ha chiamato; il nostro non è un lavoro burocratico, ma deve essere un lavoro che esce dal cuore, dall’anima, che prenda tutto il nostro essere per portarlo vicino al lavoratore che ha necessità e che per questo chiede il nostro appoggio.
Affinchè l’Assistente sociale di fabbrica possa compiere così il suo lavoro non dovrà mai disgiungere la sua opera da quella del Cappellano di Fabbrica. Egli raccoglie anche quelli che sono risultati del vostro lavoro. Il vostro lavoro non deve avere la freddezza del lavoro comune, ma avere anima e spirito di apostolato, occorre siate vicine al ministero del Sacerdote, il quale attende a portare le anime al Signore.
Voi rappresentate l’avanguardia negli stabilimenti. Prescindendo dall’attività, assistenza vera e propria, guardate innanzi tutto quello cui deve tendere il vostro spirito. Dovete considerarvi un movimento d’avanguardia che si china su situazioni che senza di voi non sarebbero conosciute. Il servizio Sociale c’è in tanti stabilimenti, in tanti uffici; ma noi dobbiamo chiederci: gran parte di questo Servizio Sociale è come noi desideriamo? È una domanda che merita molta considerazione. Innanzi tutto l’assistente sociale di fabbrica deve conoscere la organizzazione aziendale per poter comprendere meglio le difficoltà e le necessità degli operai. Lo stabilimento che in modo particolare ho praticato è quello della Viscosa. Nello stabilimento della Viscosa noi vedevamo la diversità di orientamento anche spirituale che derivava all’operaio dalla natura del lavoro che svolgeva. Il nostro dovere era quindi quello di conoscere le attrezzature di ogni reparto per poter appurare in cosa si cimentava la vita dei lavoratori; quando noi giravamo tutti i reparti, ci rendevamo conto delle loro diverse reazioni e non potevamo non comprenderli. Dobbiamo cercare di capire la Psiche del lavoratore risalendo alle difficoltà del lavoro. Questo è un problema da porre a ciascuna di voi perchè ognuna approfondisca le varie situazioni. Non ci dobbiamo limitare ad avviare le pratiche (anche se questo è necessario per collaborare alle leggi di previdenza) ma il vero compito della buona Assistente Sociale di Fabbrica è quello di conoscere l’uomo sullo sfondo di tutti i reparti di cui è costituito lo stabilimento; di riuscire a conoscere le diverse categorie, esaminarne le diverse esigenze per divenire non tecnici della lavorazione, ma di azione sociale formativa ed educativa. Io credo che dovremo fermarci a questo punto e ciascuna di voi interrogarsi se concepisce il Servizio Sociale in questa formula.
L’ONARMO desidera che tutte le attività di ordine morale, sociale e spirituale siano armonizzate per formare il lavoratore. L’uomo non vive di solo pane; innanzi tutto secondo il Vangelo noi dobbiamo curare la vita dello spirito. Allora più facilmente risolveremo anche le più aspre questioni di carattere economico e sociale. L’industrializzazione va considerata come naturale conseguenza della ricerca scientifica, applicata alla realtà pratica. È quindi un portato dello spirito nella sua graduale scoperta ed utilizzazione delle risorse, poste da Dio a disposizione dell’uomo. Occorre perciò sia rivolta a raggiungere tutti gli uomini, ed a servirli nella attuazione del loro perfezionamento personale e di quello della Comunità.
1° STRUMENTO DI LAVORO
a) Necessità di aggiornamento del Servizio Sociale di Fabbrica
Il Servizio Sociale d’impresa di oggi – Caratteristiche
L’evoluzione del Servizio Sociale di Fabbrica dipende da quella della azienda industriale, attualmente in atto. Oggi l’unità aziendale si concepisce e si realizza, non già come puro convogliamento di forze meccaniche, amministrative e tecniche, ma come specifica funzione sociale in vista della sua importante incidenza nella vita complessiva del Paese. Tale funzione, che si attua oltre che su elementi economici e tecnici, anche attraverso l’apporto umano, include gravi responsabilità sociali. I problemi aziendali « si sostanziano oggi in problemi dei dipendenti, cui si chiede molto, in termini di costo umano, per l’indispensabile sviluppo dell’azienda» (Tesi di diploma dell’A.S. Gianna Manzoni «Analisi dell’inserimento del Servizio Sociale, con particolare riferimento ai rapporti con il Servizio del Personale in una azienda a carattere familiare in fase di riorganizzazione à» Milano 1959.). L’azienda cioè viene ad assumere « una missione sociale» nei confronti dei suoi dipendenti, ossia il compito di garantire agli uomini che collaborano alla produzione la possibilità di raggiungere, attraverso il lavoro organizzato, la concretezza del loro destino di esseri umani («Servizio Sociale nelle imprese» – Studi del Segretariato di Servizio Sociale UCID – Milano 1956, pag. 9.). Si può oggi sempre di più considerare l’azienda come una comunità ben definita.
b) Differenziazione del Servizio Sociale di Fabbrica
Premessa. « L’individualizzazione dell’ambiente nel quale e per il quale il Servizio Sociale di Fabbrica oggi opera, consente di comprendere come e perchè esso abbia perduto, nel tempo, il carattere di genericità e di polivalenza che lo distinguono, e sia andato qualificandosi come Servizio Sociale specializzato, avente fondamentalmente riguardo ai problemi che incidono sul comportamento dell’operaio sul lavoro » (Franco Ventrice «Servizio Sociale di Fabbrica graduale trasformazione», Atti del Convegno di Milano, 14 maggio 1958, p. 4). Il Servizio Sociale di Fabbrica trova la sua ragion d’essere e si caratterizza non più su da una eventuale assistenza economica ai lavoratori in condizione di bisogno, nè dalla produzione di numerose pratiche amministrative utili a loro, ma « dalla responsabilità sociale dell’impresa di offrire concretamente i mezzi per soddisfare i bisogni umani che nascono nel proprio ambiente di lavoro. Fra i mezzi che oggi si ritengono indispensabili, perchè una impresa moderna consegua i suoi intenti sociali, vi è il Servizio Sociale » (« Servizio Sociale dell’impresa », già citato, ibidem). Il lavoro e l’ambiente di lavoro includono condizioni e difficoltà speciali che richiedono una formazione altamente specializzata dell’assistente sociale. La complessità dei problemi umani e la loro frequente connessione con l’organizzazione azienda esigono per la loro soluzione 1’inserimento, nella struttura aziendale, di un organismo specifico che abbia la possibilità di dedicarsi alla loro soluzione (Gianna Manzoni, tesi cit.).
Allegato al 1° strumento di lavoro. Differenziazione del Servizio Sociale rii Fabbrica
Il gruppo di Studio Internazionale sulle funzioni e j metodi di lavoro degli Assistenti Sociali Aziendali, nelle riunioni di Zurigo del settembre 1957 e di Dortmund del marzo 1959, asserisce che i problemi non inerenti al lavoro aziendale, debbono, per competenza, essere passati dal Servizio Sociale di Fabbrica ad altri Servizi Sociali appropriati, mentre gli altri Servizi Sociali dovrebbero rimettere al Servizio Sociale Aziendale i problemi che hanno la loro origine in situazioni inerenti al lavoro. Il ‘gruppo, pur definendoli insufficienti, dà i seguenti motivi di tale smistamento.
a) i lavoratori e le loro famiglie sono membri anche di comunità più vaste che dovrebbero assumere la responsabilità dei loro membri.
b) la vita privata del lavoratore dovrebbe essere, nella massima misura possibile, rispettata.
c) il lavoro e l’ambiente di lavoro fanno sorgere condizioni e difficoltà speciali che richiedono un alto grado di adattamento. Se si vuole prestare aiuto per risolvere efficacemente i problemi che si pongono, occorre una formazione specializzata che si aggiunga alla formazione di base relativa al Servizio Sociale (Rapporto del gruppo di Studio Internazionale sulle funzioni ed i metodi di lavoro degli Assistenti Sociali Aziendali, Edizione Confindustria, 1960, pag. 8).
Recensione relativa al primo strumento di lavoro. Il Servizio Sociale nelle imprese d’oggi (considerazioni ed esperienze delle Assistenti Sociali, Segretario di Servizio Sociale UCID, Milano, 1956).
Il contenuto dell’opuscolo è assai pregevole e bene impostato. Si sviluppa in « Servizio Sociale nella moderna società industriale»; «Servizio Sociale e Relazioni umane»; «Assistenza in caso di bisogno economico»; « Assistenza ai casi di disadattamento al lavoro »; « Servizio Sociale e cura del fattore umano nell’impresa»; Sensibilità imprenditoriale per l’organizzazione del Servizio Sociale nel Mezzogiorno d’Italia »; « Il Servizio Sociale nelle imprese attraverso le realizzazioni della UCID ». Molto valido il primo articolo che differenzia nettamente il Servizio Sociale di azienda dagli altri Servizi, in base alla concezione moderna di azienda.
Dopo aver individuato « nel precetto evangelico della carità del prossimo e della giustizia sociale » il concetto ispiratore del Servizio Sociale e quindi dopo averlo riallacciato « alla perenne pratica della carità cristiana e della umana solidarietà» si espone la interpretazione moderna del bisogno, considerato come fatto sociale alla cui soddisfazione deve provvedere la comunità attraverso una « persuasa, convinta, disciplinata formazione di quei rapporti che son destinati a garantire il maggiore e migliore rendimento dell’atto assistenziale ». Funzione del Servizio Sociale in genere è « la considerazione e la valutazione dei bisogni umani secondo le esigenze, le esperienze di vita di ogni individuo; ed il concorrere al soddisfacimento dei bisogni individuali, utilizzando le risorse sociali ».
Gli scopi del Servizio Sociale sono: la ricerca delle cause del disadattamento; la possibilità di modificazione di ambiente sul piano individuale o di gruppo; gli sforzi per rendere più efficienti le risorse.
La funzione del Servizio Sociale di azienda è specifica:
« Il mondo industriale e commerciale riconosce che attualmente l’azienda non solo è una organizzazione economica o istituzione tecnica, ma un fenomeno specifico della vita sociale ». In questo senso le si riconosce « una missione sociale » ossia il compito di garantire agli uomini che collaborano alla produzione « la possibilità di raggiungere, attraverso il lavoro organizzato, la completezza del loro destino di esseri umani » (già citato).
La responsabilità sociale dell’impresa implica la necessità di offrire concretamente i mezzi per soddisfare i bisogni umani che nascono nell’ambiente di lavoro. Fra i mezzi che oggi si ritengono indispensabili perchè nell’impresa moderna consegua i suoi intenti sociali vi è il Servizio Sociale» (già citato).
Nota bibliografica relativa ili primo strumento di lavoro. Visione ed aspetti del servizio sociale di fabbrica
Il Ventrice studia In situazione odierna dell’Assistenza Sociale di Fabbrica. Sostiene olio non è detto elio essa sia mutata nell’indirizzo. Certo lo è nella produzione dolio pratiche. Vede come compito essenziale odierno, l’adattamento dell’operaio all’ambiente. Ma l’adattamento si realizza attraverso facccttazione dell’ambiente, e non esiste vera accettazione senza distensione psicologica. L’ambiente per il lavoratore è la fabbrica. « Questa individualizzazione dell’ambiente nel e per il quale FA. S. di fabbrica opera, consente di comprendere come e perchè il Servizio Sociale di Fabbrica abbia perduto, nel tempo, il carattere di genericità e di polivalenza che lo distinguevano, e sia andato qualificandosi come Servizio Sociale specializzato. avente fondamentale riguardo ai problemi (familiari, economici e comunque esterni alla fabbrica) che incidono su tale rapporto cioè sul comportamento dell’individuo al lavoro ».Ma vi sono anche dei problemi di adattamento per 1’A.S. di fabbrica. Il relatore ne descrive l’inserirsi dell’A.S. nello stabilimento come subordinato a molte difficoltà. « Il solo fatto che l’azienda non sia un Ente di S.S., propone in termini relativamente ardui il problema di trovare un posto nella struttura aziendale; in altre parole il problema dell’A.S. di fabbrica è che la sua funzione risulti chiara, e che la sua posizione di equilibrio non sia scossa dalle pressioni che, da molte parti, riceve ». (pag. 36). L’A. S. di fabbrica dovrebbe, per interpretare ben eil suo ruolo «essere collaboratrice di tutti, senza sostituirsi a nessuno ».
2ª Nota bibliografica relativa al primo strumento di lavoro (Ettore Mariano, Giornata di studio dell’A.S. di fabbrica, Ass.Lombarda Industriale, 1958).
Accennato all’importanza attuale della Sociologia industriale, in base alla quale il concetto di azienda quale convogliamene dei mezzi di produzione, è superato dal nuovo, di azienda quale sistema sociale, dato l’operare che le è proprio, il relatore ricorda gli studi di Elton Mayo, della Harward School of Business Administration di Filadelphia, e mette in risalto l’evidente evoluzione della mentalità del capo industriale. Egli oggi « non si limita ad esigere dall’operaio una determinata prestazione di attività », ma sa di dover concorrere a « cercare nel lavoratore quell’indispensabile sottofondo di motivazioni che oggi hanno superato la tabella dei tempi ed il cronometro » (pag.13).
Anche l’Avv. Pucci (Pucci, ibidem pag. 20) dà una definizione del Servizio Sociale di Fabbrica : « Una manifestazione di profondo e reale interesse dell’imprenditore verso ogni singolo lavoratore, per il rispetto della sua dignità, per la retta comprensione dei suoi essenziali bisogni; interesse fattivo anche per quei minori provvedimenti che possono dare benessere materiale e soddisfazione morale dell’ambiente del lavoro».
Discussione sul 1° strumento di lavoro. Il Servizio Sociale d’impresa di oggi
Tema: Aggiornamento del Servizio Sociale di Fabbrica.
Il gruppo ha dapprima considerato la realtà aziendale, quale essa si presenta attualmente all’A.S., confrontandola con il quadro prospettato nel materiale di studio distribuito. Pur rammaricandosi del divario profondo che separa la situazione concreta da quella idee, tutte concordano sugli obbiettivi da raggiungere e sulla nuova funzione sociale che l’azienda dovrebbe svolgere.
Nell’esaminare sia il contributo che l’A.S. può recare in questo processo di trasformazione, sia le nuove e più ampie sfere di operativi a che a lei si preparano nell’ambito aziendale e il discorso puntualizza la necessità dell’aggiornamento. Malgrado qualche parere contrastante, in genere il gruppo concorda nel ritenere che l’onere dell’aggiornamento spetti all’Ente, perchè la Scuola non può che offrire una preparazione polivalente. Naturalmente la stessa A.S. deve impegnarsi sul piano personale a tenersi informata culturalmente, a perfezionare i suoi metodi di lavoro, ed a contribuire pur nei suoi ristretti limiti al miglioramento della situazione attuale.
Molte presenti hanno obiettato che l’Ente preoccupandosi sul momento dell’inserimento del S.S. di precisare con chiarezza gli scopi e le finalità, facilita una migliore utilizzazione dell’A.S. da parte di tutta l’Azienda. Il discorso si sposta poi su di un altro punto: « differenziazione del Servizio Sociale di Fabbrica », ed il gruppo pur accettando come desiderabili le conclusioni dei gruppi di Studi Internazionali, ritiene prematuro limitare i compiti dell’A.S. nell’interno della fabbrica. Si conclude segnalando la necessità che nelle presenti contingenze, l’A.S. articoli la sua attività in direzioni:
1 nell’interno dell’Azienda perchè specificatamente adibita a questo.
2 nelle famiglie perchè l’A.S. deve considerare l’operaio nella sua integrità, di membro, del gruppo familiare.
3 nella più grande comunità parrocchiale, con la specifica funzione di indirizzare l’uomo al raggiungimento del proprio fine.
2° STRUMENTO DI LAVORO. Fasi di lavoro dell’Assistente Sociale di Impresa
a) Inizio del servizio sociale in una impresa
L’Ente presenta l’A.S. al Dirigente dell’Azienda, o dello stabilimento industriale che ha richiesto, o caso sempre più raro – che è stato dall’Ente sensibilizzato sulla necessità di esso.
L’A.S. espone a larghe linee al Direttore di stabilimento il suo ruolo, e prende l’impegno di presentare il proprio programma adatto al particolare ambiente della azienda.
b) Inserimento del Servizio
L’A.S. viene presentato dal Direttore ai capi tecnici o amministrativi, a diverso livello, sull’attività dei quali lo stabilimento s’incardina.– Il Direttore indica ad essi la funzione di collaborazione dell’assistente al buon andamento dell’impresa, alla soluzione delle difficoltà concernenti il personale, ed alla migliore coesione sociale dell’Azienda.
c) Studio di ambiente che verte su:
Natura giuridica della Società Industriale.– Strutture tecniche ed amministrative dello stabilimento: materia prima – tipo di processo lavorativo – energie di produzione – attrezzature strumentali – prodotto.– Contigente, categorie, provenienza dell’elemento umano dell’Azienda. Regolamenti amministrativi e disciplinari vigenti sul lavoro.
Contratto di lavoro, strutture sindacali, previdenziali, sanitarie, assistenziali operanti nello stabilimento.
Lo studio dunque, si estende al quadro completo dell’Azienda.
Scopo dello studio: è l’individuazione degli elementi sociali di maggiore interesse rispetto allo scopo intrinseco della comunità aziendale.
Metodo: Colloqui, giustificati o preannunziati o concessi con i responsabili dei vari servizi ed uffici ma anche ottenuti con i vari esponenti di essi, a diversi livelli, e perciò largamente con i lavoratori.
d) Presentazione al Direttore di un piano di lavoro, concepito in base alle rilevazioni sociali risultanti dallo studio eseguito.
e) Servizio
L’assistente potrà quindi svolgere la sua attività specifica nell’impiego delle tecniche e dei principi del S.S., in collaborazione giornaliera con tutti gli elementi dell’Azienda, utilizzando, in armonia con essi, tutte le risorse che offre, allo scopo di aiutare chi vi lavora ad acquistar gradatamente, non solo la consapevolezza della propria situazione professionale e personale, ma anche la fiducia di poter affrontarla da sé.
Recensione relativa al secondo strumento « Fasi di lavoro dell’A.S. di Fabbrica »
« Difficoltà di inserimento dell’A.S. in una fabbrica» (Egle Cantalupi in Settimana dell’assistenza di fabbrica, 1958, Assolombarda, 1958, pp. 73-76).
Si suppongono che la Direzione abbia accettato i postulati del S.S. propostogli dall’Ente e che abbia accettato l’A.S. che viene presentata in apposite riunioni, dal capo a tutti gli organismi aziendali. Con i quali il Dirigente abbia già svolto azione di chiarificazione, ripetendo le sue direttive. Si suppone anche che la direzione mantenga aperte le sue vie di comunicazione con l’assistente.
Rimangono altre difficoltà che sono considerate dalla relatrice in:
a) soggettive: timidità della stessa Assistente Sociale, tendenze al pessimismo, incapacità ad analizzare con obbiettività di fatti, gli avvenimenti della vita aziendale e cattiva preparazione.
b) oggettive:
1. La commissione interna per i seguenti motivi:
a) timore di perdere il proprio prestigio nei confronti delle maestranze;
b) timore dell’invadenza dell’A.S. nei settori di propria competenza;
c) timore che i capi manifestino tendenza a trattare alcuni problemi con lei e quindi indebolisca il loro potere: di qui molte reazioni di aggressività.
2. Questi timori si può immaginarli condivisi da molti: da tutti gli organi aziendali precostituiti i quali adottano metodi diversi dall’A.S. e che per esempio, si interessano dei lavoratori in base al merito, invece che allo stato di bisogno;
3. dalle persone che si occupavano prima volontariamente, più o meno, di assistenza in fabbrica;
4. dai capi i quali o vanno verso l’A.S. in attesa miracolistica o con desiderio di essere sempre interpellati.
Rimedio: cercare la coesistenza armonica attraverso la chiarificazione e la collaborazione.
Mezzi preventivi per attuare l’inserimento sono:
a) uno studio analitico accurato della realtà aziendale;
b) le tecniche del case work (pag. 70).
Seconda recensione sul secondo strumento di lavoro dell’Assistente Sociale di Fabbrica
Collaborazione ira Servizio Sociale e Servizio del personale a diversi livelli di evoluzione del Servizio Sociale e dell’Azienda (Gianna Manzoni, già cit., pag. 30).
Inserita dall’Ente in una Ditta forse non del tutto bene informata sul Servizio Sociale, l’Assistente Sociale eseguirà dapprima uno studio d’ambiente per conoscere i molteplici aspetti della vita di azienda, e per rilevarne i vari problemi ed i loro riflessi sugli individui.
Il suo studio appurò:
a) problemi d’ordine generale, comuni a vari settori dell’organizzazione aziendale, richiedenti una soluzione unificata per impedire sperequazioni;
b) problemi di ordine particolare, richiedenti una indagine accurata e particolareggiata di situazioni individuali.
Sui risultati di questa inchiesta l’Assistente programmò un servizio che aveva il compito principale di dedicarsi alla soluzione dei vari problemi dei lavoratori, e che promuoveva, organizzava e controllava le varie attività destinate alla piena utilizzazione della capacità dei dipendenti, al fine di ottenere soddisfazione del personale e utilità dell’impresa. Fu così creato un Ufficio Personale nella Fabbrica.
L’abilità di questa Assistente si dimostrò nello sviluppare un’ampia collaborazione, e nello sforzo di non sostituirsi mai all’Ufficio del personale, ma anzi di potenziarlo. L’A. S. mise in luce in tal maniera la particolare utilità dell’intervento del Servizio Sociale in determinati momenti della vita del lavoratore, nei quali occorre che egli sia aiutato a raggiungere la consapevolezza della situazione in cui si trova, e ad assumere atteggiamenti responsabili.
Terza recensione sul secondo strumento di lavoro: Fasi del lavoro dell’A.S. di Fabbrica, « Il S. S. ed il problema dell’adattamento al lavoro di nuovi assunti » (Fiorenza Rossini, Atti giornata A.S. di fabbrica, già cit.).
La collaborazione dell’Assistente Sociale, si svolge, nelle esperienze della relatrice già in sede di selezione, e cioè nel preparare il lavoratore all’esame psicotecnico e nel discutere con lo psicologo dopo 1’esame.
Con i già ammessi l’A.S. ha un colloquio in cui parla loro sulla Azienda, la ‘lavorazione trattata, i reparti dello stabilimento, le previdenze sociali esistenti.
Al colloquio segue l’accompagnamento dell’ammesso alla visita delle mense e delle infermerie, la presentazione al capo reparto ed il colloquio con lui. Si dà così la prima visione del lavoro. Dopo di che l’A.S. va spesso nei reparti, ove il nuovo assunto lavora, ed ha contatti frequenti con il suo capo. Dopo quindici giorni, un secondo colloquio individuale dell’A.S. con il lavoratore. Il colloquio verte sulle sue impressioni circa il lavoro. Lo scopo è di far opera di chiarificazione sulle difficoltà da lui incontrato, di cui, secondo le relatrice, due sono le principali: il timore di non riuscire nel lavoro, la ostilità contro il capo (pag. 78).
I pareri del gruppo Internazionale esperti di S.S.A. (Rapporto del gruppo di studio internazionale sulle funzioni ed i metodi del lavoro degli assistenti sociali aziendali, convegni di Zurigo e Dortmund, 1957-1959, Edizioni Confindustria, pp. 9-10).
Qualche principio relativo al servizio sociale aziendale
Principi fondamentali di ordine generale valevoli per il servizio sociale nel suo insieme:
1. Il servizio sociale offre un aiuto specializzato alle persone che devono far fronte a dei problemi sociali
2. II servizio sociale è praticato per mezzo di relazioni professionali tra l’assistente sociale ed il suo cliente.
3. Il servizio sociale è fondato su di un rapporto di fiducia e per questo fatto si rende necessario il segreto professionale.
4. Il servizio sociale richiede da coloro che lo esercitano di astenersi dal giudicare.
5. Il servizio sociale richiede il rispetto del diritto del cliente di disporre di sé stesso per quanto concerne la propria responsabilità ed integrità individuale.
6. Il servizio sociale richiede da parte di chi lo pratica comprensione del cliente, della sua situazione complessiva, cioè ‘la conoscenza delle sue esperienze passate e presenti, dei suoi progetti, della sua famiglia, del suo ambiente di lavoro, ecc.
7. Il servizio sociale richiede l’indipendenza psicologica dell’assistente sociale nei confronti di tutte le persone e parti interessate.
8. Il servizio sociale richiede che l’assistente sociale abbia la conoscenza delle possibilità e dei limiti:
a) del cliente,
b) della professione dell’assistente sociale,
c) di sé stesso.
9. Il servizio sociale richiede che l’assistente sociale sia cosciente del suo aspetto esteriore, del suo comportamento e della sua propria evoluzione.
DISCUSSIONE SUL II� STRUMENTO DI LAVORO. Fasi del lavoro dell’Assistente di Fabbrica
Poichè nella discussione antimeridiana sono emersi alcuni problemi inerenti alla figura e ai compiti dell’A.S. in fabbrica, il leader ha proposto all’esame e alla critica del gruppo il seguente piano di lavoro da svolgere nell’azienda:
1) partecipazione all’inserimento dei nuovi assunti;
2) cura dei casi di disadattamento interno (all’ambiente, ai compagni, al lavoro, per infortunio o malattia, etc.);
3) opera di chiarificazione circa i provvedimenti interni (premi, multe, trattenute, etc.);
opere sociali: promuovere in collaborazione operaia iniziative culturali, ricreative, formative e di assistenza; fare opera di critica costruttiva sui servizi già esistenti;
5) collaborazione dell’A.S. alla prevenzione degli infortuni.
Il gruppo si è trovato d’accordo in linea di massima su tale programma, facendo però o-biezioni e riserve. Un membro ha fatto notare la necessità che l’Ente Gestore del Servizio Sociale presenti ‘professionalmente l’A.S. ai dirigenti dell’azienda. Il gruppo ha accettato questo punto ed altre precisazioni hanno affermato l’opportunità che l’Ente esponga fin dall’inizio il programma di lavoro e sostenga l’opera dell’A.S. curandone l’aggiornamento soprattutto professionale e formativo. Un altro membro ha lamentato che talvolta manca una convenzione tra l’Ente e l’azienda; così che l’A.S. corre il pericolo di non aver posizione chiara. Dello stesso parere sono state altre partecipanti che, citando esperienze personali, hanno attribuito la gravi difficoltà incontrate nel lavoro al difetto di inserimento del Servizio presso la direzione aziendale. Inoltre qualcuna ha sostenuto che non sarebbe errato parlare di case-work. nella presentazione per dare un’idea più esatta del servizio, ma tutte sono state d’accordo nel considerare questo particolare un elemento proprio dei metodi più che delle fasi di lavoro. Una partecipante ha precisato che il programma attuato dall’A.S. in azienda, formulato dopo un primo studio di ambiente e concordato con i dirigenti dell’azienda, deve essere tale da non esulare dai limiti di competenza dell’A.S. Infine il gruppo ha posto in discussione se includere nel programma il servizio di patronato. Questo infatti assorbe molto tempo ed impedisce la realizzazione del vero e proprio case-work.
Sarebbe pertanto opportuna la presenza di una segreteria efficiente cui affidare lo svolgimento delle pratiche.
Un altro membro del gruppo è del parere di scindere completamente il patronato dal Servizio Sociale per fare più largamente servizio di azienda come si conviene ad una A. S. specializzata; essa infatti dovrebbe essere richiesta di interventi di S. S. e non della produzione di documenti e cose simili. Questo contribuirebbe anche a valorizzare l’opera che ciascuna quotidianamente svolge. Alcune hanno fatto presente che una così radicale modifica sarebbe l’ideale, ma che per il momento non appare attuabile, sia per ragioni amministrative, sia perchè la pratica è un servizio che completa la soluzione del « caso » e che a tutt’oggi è molto apprezzato dall’azienda. È stata quindi sostenuta la precedente proposta di potenziamenti di vari servizi. Tutte comunque sono state d’accordo nel ritenere quest’ultima formula come una soluzione provvisoria. Infine si è auspicato un maggior aggiornamento dinamico del personale amministrativo curato dalla Direzione dell’Ente. I pareri del gruppo internazionale di esperti in S. S. A.
2. Principi di base aventi specifico riferimento cd servizio sociale aziendale (Rapporto del gruppo di studio internazionale sulle funzioni e i metodi di lavoro degli A.S. Aziendali già cit., pag. 10)
2. Il servizio sociale aziendale non permette all’assistente sociale di avere una funzione autoritaria nell’azienda, salvo nei confronti di personale ad esso subordinato.
3. Il servizio sociale aziendale richiede dall’assistente sociale che egli riconosca i limiti delle sue funzioni nell’impresa.
4. Il servizio sociale aziendale richiede che l’assistente sociale favorisca le comunicazioni e le relazioni dall’alto verso il basso della gerarchia aziendale.
5. Il servizio sociale aziendale richiede che 1’assistente sociale sia a disposizione disposizione degli individui e dei gruppi a tutti i livelli della struttura aziendale.
« Si, i beni spirituali non sono la casa ed il vestito. Ma ciò che vi annuncio dà argomento, titolo, e, starei per dire, diritto alle cose temporali. La speranza cristiana attribuisce a voi il diritto di avere queste cose. Voi siete cittadini del Cielo, rivestiti di una sacra dignità, per cui, quelli che vi circondano, devono trattarvi col massimo rispetto. Siete uomini riconfermati dallo stesso Cristo, in questa dignità naturale, e basterebbe solo questo titolo a darvi il diritto al rispetto. Ebbene, io vi do il titolo e rivendico a voi il vostro livello morale e spirituale umano. Sappiate, quindi, che il mio augurio di Buona Pasqua, vi dice che la Chiesa vi vuol bene e vi difende. Essa vuole che voi progrediate; essa vi è vicina e vi promette consolazione, dignità e speranza » (S.E. Cardinal Montini agli operai dei 50 stabilimenti della Bovisa 28 marzo 1959).
TERZO STRUMENTO DI LAVORO. Metodi del Servizio Sociale di Fabbrica (A. Cattagni, « Possibilità di lavoro dell’A.S. di Impresa». Quaderno n. 5 del Segretariato Servizio Sociale UCID Milano, 1959, p. 11, «Esperienza di lavoro di gruppo con capi reparto, ibidem, p. 19)
1) Servizio Sociale al caso individuale
a) Limiti posti dal cliente
Esistono molte difficoltà da superare per ottenere l’attiva collaborazione del cliente all’azione dell’A.S. Gli operai non sono abituati a prendere in considerazione il modo di affrontare il proprio problema, ma chiedono solo un ristabilimento momentaneo di equilibrio.
Vi è inoltre in loro scarsa possibilità di instaurare un rapporto di lavoro sociale con l’A. S:
b) Limiti posti dalla Direzione della Fabbrica
nella concezione della funzione dell’A.S.
nel tipo di assistenza da essa concessa ai lavoratori.
c) Limiti che FA. S. si impone da se:
una diagnosi, anche se rapida;
ottenere la partecipazione del cliente al piano di lavoro comune; l’uso del rapporto e l’uso razionale delle risorse per la soluzione dei problemi.
2. Servizio Sociale di gruppo
E un processo educativo sociale che ha lo scopo dello sviluppo della personalità, attraverso esperienze collettive; strumento è il gruppo, e mezzo, le tecniche specifiche del Servizio Sociale.
i gruppi aziendali di fatto sono:
a) obbligati – determinati cioè in funzione della mansione che ciascun operaio deve esercitare; sono gruppi eterogenei per età, situazione individuale, provenienza, esperienza, aspirazione (reparti ed uffici);
b) di fatto – determinati dall’esigenza di una vita sempre in comune, nonostante gli interessi individuali di ciascuno (apprendisti, capi-reparto, specializzati);
c) di adesione libera (Comitati e Consigli, benchè la scelta dei membri venga fatta dalla Direzione
o dai suffragi);
d) gruppi ai margini – sono i gruppi culturali. Scopo principale del lavoro di gruppo è di mutare i gruppi occasionali in volontari.
Problemi che considera il lavoro di gruppo:
difficoltà di comunicazione;
difficoltà di collaborazione ad ogni livello;
rapporti gerarchici impostati ad autoritarismo o non strutturati razionalmente, ma lasciati all’arbitrio dei capi. Mezzi che il Servizio Sociale adopera:
a) comprensione, fulcro delle relazioni umane, attraverso il colloquio – rispetto delle responsabilità dei lavoratori, accettazione delle loro idee, discussione dei problemi del lavoro, ed in particolare dei problemi personali con loro.
b) comprensione dello spirito di gruppo che non è quello di costituire una classe o una � èlite, ma di aprirsi verso gli altri.
Nota bibliografico relativa al terzo strumento di lavoro. Metodi di servizio sociale di impresa
L’Assistenza ai casi di disadattamento al lavoro (Studi, considerazioni, esperienze di A.S. in servizio sociale dell’impresa, UCID, Milano, 1956). Spesso certi tipi di lavoro provocano, specialmente su elementi psichicamente fragili, ripercussioni notevoli che incidono sulla vita lavorativa, ad esempio la lavorazione in serie o a catena può avviare alcuni lavoratori a forme di nevrosi.
L’Assistente Sociale darà la collaborazione del suo studio alla ricerca di determinati accorgimenti atti ad eliminare in parte i negativi effetti di certa organizzazione del lavoro; in più potrà osservare più attentamente e cercare motivi di. contatto più frequenti con questi lavoratori per poter prevenire forme specificatamente patologiche.
Trattamento dei casi
L’Assistente Sociale deve collaborare con i capo-reparto alle conoscenze del lavoratore disadattato ed iniziare con lui un trattamento professionale. I mezzi da usarsi sono i colloqui con l’assistito e con coloro che hanno rapporti con la sua situazione, in maniera significativa ed il contatto con gli aspetti più importanti dell’ambiente. II colloquio con il lavoratore è sempre l’elemento più importante per l’esame della situazione. Si può avvertire inizialmente in lui un senso di disagio perché egli prova vergogna a riconoscersi incapace di fare da sé. Innanzitutto necessario assicurarlo sulla buona volontà di aiutarlo e facilitargli l’esposizione del suo disagio, intervenendo con domande appropriate non solo per chiarire la situazione, ma anche per conoscere il suo punto su di essa e la sua idea sul modo di migliorarla (Ibidem, pag. 23).
Servizio sociale e relazioni umane. Recensione (da Servizio sociale nelle imprese, UCID, Milano, 1956, pag. 13)
Le condizioni artigianali nel secolo scorso non ponevano la problematica di oggi e cioè il lavoratore non provava come oggi il bisogno di soddisfazioni morali: il riconoscimento del lavoro compiuto, la certezza di essere utile e la speranza di migliorare la propria situazione.
Non bastano ora all’individuo le conquiste che come membro di una categoria consegue attraverso l’azione del sindacato; occorre che i suoi desideri le sue aspirazioni trovino soddisfazione nella sua attività giornaliera. Ogni uomo è prima individuo e poi membro della collettività. In una impresa modernamente organizzata, caratterizzata dal decentramento di poteri attraverso la delega di autorità, non si possono raggiungere tali obbiettivi, se non introducendo nei quadri dei capi una notevole preparazione tecnica e psicologico-umana.
Questa preparazione attuale è il compito principale delle Relazioni Umane.
Le due tecniche del Servizio Sociale e delle Relazioni Umane hanno in comune il fine: valorizzazione dell’elemento umano che opera in seno all’impresa. Programma specifico delle Relazioni Umane è quello di introdurre nuove direttive e nuove tecniche nella conduzione aziendale.
Il Servizio Sociale affianca quest’azione, curando che le direttive generali trovino il loro riscontro e la loro applicazione nel singolo, ed offre « il contributo di un’attività giornaliera volta all’individuazione ed allo studio dei casi di disagio, la cui origine può essere fatta risalire a condizioni di ambiente, di estraneità o di ostilità ad esso, con manifestazioni di indisciplina, scarso rendimento, disinteresse per il lavoro; o a cause più specificatameli personali che esulano dalla vita dell’impresa e va ricercate spesso nella vita familiare» (pag. 14). Il Servizio Sociale porta un valido contributo all’instaurazione di un clima di buone relazioni umane nell’azienda. Infatti uno dei suoi compiti, ad esempio la sensibilizzazione dei capi specialmente di quelli livello meno elevato ai problemi più che mai importanti dei rapporti con i lavoratori e l’importanza del fattore psicologico che affiora da situazioni reali a loro ben note. Sensibilizzazione dei capi perchè « non possono esservi buoni rapporti se non c’è comunicazione, e la comunicazione tra il vertice e la base, e tra i membri della base stessa si può mantenere aperta e costante solo se. nelle vie attraverso le quali essa si attua, vi sono individui onesti e capaci ». «A proposito di uomini in primo luogo è opportuno parlare di disposizioni d’animo, di modo di concepire l’uomo, di riconoscerne gli inderogabili diritti di libertà, di autodeterminazione, di accettarli come soggetti, e non oggetti, dell’impresa » (pag. 15).
Seconda Recensione sul terzo Strumento di Lavoro. I metodi del S.S. di Fabbrica
L’intervento dell’A.S. nell’infortunio sul lavoro (Verana Viale in Atti della Settimana sulla Assistenza Sodale di Fabbrica. Associazione Lombarda Industriale 1958, pag. 67). « La Viale che è A.S. di fabbrica, fa un’analisi dello stato d’animo dell’infortunato, assai acuto. Dice circa l’infortunato sul lavoro, che egli è turbato innanzi tutto psicologicamente; quando è colpito sul posto di lavoro, non riesce a capacitarsi di quanto gli è accaduto. Riporta perciò un trauma psichico, e si sente ostile a tutte le macchine che quotidianamente adopera; ed, in generale, alla società. Gli affiorano alla mente tutte le sue preoccupazioni morali e materiali, se ne sente oppresso, disorientato, avvilito. Oltre che psicologicamente, l’infortunato è colpito economicamente e nella sua valutazione sociale sulla ditta e sulla società, in genere. L’intervento dell’A.S. è immediato e consiste in una azione di appoggio morale. In casi gravi l’A.S. ricorre alla collaborazione dello psicologo ». La comunicazione continua descrivendo il trauma della famiglia che è colpita anch’essa psicologicamente, economicamente e nelle valutazioni sociali, tendenzialmente di ribellione all’azienda nell’episodio dell’infortunio. La comunicazione è assai importante.
I pareri del gruppo Internazionale di esperti di S. S. A. (Rapporto del gruppo internazionale, già cit., pag. 14-15).
3. Le ragioni più importanti che militano a favore dell’impiego di specialisti del servizio sociale aziendale si riferiscono:
a) agli scopi particolari del servizio sociale aziendale;
b) alle conoscenze, ai metodi, alle tecniche ed ai mezzi di lavoro che sono propri di tale servizio;
c) alla struttura di questa funzione nell’organizzazione dell’impresa. I commenti che seguono espongono alcune delle ragioni che sono alla base della esistenza del servizio sociale aziendale:
– l’organizzazione dell’impresa, nel suo insieme, è orientata nello svolgimento di un lavoro avente obiettivi economici. Il servizio sociale aziendale, invece, è principalmente orientato verso un determinato aspetto dello scopo generale. Esso pone l’essere umano al centro delle sue preoccupazioni. Ne deriva che l’assistente sociale aziendale può consacrare tutta la sua attenzione ai suoi clienti, mentre l’insieme della gerarchia aziendale si preoccupa di molti altri fattori di cui il lavoratore non è che un elemento. Spesso, aiutando l’individuo a risolvere i suoi problemi d’ordine sociale, si accresce la sua efficienza professionale; pertanto, gli aspetti economici e sociali vanno nella maggior parte dei casi di pari passo. L’assistente sociale aziendale è specialmente formato per cooperare alla soluzione dei problemi sociali. Le cognizioni, i metodi, le tecniche ed i mezzi che si richiedono per la sua attività sono più specializzati di quelli cui ricorrono gli altri membri dell’organizzazione.
d) la struttura della funzione può essere considerata sotto punti di vista differenti.
DISCUSSIONE SUL TERZO STRUMENTO DI LAVORO. I metodi del servizio sociale di fabbrica
Case Work – L’applicazione di questo metodo, secondo il parere unanime, nell’ambito di fabbrica, urta contro alcune remore che inducono l’A.S. ad usare degli accorgimenti per il suo uso. Si rilevano alcune difficoltà di carattere generale come la scarsa conoscenza del S.S. da parte dell’ambiente, sentimenti di diffidenza e sospetto circa i reali fini dell’atto assistenziale. Si passa poi ad analizzare le cause che limitano la capacità di iniziare, sostenere approfondire il rapporto col cliente:
a) condizioni esterne quali la limitazione di orario, impossibilità o quasi di condurre un colloquio prolungato, mancanza di un locale che consenta la dovuta riservatezza al dialogo:
b) reale impellenza di un bisogno del cliente che sembra richiedere una soluzione immediata e che molte volte la esige;
c) scarsa disposizione del lavoratore a collaborare, a causa della sua dipendenza e subordinazione dovute ad un fenomeno di suggestione che si estende anche al rapporto con l’A.S. La sollecitazione del senso di responsabilità e dell’iniziativa personale, è resa più difficile anche per la sfiducia al cliente nei confronti degli Enti pubblici, dalla sua ignoranza e timore della legislazione assistenziale e previdenziale. L’abilità richiesta all’A.S. consiste nella riduzione al minimo dalla fase di studio nella rapidità diagnostica, e dalla efficacia di un intervento, ed attivazione del cliente, offrendo a lui ed a sé la opportunità della collaborazione. Si tratta di stimolare in un tempo quasi sempre breve, l’energia interna del cliente, di chiarirgli con poche parole i termini del problema e di prospettargli le possibili soluzioni. Oltre alle difficoltà suaccennate, le partecipanti possono parlare di quelle provenienti dalla Direzione. I limiti da questo lato sono proporzionati al grado di conoscenza del S.S. stesso da parte dei Dirigenti, che talvolta ne contengono l’applicazione in forme così marginali da limitarne le possibilità e rendere l’uso dei metodi, praticamente difficile. Viene rilevato infine un ulteriore fattore di limitazione al S.S. l’atteggiamento della Commissione interna, che talora mostra avversione per talune forme del S.S. interpretandole come attività sostitutiva della propria prerogativa. Si afferma pertanto che la vittoria sulle diffidenze e la errata o nulla conoscenza del S.S. con la conseguente estensione della sua sfera d’azione è in gran parte affidata alle doti ed alle abilità personali dell’A.S. A questo punto si fa rilevare che qui l’A.S. di Fabbrica trova condizioni ideali per operare, agisce secondo quelle direttive che la sua preparazione professionale e la sua sagacia le consentono. La diagnosi, anche se rapida, il piano di la utilizzazione razionale delle risorse interne ed esterne, anche se diminuiscono la rapidità della conclusione, sono indispensabili. E tutte concordano come sia da preferirsi, dunque. la collaborazione con il cliente, anche se il risultato non è immediato, piuttosto che giungere a conclusioni determinate dall’A.S. che pur essendo state richieste, potrebbero poi in seguito venire criticate dal cliente stesso, o comunque non influire sullo sviluppo della sua personalità.
Il case-work
Il gruppo ha ritenuto opportuno esaminare, quale premessa alla discussione del punto primo, le difficoltà di ordine ambientale che possono sorgere nell’instaurazione del rapporto tra A.S. e cliente, quali orario della presenza in fabbrica, limitato in proporzione al numero rilette di operai, ufficio inadeguato, mancante, da dividersi con membri direttivi assolutamente estranei al Servizio Sociale.
Punto A – Sono state messe in discussione le difficoltà di carattere psicologico che si presentano nel trattamento del caso.
I limiti posti, sia pure involontariamente dal cliente, si localizzano soprattutto nella fase iniziale, come difficoltà di apertura dovuta a titubanza, apprensione, diffidenza del cliente che non conosce l’A.S. né il Servizio Sociale. Nella seconda fase del trattamento, allorchè si richiede una collaborazione da parte del cliente, la difficoltà consiste nel fatto che egli non vede chiaramente il suo problema.
Nell’ultima fase, quando il caso, si avvia ad una soluzione, l’A.S. si trova a dover affrontare nel cliente una tendenza e lasciar fare per incapacità, per sfuggire allo sforzo, e soprattutto per atteggiamento di passività e di fuga dalle responsabilità.
Punto B – Per quanto riguarda i limiti posti dalla direzione della fabbrica in ordine alla concezione della funzione dell’A.S., si è già discusso ampiamente nella prima riunione di gruppo. Così anche per il tipo di assistenza che la fabbrica concede ai lavoratori.
Punto C – Il gruppo è stato concorde nel considerare che quanto contenuto nel paragrafo C (limiti che l’A. S. si impone da sé) non rappresenta un limite all’opera dell’A.S., ma piuttosto una provvidenziale graduazione del trattamento; si parlerà quindi di limiti positivi che trovano la conferma della loro validità nelle tecniche del case work. L’A.S. infatti non può definire la terapia del caso senza averlo prima diagnosticato, né può sperare in una soluzione positiva senza la partecipazione attiva del cliente e la valorizzazione delle risorse personali o ambientali atte a risolvere il problema.
Il group-work
Per quanto riguarda il g.w., il gruppo ha accettato sul piano teorico la validità di questa tecnica. Nessuna Assistente infatti ha esperienze concrete in merito, essendo state realizzate finora soltanto attività collettive e non vero e proprio lavoro di gruppo.
Da tutte è stata accettata la suddivisione dei gruppi aziendali precostituiti, precisando però che sarebbero preferibili i gruppi di adesione libera, occasionali; l’impostazione del lavoro è dunque di rendere i gruppi obbligati; accetti e simili a quelli spontanei e liberi. Non si vede altrimenti come costituire facilmente il Servizio Sociale dei gruppi.
L’attività di tale lavoro servirà ad attutire o ad eliminare le difficoltà di comunicazione e di collaborazione in ogni settore (dislivelli di cultura, di idee, di esperienze, etc.) e a modificare indirettamente il sistema autoritario di alcuni capi, per instaurare un clima democratico di reciproco rispetto e di accettazione delle idee di ciascuno con maggiore comprensione e maggiore apertura sociale; è ovvio che tale apertura sociale non tollera lo spirito di classe, né l’isolamento del gruppo dagli altri.
Primo gruppo: lavoro di gruppo
a) Limiti posti dal cliente
Innanzi tutto il gruppo ha voluto crepelle cosa s’intende per Servizio Sociale al individuale, ossia per Case Work. Esso si ha su rapporto individuale (tra A.S. e cliente) come la Richmond dice, «un metodo che mette lo sviluppo della personalità attraverso un adattamento cosciente ed individuale dell’uomo al suo ambiente sociale ».Nell’attuazione di questo metodo, l’A.S. trova delle difficoltà nei limiti che il cliente stesso pone difficoltà, scaturite dalla mancanza di conoscenza da parte del cliente, del S.S. dalla sua tendenza a non collaborare con l’A.S. nella soluzione di un caso (tendenza dovuta ad incapacità o a pigrizia); dalle difficoltà di puntualizzare il problema per riserbo personale (il problema viene spesso nascosto, a volte inconsciamente, dietro una richiesta materiale).
b) Limiti posti dalla Direzione di Fabbrica.
L’esperienza di qualche collega, pone in evidenza che in alcune fabbriche la Direzione vede l’A.S. solo in funzione dello svolgimento delle pratiche previdenziali. In altre, invece, là dove già esiste un Ufficio di Assistenza proprio, la Direzione quasi obbliga l’A.S. a seguire una determinata linea di azione. Per quanto si riscontrino in pratica questi limiti, tuttavia bisogna ammettere che dove l’azienda ha raggiunto un notevole sviluppo economico, ed una maggior apertura sociale, si riscontra una maggior possibilità di inserimento da parte dell’A.S., con conseguente riduzione dei limiti.
c) Limiti che l’A.S. si impone da sé
La diagnosi, la partecipazione del cliente al piano di lavoro, l’uso del rapporto e l’uso razionale delle risorse per la soluzione dei problemi, secondo l’opinione comune, devono essere considerati come metodi di lavoro. Sono perciò un binario e quindi limiti positivi facenti parte e punti fondamentali del Case Work. Si sostiene che la diagnosi è indispensabile, anche se rapida. Riguardo alla partecipazione del cliente, è notato che in alcuni casi è difficile ottenerla per incapacità o pigrizia del cliente.
La partecipazione può essere minima, ma ci ve sempre essere, secondo le possibilità del cliente. L’A.S. deve intervenire per porre in evidenza il problema e le varie soluzioni, aiutando il cliente ad autodeterminarsi. Un elemento positivo su cui far leva si trova in ogni individuo normale. Solo di fronte ad una incapacità fisico-psichica, l’A.S. può sostituirsi al cliente nella risoluzione del caso.Il rapporto consente, innanzi tutto, di stabilire la natura delle risorse a cui attingere, siano esse risorse individuali o quelle offerte dalla società.
Secondo Gruppo: lavoro di gruppo.
La discussione ha avuto inizio con la definizione del gruppo e della sua dinamicità. Il gruppo è un insieme di persone disposte a stare unite. La dinamicità del gruppo è data dai rapporti di azione che intercorrono tra i componenti.
Il lavoro che l’A.S. deve svolgere nel gruppo è il piano di lavoro, la diagnosi del gruppo, gli interventi, il programma. Si osserva però, che non tutte le aziende danno la possibilità all’A.S. di lavorare liberamente nell’attività di gruppo. Si registrano dei casi sporadici positivi, ma generalmente si nota che un lavoro, di fatto, non è stato ancora possibile. L’A. S., quando entra in un azienda, trova già dei gruppi costituiti che possono essere: obbligati, di fatto, di adesione libera o altri gruppi ai margini. Nei gruppi obbligati si trovano, quasi sempre, gruppi eterogenei, uniti però nello stesso lavoro per motivi personali diversi. In questi gruppi, l’A.S., in realtà, interviene quando un membro o più membri di essi, presentano degli in adattamenti al lavoro, gruppo, all’ambiente. A questo punto una collega interviene affermando che oggi gli individui hanno un eccessivo personalismo per cui non è facile formare dei gruppi attivi.
L’A. S. può individuare nei gruppi obbligati0 di fatto, degli interessi comuni e formare altri gruppi, assorbendo il tempo libero, per dar origine a gruppi culturali, sportivi ecc.
Solo in questi gruppi è possibile mettere in pratica le tecniche del Group Work.
Le difficoltà di comunicazione possono venir superate mediante una reciproca comprensione attraverso i colloqui e nell’applicazione dei valori che sono alla base della società democratica, ossia il rispetto della personalità e la ricerca dei mezzi che permettono agli uomini di convivere insieme.1 pareri del Gruppo Internazionale di esperti nel S. S. A.
4. Problemi in rapporto con la situazione di lavoro (Rapporto del Gruppo di Studio Internazionale etc. già citato pag. 7)
1. Porsi nell’ambiente professionale ed avere in esso la loro origine;
2. Esercitare una influenza sfavorevole sulla situazione di lavoro, anche quando non abbiano la loro origine in quest’ultima;
3. Essere sorti in seguito a regolamenti generali di carattere arbitrario, in vigore nelle imprese i cui effetti incidono, comunque, anche sulla vita dei lavoratori fuori dal loro lavoro.
Come il servizio sociale in generale, il servizio sociale di impresa ha un triplice scopo. Esso deve:
a) aiutare gli individui e i gruppi ad adattarsi alla loro situazione di lavoro ed a soddisfare le esigenze che essa implica;
b) incitare la direzione ad adattare la situazione di lavoro ai bisogni dei lavoratori;
c) contribuire al migliore funzionamento della comunità aziendale considerata come un tutto organico.
Questi tre aspetti sono molto spesso interdipendenti.
QUARTO STRUMENTO DI LAVORO
Ruolo dell’Assistente Sociale di Fabbrica
Collabora con l’Azienda alla considerazione dei problemi sociali della fabbrica in rapporto alle caratteristiche psicologiche dei lavoratori, rilevate dal loro comportamento, ed alla loro situazione sia interna che esterna rispetto alla fabbrica;
tratta i casi di disadattamento al lavoro e cerca di chiarirne i motivi biologici, psichici, sociali e morali;
considera e procura di interessarsi positivamente ai casi di scarso rendimento;
cerca di prevenire le conseguenze derivanti dalla penosità del lavoro;
dalla mancata o parziale soddisfazione del lavoratore;
di promuovere l’attuazione dei provvedimenti più adatti ad adeguare la situazione di lavoro ai bisogni dei lavoratori, collaborando « con il suo studio alla ricerca di determinati accorgimenti atti ad eliminare, in parte, i negativi effetti di certa organizzazione del lavoro»;
contribuisce a stabilire nella azienda « una migliore coesione sociale » ossia un miglior funzionamento della comunità aziendale considerata come un tutto organico.
Il Servizio Sociale è dunque particolarmente impegnato « nei delicati momenti della vita aziendale che riguardano l’inserimento del personale, l’insorgere di un conflitto tra l’uomo e l’ambiente, la presenza di bisogni materiali e morali dei lavoratori che vanno soddisfatti sul piano individuale e collettivo, nei casi di trasformazione di azienda che includono licenziamenti di personale».
Recensione relativa al quarto strumento di lavoro: ruolo dell’A.S. di fabbrica
L’A.S. riuscì in una Ditta a differenziare il servizio sociale da quello personale. Ritenne “servizio personale” quello che risolve, con carattere di autorità, i problemi concernenti i dipendenti, soprattutto da un punto di vista organizzativo ed attraverso procedure che attuano la politica direzionale dell’azienda.
Ritenne invece “servizio sociale” quello che pur inserito nell’organizzazione aziendale, ed accettandone le direttive, ha la funzione di promuovere l’adattamento dei singoli alla situazione generale, attraverso attività capillari e profonde, caso per caso, e che accorda al massimo gli interessi generali con quelli particolari (pag. 32).
I problemi degli operai determinati dal lavoro si enucleano cosi:
__ difficoltà soggettive ed obbiettive;
__ inserimento nell’azienda;
__ adattamento al lavoro;
__ spostamenti nei posti;
__ rapporti con i capi ed il gruppo;
__scarso rendimento,
__ problemi personali e familiari derivanti in gran parte dall’ambiente;
I fattori tecnico – organizzativo economici, personali e sociali sostanziano possibili problemi dei dipendenti con l’azienda, la quale chiede molto in termini di costo umano (pag. 33) per il proprio indispensabile sviluppo. L’A.S. opera una diagnosi individualizzata di questi problemi come mezzo per guidare l’individuo alla consapevolezza della situazione in cui vive, e per condurlo a una maggiore partecipazione di intelligenza e di interesse al proprio lavoro (pag. 33). D’altro lato la conoscenza di questi problemi consente all’azienda lo sviluppo organizzativo del proprio lavoro in vista delle istanze dei dipendenti ed una azione formativa lungo la linea gerarchica. Il Servizio Sociale rispettando al massimo la gerarchia portò i problemi in sede pertinente, ed aiutò le persone ad usare in modo autonomo le varie strutture aziendali preposte alla soluzione dei vari problemi.
Infine l’Assistente descrive la complementarietà tra Servizio Sociale e Servizi Aziendali.
Seconda Recensione sul quarto Strumento di Lavoro: ruolo dell’A.S.
Esperienze di lavoro: l’adattamento al lavoro in un servizio telefonico (Quaderno Ucid, 1959, pag. 85)
In una azienda milanese si verificò una generale insoddisfazione del personale assunto dopo un concorso.
La Ditta si rivolse all’A.S. perchè considerasse questo problema e ne suggerisse le possibili soluzioni. Il problema da studiare riguardava à« l’adattamento dell’individuo al proprio lavoro ». « Si intende per adattamento un processo di natura psicologica che impegna la persona ad armonizzare le proprie esigenze con quelle dell’ambiente nel quale viene a trovarsi. Le esigenze che una persona può portare nel suo lavoro non sono solo di carattere economico, ma anche di carattere ambientale (ricerca sia di un ambiente di lavoro confortevole dal punto di vista fisico, sia di buoni rapporti con i colleghi e con i superiori); altre esigenze possono nascere dall’aspirazione di ciascuno a migliorare la propria posizione lavorativa à».Spesso difficoltà di lavoro anche notevoli nascono proprio dal fatto che la persona non ha potuto soddisfare determinate esigenze da lei ritenute molto importanti.
Per l’Assistente Sociale si tratta di conoscerle e di trovare le possibilità nell’ambiente di lavoro di soddisfarle, nonchè di prevedere le conseguenze che possono derivare da una mancata o parziale soddisfazione di esse » (pag. 41). L’Assistente Sociale credette chiedere la collaborazione diretta di alcune dipendenti che, avendo già superato il periodo di prova, stavano vivendo molto da vicino tutti i problemi e le difficoltà di adattamento al proprio lavoro. Furono avvicinate, in colloqui vennero condotti su di uno schema di argomenti precedentemente studiati vertenti sulle loro esperienze ed impressioni in questo periodo, e fu loro partecipato lo scopo di giovare alle altre.
Si utilizzarono i risultati con proposte concrete ed attuabili di modifiche relative all’ambiente, al problema di addestramento, al lavoro di Assistente Sociale.
Terza recensione sul quarto Strumento di Lavoro: ruolo dell’A.S.
« Dall’automazione, il licenziamento e quindi la disoccupazione dei lavoratori »
Una A.S. parla di una propria esperienza. In una azienda tessile a causa di mutamento dei processi di fabbricazione, invece di licenziare il personale, al licenziamento si sostituì una forma di disoccupazione periodica per tutti.
Si volle disporre anche un sussidio speciale nei casi più bisognosi. L’A.S. venne incaricata di collaborazione all’individuazione di essi. Ella prepose uno studio sullo stato di bisogno dei singoli. Tale studio si svolse con successivi e ripetuti colloqui: con il capo-reparto e con le operaie, per raccogliere tutti gli elementi atti a puntualizzare le situazioni individuali e ad inquadrarle nel problema generale. Le situazioni vagliate una ad una, nei loro diversi fattori di composizione (fisici, economici, affettivi, ambientali, di composizione familiare) rilevarono come la diversa combinazione di questi elementi influisca a determinare il maggiore o minor peso del problema economico.
Nell’esame di un problema che, come quello della possibile disoccupazione investe l’uomo nella sua sfera personale, familiare, sociale e lavorativa, si rileva particolarmente positiva l’utilizzazione di una persona specificamente preparata che possa servirsi di un metodo particolare per stabilire quel rapporto di fiducia indispensabile per valutare tali situazioni individuali, dopo un esame obbiettivo e motivato del provvedimento da prendersi nei riguardi dei lavoratori. Invece che la ribellione per il provvedimento di natura negativa l’intervento alleggerì lo stato di tensione dei singoli individui, dette appoggio e comprensione nella valutazione dei vari fattori determinanti il bisogno. L’A.S. decise con le lavoratrici stesse quali elementi fosse utile portare alla Direzione per presentare le varie situazioni. Così l’elenco delle persone da sussidiare fu compilato in collaborazione tra il Servizio Sociale, il personale e la Direzione anche per il modo e la misura del sussidio. Chiarificazioni fu fatta con le operaie escluse dagli aiuti.
II risultato ottenne l’utilità delle lavoratrici ed apportò anche una più profonda reciproca conoscenza tra esse e l’A.S.; oltre la dimostrazione dell’importanza agli industriali delle tecniche del Servizio Sociale.
Nota bibliografica sul quarto Strumento di Lavoro: ruolo dell’Assistente Sociale di Fabbrica
Il ruolo dell’assistente di fabbrica secondo il Mariano (E.Marianno in Atti giornata A.S., 1959, già cit., pag. 15) è diverso da quello sin ora concepito, secondo una certa generalità e libertà di movimento e di funzione. Egli ritiene che l’assistente di fabbrica debba essere inserita nell’azienda, ossia in uno specifico sistema sociale, « con pieno diritto di cittadinanza ».Tale ruolo, secondo il Mariano, seguirebbe un criterio divisorio sottile: il rilievo del comportamento di lavoro spetta all’industriale, quanto a motivazione del lavoro, mentre le motivazioni di tale comportamento che hanno radice extra lavoro, spettano anche all’A.S. di Fabbrica. Ed il ruolo verrebbe così definito: sempre di collaborazione con tutti gli operatori della fabbrica e nei seguenti settori:
a) procedure di accoglimento del personale;
b) tecniche di addestramento degli apprendisti,
c) occasione di infortunio;
d) il problema del tempo libero.
E nel settore extra lavoro:
a) famiglia del lavoratore;
b) scuola, figli dei lavoratori;
c) istituzioni assistenziali extra stabilimento.
Il Servizio Sociale non intende interferire o sostituirsi alla Direzione del personale, ma collaborare con essa. considerando i problemi di fabbrica in rapporto alle caratteristiche umane psicofisiologiche dei lavoratori, in rapporto alle loro capacità potenziali ed attuali, alla loro preparazione tecnico-professionale e sociale, alla loro situazione ambientale interna ed esterna alla fabbrica, al loro comportamento individuale. alla loro integrazione nel gruppo, al loro grado di partecipazione e collaborazione alle opere sociali ed iniziative aziendali ».
Il Servizio Sociale non può esaurirsi nel caso individuale o nell’attuazione di un buon programma di relazioni umane, « ma si deve necessariamente inserire anche nel settore organizzazione e conduzione del personale ». (pag. 25).
DISCUSSIONI SUL QUARTO STRUMENTO DI LAVORO: IL RUOLO DELL’A.S. DI FABBRICA
La discussione del gruppo inizia dopo la lettura dei vari punti da trattare. Si osserva che in generale le assistenti non sono inserite in fabbrica con tutti i compiti enunciati dallo schema; soltanto in alcune Sedi il lavoro è stato impostato secondo quanto in esame, e questo sta realizzandosi secondo un preventivo piano di lavoro formulato dapprima in sede teorica, da trasferirsi conseguentemente in pratica.
Si propone di esaminare in particolare i frutti delle varie esperienze personali.
Il leader, sentito il gruppo, chiede di approfondire in quali dei punti fìssati, il ruolo reale dell’A.S. in servizio, diverge da quello designato. Si procede ad esaminare le varie esperienze, realizzate dalle partecipanti, quanto all’assunzione di nuovi elementi nell’azienda evidenziano i metodi attuali, i risultati conseguiti. Dalla totalità dei casi esposti, è emerso che tale compito dell’A.S. è circoscritto a casi sporadici. Si è notato ad esempio, che nell’ambito della stessa azienda, mentre talvolta è stata affidata all’A,S. l’inchiesta su casi di riassunzione, la sua collaborazione non è però richiesta per la scelta dei nuovi elementi. Il gruppo cerca di approfondire i motivi per cui YA. S. viene esclusa dalla consultazione su di un compito che le dovrebbe competere; si è visto che tale deficienza dipende in gran parte dalla parziale conoscenza delle funzioni dell’A.S. da parte dei datori di lavoro. A testimonianza di questa carenza, si pone in rilievo che alcuni imprenditori, per difetto di informazione, riducono il Servizio Sociale ad attività di patronato o ad opere di beneficenza.
Un membro del gruppo espone i vantaggi tratti dall’aver presentato alla Direzione di varie Ditte un grafico dei compiti dell’A.S. ed un piano di lavoro dettagliatamente esteso, desunto dai programmi di specializzati nel S.S. di fabbrica. Si fa ancora rilevare come, per poter svolgere un servizio sociale di fabbrica il più possibile completo, un’A.S. debba avere la possibilità di seguire molto da vicino gli operai e quindi di dedicare ad una fabbrica tutto il tempo che essa richiede, e di avvicinare gli operai sul posto di lavoro. Riportando situazioni personali, tutti i membri mettono in evidenza le difficoltà inerenti a queste due condizioni. L’orario di servizio dell’A.S. presso una fabbrica è spesso subordinato a vari altri compiti a lei affidati, e risulta talvolta insufficiente alle esigenze del lavoro da svolgere. Inoltre, nella quasi totalità dei casi, gli incontri fra operai ed assistente avvengono negli intervalli dei turni.
Solo raramente l’Assistente può chiamare i lavoratori o visitare i vari reparti durante la lavorazione; questo dipende da vari elementi tra cui la natura stessa della lavorazione, talvolta pericolosa, e anche dell’apertura sociale dell’azienda.
Il leader fa notare come l’A.S. dovrebbe qualche volta visitare i reparti per conoscere il particolare atteggiamento psicologico dell’operaio nei confronti del lavoro che ordinariamente svolge, elemento indispensabile per una giusta valutazione dei problemi del lavoratore. Passando ad esaminare i punti successivi il gruppo nota come, alcuni di essi, pongano in luce problemi simili, con difficoltà e soluzioni pressocchè analoghe.
Lo schema in esame infatti, chiede se:
– l’A. S. tratta i casi di disadattamento al lavoro– se si interessa e mira alla soluzione dei casi di scarso rendimento– se previene le conseguenze che derivano dalla penosità del lavoro o dalla insoddisfazione del lavoratore. A questo proposito, dalla discussione emerge che spesso l’A.S. ha modo di trattare problemi del genere, in particolare di disadattamento al lavoro, di cui viene a conoscenza per specifica richiesta del cliente; raramente il caso è segnalato dalla Direzione. Quasi tutti i membri riferiscono su esperienze che espongono limiti e situazioni che lasciano intravedere varie sensibilità delle Direzioni ai problemi umani dei dipendenti.
Presso una Azienda la Direzione ha affidato all’A.S. il compito specifico di condurre un inchiesta sull’atteggiamento psicologico di una parte di lavoratori nei confronti della loro partecipazione abituale. Si trattava di 60 operaie poco assunte; l’inchiesta aveva lo scopo di mettere in evidenza le eventuali difficoltà che incontravano circa l’orario e l’ambiente, le personali preferenze fra le varie forme di lavoro della fabbrica, le modifiche che avrebbero auspicato. L’inchiesta tuttora in corso di svolgimento, è condotta su schema e con metodo fissati dall’A.S. Riguardo all’attuazione di provvedimenti atti a migliorare la situazione del lavoratore nei confronti del suo lavoro, il leader sintetizza i pareri dei vari membri i quali opinano che agendo su casi singoli ed isolati, vi è raramente la possibilità di ottenere realizzazioni pratiche su vasta scala. L’esame dell’ultimo punto, ha subito messo in evidenza le difficoltà riscontrate da tutte nello svolgimento di un’azione tendente ad « una migliore coesione sociale ». Un A.S. nota come, per giungere a questo, sia necessaria una approfondita conoscenza delle « relazioni umane », che non sempre l’Assistente stessa possiede. Inoltre per poter svolgere su questo piano un’attività valida ed efficiente, l’A.S. dovrebbe potersi valere della collaborazione di una èquipe di esperti, cosa che ancora nessuno dei membri presenti ha avuto la possibilità di fare. Si nota infine che questo punto è, in ultima analisi, il risultato di tutta l’attività dell’A.S., e che però postula ed implica l’inserimento efficiente dell’A.S. nell’ambiente di fabbrica, la sua partecipazione attiva alla vita di essa. Per poter giungere a questo, il gruppo è ben convinto della necessità della presentazione dell’A.S. alla Direzione da parte dell’Ente, con il Programma specifico dettagliatamente redatto dallo stesso su schemi tipici, a seconda delle essenziali caratteristiche ed esigenze della piccola-media e grande azienda. A conclusione della discussione, si auspica e il Centro elabori uno schema di piano di lavoro dell’A.S. di fabbrica, che ne chiarisca esattamente i compiti e ne delinei nettamente il Profilo.
Il gruppo ha ritenuto opportuno prendere in esame l’ultimo dei punti relativi al ruolo dell’Assistente Sociale di Fabbrica.
Punto di discussione
L’A.S. contribuisce a stabilire nell’azienda una migliore « coesione sociale » ossia un migliore funzionamento della comunità aziendale considerata come un tutto organico. Il gruppo è d’accordo nell’affermare che l’A.S. deve contribuire a favorire e a migliorare i rapporti interindividuali dei lavoratori e i rapporti tra i lavoratori e i dirigenti. Sappiamo che nell’ambiente di lavoro si creano spesso delle ostilità di alcuni elementi nei confronti di altri per motivi diversi (promozioni, premi di produttività etc.) tanto che l’A.S. deve promuovere una atmosfera di reciproca comprensione e rispetto svolgendo nei suoi contatti individuali azione di chiarificazione. Si chiede quali siano le iniziative che contribuiscono a migliorare le relazioni nell’azienda. Le assistenti concordi suggeriscono le seguenti iniziative riferendosi alle loro esperienze già effettuate:
1. promuovere riunioni con capi intermedi e capi-reparto per poter maggiormente collaborare alla soluzione dei problemi dei dipendenti e delle eventuali deficienze di organizzazione e struttura dell’azienda dando il proprio apporto;
2. partecipare alle riunioni del Comitato di Sicurezza Antinfortunistica Aziendale;
3. collaborare con tutte le attività a carattere assistenziale (Cassa Mutua Interna, S. Vincenzo, etc.) già esistenti nella Fabbrica;
4. favorire le iniziative di gruppo, promuovendo in esse il contributo di interessamento, di consiglio, di partecipazione degli operai, nei seguenti settori:
a) culturale-educativo (proiezioni antinfortunistiche in collaborazione con l’ENPI, proiezioni scientifiche, etc).b) artistico (mostre di pittura dei lavoratori, concerti se è possibile dati anche dai lavoratori, rappresentazione di prosa o arte varia);
c) ricreativo (gite, gare sportive, cineforum, etc.);
d) eventuali corsi di tagli e cucito per le operaie;
e) corsi di educazione civica;
5. promuovere l’istituzione di biblioteche circolanti;
6. promuovere l’istituzione di campeggi, colonie per i figli dei dipendenti, impegnando i lavoratori;
7. collaborare all’istituzione di case per ferie. Ci si domanda quale sia l’atteggiamento Che l’A. S. deve assumere in caso di sciopero. Si fanno in primo luogo le seguenti distinzioni:
a) sciopero economico;
b) sciopero politico.
La discussione diviene molto animata, infine però il gruppo ritiene che in caso di sciopero qualsiasi sia la causa, giusta o ingiusta, l’A s dovrebbe presentarsi in fabbrica, perchè la sua posizione è al di sopra delle parti. Un’A.S fa presente di essere stata impedita con la forza da parte degli operai di recarsi sul posto di lavoro. Pertanto il gruppo discute su di ciò e conclude che, in casi di forza, è bene che l’A.S. si astenga dal presentarsi informandone la Direzione della Fabbrica. Il gruppo concorde afferma che il suo atteggiamento non deve essere però agnostico, ma attivo, cioè che l’A.S. deve fare opera di chiarificazione nei confronti dei dipendenti (se richiesta) e verso i dirigenti e i capi-reparto, specie nella prima fase di preparazione dello sciopero. Durante questo periodo curerà di conoscere le cause che determinano lo sciopero, interpellando la Direzione, la Commissione Interna, i Sindacati, le ACLI.
Nell’ambito della discussione è sorto un dibattito circa il comportamento dell’A.S. nei confronti del cliente che si presenta a far sollecitare una pratica già patrocinata da un altro Ente di patronato, qualunque esso sia. Si premette che il sollecito può essere fatto a voce presso l’istituto competente, o facendo firmare all’interessato una nuova delega. Il gruppo ritiene che l’A.S., pur cercando di creare dei rapporti cordiali con il cliente, aiutarlo, seguirlo, non può assumere Patrocinio della pratica, per motivi di giustizia e morale professionale; mentre per alcuni casi (lontananza, spese richieste dal funzionario dell’Ente patrocinatore, etc.) può farlo.
Quinto strumento di lavoro: Ruolo particolare dell’Assistente Sociale di Fabbrica ONARMO
Svolgere accuratamente e con esattezza il proprio compito professionale, secondo una interpretazione intelligente, aggiornata e generosa;
collaborare all’apostolato dei Cappellani del Lavoro fedelmente, con interiore adesione; tendere e cooperare all’attuazione della Comunità Aziendale;
trasferire il significato delle verità sovrannaturali della fede cristiana nei principi filosofici, psicologici e sociologici che informano le tecniche specifiche del Servizio Sociale, giovandosi dell’altissimo contributo di tali verità;
partecipare il tesoro di fiducia, speranza ed amore del Cristianesimo non solo attraverso il proprio abituale sforzo di comportamento coerente, ma anche nei momenti gravi della vita, della sofferenza e della gioia dei clienti;
credere alla forza della preghiera nei casi in cui ogni accorgimento umano è inadeguato (e-venti irrimediabili, irriducibilità di vizi, contrasti, situazioni).
Discussioni sul quinto� strumento di lavoro: Ruolo particolare dell’A.S. di Fabbrica ONARMO
Il gruppo dopo aver premesso che l’A.S. ONARMO deve anzitutto essere ben qualificata professionalmente, ha preso in esame la collaborazione con il Cappellano del Lavoro.Dall’esame delle varie situazioni è emerso che non in tutte le Fabbriche è presente il Cappellano del Lavoro. In alcune è presente solo per determinate circostanze (precetto Pasquale, commemorazioni festive, 1° Venerdì); in altre viene chiamato sporadicamente un Sacerdote per casi in cui solo il suo parere può risolvere una data situazione. È stato chiesto là dove esiste il servizio religioso regolare, come si attui la collaborazione col servizio sociale .Dai vari interventi è risultato che in alcuni casi essa avviene mediante la reciproca segnalazione di ammalati da visitare oppure con la discussione di casi durante gli incontri nella Conferenza di S.Vincenzo. In altri la collaborazione è ancor più soddisfacente, perchè con essa si determina una interazione tra l’opera dell’A.S. e del Cappellano, interazione che permette di considerare l’uomo nella totalità delle sue esigenze sul piano materiale e spirituale, in funzione del fine per cui esso è stato creato. Tale collaborazione esige naturalmente da parte dell’A.S. una interiore adesione. Una partecipante al gruppo dice che in mancanza del Cappellano del lavoro nella sua azienda, quando sia necessario, ricorre ad altro Sacerdote per consiglio ed appoggio. Si è fatto presente che le possibilità di apporto del Cappellano inserito nella Fabbrica, rispetto al Sacerdote che ne è fuori siano di gran lunga superiori, in quanto al pari dell’A.S. egli che conosce l’ambiente dove l’assistito lavora, può intervenire con più efficacia essendo il suo apostolato già noto e già stimato nell’ambiente. Talvolta la collaborazione soffre interferenze di attività, per lo più a motivo del cliente che si rivolge ad una delle due persone impropriamente rispetto alla risoluzione del suo problema.
Riconosciuti i benefici che il servizio religioso porta nell’ambiente di fabbrica, si asserì che l’A.S. può e deve adoperarsi per l’insimento del Cappellano chiarendo tanto alla maestranza che ai dirigenti il suo ruolo precipuo. La carenza dei Sacerdoti, diffusa un dovunque, impedisce alle Diocesi la nomina dei Cappellani del Lavoro per cui in alcuni Centri si provvede alla designazione di uno che operi nell’ambito di più aziende. 8Si intende che anche per il Cappellano, come per l’A. S. occorre una particolare attitudine a tal genere di Apostolato, non disgiunta da una preparazione tecnica cui si auspica che l’ONARMO possa continuare a provvedere. Prima di esaminare se e come l’A.S. cooperi all’attuazione della Comunità aziendale si vuole dare una chiarificazione al concetto di comunità, intesa come una entità costituita da persone legate fra di loro da interessi economici, da rapporti reciproci, finalità ed aspirazioni comuni sul piano umano, tecnico, spirituale. Tutti i componenti la comunità, ciascuno nel proprio ruolo: imprenditori, capi, dirigenti, prestatori d’opera, l’A.S. ed il Cappellano, non lavorano per un fine proprio, ma per l’interesse superiore della comunità aziendale e quindi di tutti. Una azienda così concepita non si chiude nel proprio alveo, nè si estranea alle situazioni delle altre Aziende, ma si sente parte di tutta la comunità operante.
Si esamina allora come l’A.S. possa adoperarsi per favorire la realizzazione di tale comunità. Una partecipante fa notare che l’applicazione stessa delle tecniche del S. S. può essere già considerata un mezzo. Indispensabile è comunque sviluppare fra i singoli il senso comunitario con metodi di lavoro appropriati allo scopo, quali l’instaurare una abituale collaborazione tra tutti i membri delle aziende, il lavoro di gruppo e l’attuazione di altre iniziative, promuovere fra i membri la conoscenza, la comprensione ed il rispetto reciproco, stimolarne l’interesse ai comuni problemi. Un altro metodo efficacissimo è quello delle Relazioni Umane, movimento a cui l’A.S. collabora, partecipa, contribuendo e facilitando i ,ab0ra’ti e creando un linguaggio comune fra individui ed i gruppi dell’azienda. Il discorso indugia per chiarire cosa debba intendersi per Relazioni Umane: infine si assume che le Risorse Umane più che uno schema di tecniche debbano intendere come una filosofia di gelone, fondata sulla giustizia sociale e sulla dignità della persona umana. Uno dei fondamentali aspetti di un programma di R.U. è la informazione bidirezionale che va dal vertice alla base e viceversa.
Anche il Cappellano con la sua attività, con la formazione di gruppi religiosi in azienda (Apostolato della Preghiera, Conferenza di S. Vincenzo) facilita l’effettuazione delle R.U. Gli ostacoli all’attuarsi della Comunità aziendale sono gli stessi che si presentano nell’attuazione del S.S. nella sua interezza. L’A.S. può far molto anche con la sua azione educativa che facilita lo sviluppo della personalità e svincola i singoli dalle limitazioni dei propri pregiudizi ed egoismi. Passiamo poi ad esaminare il contenuto spirituale del Servizio Sociale ONARMO. Ci siamo soffermate sul modo come trasferire sul piano pratico il significato delle verità sovrannaturali che ci animano. Sappiamo che ogni uomo tende ad un fine, anche se inconsapevolmente, il fine ultimo che è Dio e la salvezza dell’anima. Tutti gli uomini sono perciò livellati a tal fine ed affratellati dal desiderio di raggiungerlo. L’A.S. valorizza e parte prima dall’elemento umano, perchè non se ne può prescindere, quindi gradatamente porta il cliente ad avere una visione soprannaturale delle sue azioni e dei suoi problemi. Ne consegue che anche di fronte a situazioni di estrema difficoltà e talvolta insolubili, non tralasciamo di illuminare il cliente facendolo Partecipe del tesoro di fiducia del cristianesimo.
Si è d’accordo che il problema religioso, prima di trasferirlo al Cappellano, va affrontato gradualmente dall’A.S. e soltanto dopo aver stabilito contatti di fiducia e stima. Il modo di partecipare ai problemi umani, alla vita, alla gioia, alle sofferenze del cliente, è legato alla preparazione, esperienza, sensibilità di ogni assistente.
L’A.S. per prima dovrà essere lei stessa informata a questi principi, sentirli, viverli, trasportarli apertamente nel suo modo di agire.
La sua azione può esaurire la carica spirituale, di qui il bisogno di ricorrere alla Grazia attraverso i Sacramenti e la preghiera.
Gruppo di lavoro sul tema: Ruolo dell’A.S. di fabbrica nell’Onarmo
II gruppo sottolinea le necessità di svolgere anzitutto un’azione ben qualificata, il che significa porre a disposizione dei clienti la propria intelligenza, e cultura e le doti morali. Passa poi a considerare la collaborazione dell’A.S. col Cappellano del Lavoro, i reciproci rapporti, i ruoli ed i limiti rispettivi, le forme della cooperazione. Passando poi a riflettere sul come un’A.S. Onarmo possa contribuire al realizzarsi di una
maggior coesione sociale nell’azienda, il gruppo cerca dapprima di definire il significato di comunità. Il gruppo è concorde nell’asserire che la Comunità Aziendale, è ancora, in genere, solo un ideale da raggiungere, anche se in qualche impresa si possono notare dei segni che inducono a sperare in una concreta realtà. Secondo un membro del gruppo l’introduzione dei metodi professionali costituisce un rapporto notevole da parte dell’A.S. l’azione di chiarificazione; di ammorbidimento, di sensibilizzazione che un’A.S. svolge per amalgamare maestranze e dirigenti, rappresenta questo fattore d’integrazione. Se poi questi metodi vengono utilizzati con abilità da una persona che li ha assorbiti in un’interiorità che sa guardare e valutare gli uomini come partecipi ad un comune eterno destino, e che si rende umile, pronta alla preghiera così come all’azione, permeata di speranza e di serenità oltre l’evidenza contingente in modo che la sua azione coerente si distingua abbastanza nettamente, la carica di solidarietà di questi metodi si comunicherà e informerà l’ambiente.
Conclusioni del Convegno
Le A.S. di Fabbrica dell’ONARMO, al termine delle loro riunioni di studio e di discussione del Seminario Nazionale sul Servizio Sociale di Impresa
RICONOSCENDO
che il ruolo degli A. S. aziendali è in continuo sviluppo, determinato dal continuo evolversi della coscienza umana e sociale dell’impresa, dipendente, anch’essa, dal progressivo, incessante dinamismo delle strutture sociali, economiche, politiche e spirituali proprie del nostro Paese e del tempo;
AFFERMANO
in primo luogo la costante validità dell’indirizzo religioso nel quale l’Onarmo, dalle origini, ha impostato il loro ruolo, tale indirizzo permanendo il più atto a raggiungere, attraverso la mobilitazione dei valori spirituali personali, dei gruppi e della Comunità, risultati autentici ed integrali, sul piano umano e sociale dei gravi problemi e conflitti attuali del lavoro;
assicurano la loro volonterosa collaborazione, nell’opera e nello spirito, all’apostolato dei Cappellani del Lavoro;
CONFERMANO
la loro costante volontà di perfezionarsi nel loro ruolo professionale,
DOMANDANO ALLA $EDE CENTRALE
a) di poter giovarsi più regolarmente di una consulenza tecnica nel loro servizio di Fabbrica;
b) di usufruire più largamente della supervisione qualificata
PROPONENDOSI
di dedicare una parte della loro attività professionale, sotto guida competente (ove possibile quella delle Scuole di Servizio Sociale) dell’Ente utilizzando, allo scopo, la formazione e l’esperienza degli A.S. della loro Sede, secondo le tecniche del lavoro di Gruppo
RITENGONO
di segnalare soprattutto il loro interesse per lo studio della Sociologia industriale, per la Psicologia applicata al lavoro, oltre che per la Storia dei movimenti sindacali, e per l’Economia.
Problematica sindacale attuale determinata dallo sviluppo tecnologico industriale, 11-12, 1960, pp. 4-11.
di Vito Santoro
1. – L’introduzione nei processi di lavorazione delle nuove tecniche di meccanizzazione e di automazione provoca i seguenti effetti nei rapporti di lavoro :
a) divisione parcellare del lavoro. Il processo produttivo viene frazionato tra i singoli operatori a ciascuno dei quali viene chiesto un compito « parcellare» e di natura elementare;
b) dequalificazione professionale del lavoratore, che trasferisce le sue capacità alla macchina, limitandosi a regolarla. Ad esempio i moderni torni a revolver sono capaci di lavorare con molta maggior precisione di un provetto tornitore, il quale oggi si limita a mettere in azione la macchina ed a regolare i vari parametri. Il processo di meccanizzazione raggiunge gli sviluppi più elevati nelle industrie chimiche ed in quelle della raffinazione, dove l’operatore esercita solo una funzione di sorveglianza, perchè il flusso produttivo proceda nei modi prestabiliti. I moderni impianti chimici sono forniti di sistema di autoregolazione e autocontrollo tali che, superando alcune tolleranze minime e massime, gli impianti produttivi segnalano, attraverso apposite spie, la perdita di controllo. Al processo di dequalificazione si accompagna l’esigenza di una maggiore esperienza del lavoratore per ogni posto di lavoro e in questo aspetto si crea un legame di tipo nuovo tra il processo produttivo e il lavoro.
c) Nella misura in cui aumenta il processo di meccanizzazione, il grado di responsabilità del lavoratore rispetto al processo e rispetto alla macchina aumenta. Pertanto, l’imprenditore nel’ l’assunzione dei lavoratori è portato a tener presente questa particolare esigenza del processo produttivo. Le quote di lavoro che si trovano ad essere liberate, in seguito all’introduzione delle nuove macchine, solo raramente sono reimpiegate all’interno dello stesso complesso produttivo, per cui vi sarà disoccupazione tecnologica nell’ipotesi di un mercato del lavoro a pieno impiego ed un incremento della disoccupazione strutturale ove vi sia sovrabbondanza di offerta di lavoro. Tuttavia, in un mercato di lavoro a basso tasso di disoccupazione, il lavoratore non subisce lo choc psicologico del licenziamento, poichè le esigenze di mano d’opera, soprattutto qualificata, sono in continuo aumento. Inoltre non è da escludere che il lavoratore, attirato da impieghi più remunerativi, elevi il grado di mobilità del lavoro.
2. – Di fronte al verificarsi di questa trasformazione airinterno del mercato del lavoro, in seguito all’introduzione di nuove macchine e alle trasformazioni tecnologiche, sorgono per il sindacato due esigenze contemporanee: quella di salvaguardare gli interessi dei non qualificati e quella di garantire gli interessi del personale altamente qualificato, a cui è affidata la manutenzione e la responsabilità ultima dell’andamento della macchina e di parte del processo di lavoro.
a) Per quanto riguarda il Primo punto, va detto che il sindacato è impegnato costantemente alla salvaguardia del posto di lavoro e alla più esatta classificazione del lavoro. Di qui l’impiego delle tecniche di « job evaluation » in luogo delle tecniche di classificazione basate sulle qualifiche. Va tuttavia aggiunto che l’atteggiamento del sindacato tendente alla conservazione del posto di lavoro, non assume nè assumerà nel futuro eccessiva rigidità, semprechè si adeguino gli strumenti di garanzia del lavoratore, onde non ostacolare le necessarie trasformazioni tecnologiche. Una maggiore mobilità di lavoro debitamente assistita, sarà, pertanto, la conseguenza di questo più duttile e più dinamico atteggiamento del sindacato.
b) Per quanto riguarda il punto secondo il sindacato potrà rispondere alle esigenze di salvaguardare gli interessi dei gruppi di specializzati, sia assicurando, ove del caso, una nuova rappresentanza sindacale (unioni di mestiere in luogo delle unioni di industria) sia adeguando il contenuto contrattuale che non può non fondarsi sul significato e il valore della professione esercitata.
3. – Il progresso tecnico tende a manifestare una sua influenza anche sul livello dei salari e si deve attendere che le quote addizionali di reddito poste a disposizione del progresso tecnico debbano essere ripartite in modo equo tra lavoratàri, produttori e consumatori. Tanto più elevato è il ritmo di crescita del reddito, dovuto al progresso tecnico, tanto più marcata e incisiva deve essere l’azione del sindacato in vista di realizzare una equa distribuzione del prodotto netto addizionale. Le modalità di ripartizione di questo Addito addizionale possono essere fondamentalmente due:
a) Una ripartizione del prodotto addizionale ottenuta attraverso l’incremento dei salari (operando con il massimo decentramento contrattuale) fermo restando la durata attuale degli orari di lavoro;
b) oppure una riduzione della durata del lavoro, fermo restando il livello attuale dei salari. Anche in questo caso gli strumenti di realizzazione dovrebbero essere quelli della contrattazione decentrata (per non determinare effetti inflazionistici) e in tale seconda ipotesi si potrebbe contare su un ritmo di accrescimento dell’occupazione più intenso di quello che si avrebbe operando come indicato al punto a).
Ne consegue che l’azione del sindacato dovrà essere fondamentalmente accorta nell’utilizzare l’uno o l’altro strumento soprattutto per impedire che si abbiano slittamenti inflazionistici o mantenimento di un saggio elevato di disoccupazione. Il progresso tecnico inoltre crea problemi del tutto nuovi sul piano della preparazione delle forze di lavoro.
Si rende sempre più necessaria una appropriata formazione culturale generale di base.
Tutti i lavoratori devono possedere alcuni requisiti minimi culturali che li mettano in grado di esercitare giudizi sintetici che realizzino il coordinamento di vari elementi : poichè proprio questo richiedono le nuove tecniche produttive.
Influenze decisive si esercitano sia sui criteri, sia sui metodi da impiegare nelle formazioni dei giovani da un lato e nella riconversione delle capacità professionali degli adulti.
Occorre:
a) operare sulle strutture scolastiche esistenti (scuole professionali);
b) adeguare i metodi di insegnamento nell’industria;
c) adottare tecniche di addestramento rapide;
d) adottare nuovi criteri nei corsi di qualificazione e riqualificazione. Tutto il vasto campo delle strutture formative deve rapidamente aggiornare i suoi obiettivi, i suoi metodi, i suoi programmi. Sotto questo profilo è di estrema importanza l’adeguamento degli istruttori. Da ultimo il progresso tecnico nella misura in cui si tradurrà, come inevitabilmente accadrà, nel medio o nel lungo periodo, in una sostanziale riduzione della durata del lavoro allargherà la fascia del tempo libero.
Il problema del tempo libero è un problema comunitario nel senso più vasto della parola in quanto impegna tutte le forze della società e non soltanto il sindacato o l’azienda. Sotto questo profilo è estremamente importante il ruolo che possono svolgere i moderni metodi di comunicazione di massa, quali la televisione, la radio, i giornali, i periodici, i libri, ecc.
Un problema fondamentale è che questi mezzi di comunicazione:
a) diano un contributo all’elevamento culturale e civile di tutti i cittadini e quindi anche dei lavoratori;
b) sappiano trarre e difendere ed esaltare i valori morali e civili della nostra comunità;
c) sappiano consolidare la loro vitalità nel nostro popolo. Solo così il problema del tempo libero può venire risolto come impegno della società verso se stessa al fine di adeguare se stessa, nella permanenza dei valori fondamentali che la reggono, sia nel campo morale che civile, al contenuto sempre mutevole dei nuovi problemi.
4. – In Italia il sindacato si trova inoltre contemporaneamente di fronte a problemi propri delle zone altamente sviluppate e a quelli delle zone in sottosviluppo. In genere nelle prime assistiamo ad un alto grado di specializzazione del lavoro e ad un basso livello di disoccupazione, mentre nelle seconde siamo in presenza di mancanza di qualificazione e di diffusa disoccupazione La funzione che il sindacato deve assolvere in ciascuna di esse è varia:
a) nelle prime deve non ostacolare la mobilità del lavoro, sotto determinate garanzie, ed assolvere alla funzione di contrattare tutte le condizioni alle quali la prestazione deve avvenire;
b) nelle seconde, dove il suo potere negoziale tra l’altro è minore, deve assolvere a funzioni di sollecitazione generale dello sviluppo economico, stimolando i pubblici poteri all’assunzione di precise responsabilità economiche di tipo imprenditoriali quando l’industria privata è carente;
c) nelle zone industrializzate, il sindacato è portato ad espandere le proprie responsabilità ed attività sul piano contrattuale. Il nuovo impegno contrattuale deve svilupparsi a livello di settore, di attività economica, di ramo produttivo di azienda. Le materie oggetto della contrattazione variano ovviamente a seconda del livello di negoziazione allargando l’area contrattuale mano a mano che si scende verso le aziende;d) nel quadro dei nuovi sviluppi contrattuali una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla tutela contro la disoccupazione tecnologica. Infatti oltre al ruolo positivo della legislazione sociale occorrerebbe pensare a nuove forme assicurative di origine contrattuale che siano capaci non solo di trasformare, senza costo per il lavoratore, il patrimonio delle professioni e dei mestieri superati dal progresso tecnico, ma di assicurare il più rapido reimpiego di esse.
Organizzazione aziendale di uno stabilimento industriale moderno – Strutture funzionali ed amministrative sullo schema degli scopi diretti della produzione – Rapporti con l’elemento umano: i lavoratori.
Altri avrebbero dovuto illustrare questo tema, non io che conosco le aule unicamente come allievo e che non ho mai tenuto conferenze e che non ho preparato nulla per una esposizione brillante quale era forse nei voti del presente Seminario.
La mia stessa professione mi porta a fatti concreti, immediati, aridi, e se volete, in ciò reali: raramente vado al di là delle cifre per penetrare il contenuto etico e spirituale dei fenomeni e degli avvenimenti, che ho d’attorno. Sono ingegnere in un grande stabilimento chimico dell’Italia Meridionale e mi occupo dei servizi della Fabbrica: l’energia elettrica, il vapore, l’acqua, i gas, ossia tutto quanto serve al regolare esercizio dei reparti di produzione. Guido un certo numero di uomini addetti alla conduzione di impianti, che esigono personale specializzato e che sono efficienti in quanto garantiscono la massima continuità di esercizio ai reparti di produzione già citati. Da questo particolare osservatorio della vita aziendale, molto vicino alla Direzione di fabbrica cui preme e spetta produrre senza soste, ho raccolto una pluriennale esperienza.
Racconto perciò a voi un po’ la mia storia che vi darà forse una visione parziale e limitata del problema che voi volete approfondire, ma il mio sarà in compenso un quadro sincero, senza retorica e senza finzioni.
Debbo premettere qualche cenno sull’organizzazione di una grande azienda, quale quella in cui lavoro, del resto in tutto simile ad altre in cui ho lavorato in passato o con cui ho avuto comunque contatti e conoscenze. Normalmente uno stabilimento fa parte di un gruppo di fabbriche che vengono guidate da una Direzione Generale dislocata in una delle maggiori città italiane: Torino, Milano, Roma, Napoli, etc.
Gli stabilimenti – salvo rare eccezioni – sono alla periferia, ossia dove ricorrono le condizioni ambientali che rendono economica e conveniente l’impresa: affaccio al mare, rete stradale primaria, importanti nodi ferroviari, centrali di produzione di energia elettrica, mano d’opera disponibile, agevolazioni fiscali (vedi leggi sull’industrializzazione del mezzogiorno) e così via. Le Direzioni Generali abbiamo detto prima che sono impiantate in grandi città: e ciò per evidenti ragioni di relazioni con gli ambienti industriali e commerciali di analoghe organizzazioni, nazionali ed estere. Hanno inoltre necessità di rapporti frequenti con gli ambienti ministeriali e politici: l’Italia è un felice paese dove l’industria ha mille doveri burocratici da assolvere prima di poter entrare nella fase produttiva. Per questo molte Società hanno sede a Roma o nella capitale hanno uffici di rappresentanza con il compito di trattare la fantastica e sorprendente (perchè sempre piena di sorprese) materia dei permessi, delle agevolazioni fiscali, dei decreti e giù di lì.
Di norma una direzione generale ha alle proprie dipendenze tre settori:
a) uno prettamente tecnico, che tratta la costruzione dei nuovi impianti, l’esercizio di quelli realizzati e le eventuali modifiche da apportare agli stessi per migliorare la produzione sotto il triplice aspetto qualitativo, quantitativo ed economico;
b) uno amministrativo con tutte le competenze proprie degli uffici di questo ramo che sono variate, dalla contabilità all’inventario patrimoniale, dalla compilazione dei costi alla gestione dei magazzini presso gli stabilimenti, etc.
c) uno infine commerciale che forse avrebbe meritato di essere elencalo per primo, in quanto ha per scopo il fine ultimo (per non dire unico) dell’impresa – distribuzione e vendita dei prodotti. Naturalmente in questo quadro organizzativo ridotto ai minimi termini ho volutamente taciuto di uffici che – in determinate grandi organizzazioni – hanno pure una notevole importanza – gli uffici approvvigionamenti – ad esempio – che hanno tanta parte nell’ordinazione dei materiali per la costruzione degli impianti e poi delle materie prime per il funzionamento degli stessi. Ma – a seconda delle società – detti uffici costituiscono organizzazioni centralizzate ed autonome – in altre dipendono dal settore tecnico ed in altre dal settore amministrativo. Varianti che non interessano il nostro esame.
Per quanto una menzione speciale meritano gli uffici « Personale » di Sede, giacchè spesso sono alla dirette dipendenze del Direttore Generale, convinti come siamo, oggi più di ieri, che il fattore umano è predominante in qualsiasi impresa industriale: viene prima della macchina, prima dell’energia, prima della materia bruta da trasformare. L’uomo è l’artefice – consapevole o non – di tutto quanto una fabbrica produce. Anche il guardiano della portineria della Direzione Generale partecipa al ciclo produttivo con la sua divisa ed i suoi inchini. La contabilità lo classifica tra le spese improduttive, ma non per questo eliminabili e non per questo da escludere da una attenta considerazione. Gli uffici del personale hanno in questi ultimi anni studiato tanto le « Humans Relations » che l’America ci ha regalato come una novità risolutiva di qualsiasi problema. Meglio sarebbe stato se avessero studiato di più il nostro ambiente, le vicende della nostra fabbrica. Che se le avessero confrontate, se avessero ascoltai subito e direttamente le istanze sociali di certe categorie, senza i filtri di una tecnica nuova o psicotecnica che dir si voglia – sarebbe stata sufficiente una più attenta lettura del Vangelo per imparare a scegliere gli uomini ed a governarli. E non voglio con questo essere frainteso; no nego i vantaggi che possono derivare da uno studio sistematico di certi problemi, non penso che si debbano chiudere gli occhi dinanzi ai successi di tecniche nuove per respingerle irragionevolmente, ma non ammetto che si gridi al miracolo, là dove miracolo o novità non ci sono state. Bisogna guardare anche fuori dei nostri confini, ma tutto ciò che non è nostro non è perfetto per definizione e non può essere trasferito da noi senza i necessari adattamenti di ambiente e di persona.
E ben lo sanno gli uffici à« personale à» delle Direzioni Generali; fallirebbero al loro scopo se dovessero limitarsi a cercare degli operai, ad assumerli ed a classificarli per poi tenere aggiornato un ruolino di ingaggio e niente più.
Sono importanti detti uffici se vivi sono i loro contatti con gli stabilimenti e se attraverso di loro le Direzioni Generali possono conoscere il vero volto dei propri dipendenti, di qualsiasi grado e di qualsiasi categoria – dal direttore all’ultimo manovale, perchè degli uomini debbono interessarsi, prima ed al di fuori dei problemi suindicati, agitati troppo spesso a torto e contro tempo. Le pratiche di assunzione, le paghe degli assunti, i rapporti con le Associazioni industriali e con le commissioni interne sono argomenti di ordinaria amministrazione; l’essenziale è che del tono spirituale – più che materiale – le aziende e gli uffici del « personale » debbono essere in grado di avere l’esatta misura, in qualsiasi in grado di avere l’esatta misura, in qualsiasi momento. Bravi quelli che sanno determinare le condizioni di una continua evoluzione nei fattori spirituali che influenzano i lavoratori e la loro quotidiana fatica.
Vedremo in seguito di quali strumenti e di quali metri possono avvalersi alla periferia, ossia presso gli stabilimenti per un’azione capillare più approfondita di quanto non possa aversi dagli uffici « personale » di stabilimento. Già perchè gli stabilimenti ripetono a grandi linee l’organizzazione centrale, che abbiamo prima sommariamente descritte. Vi è una direzione di fabbrica retta da un Direttore, di solito un chimico od un ingegnere di larga esperienza non solo tecnica, ossia non solo strettamente professionale, ma anche sociale.
Dalla Direzione dipende la Produzione ossia i reparti o il gruppo di reparti che hanno il compito di impiegare i macchinari istallati per realizzare determinati cicli produttivi. A capo della produzione è normalmente il Vice-Direttore della Fabbrica proprio per affermare il principio che tutto si deve muovere e fare al servizio delle preminenti esigenze dei reparti impegnati a produrre, sempre di più e sempre meglio.
Sullo stesso piano, la Direzione ha alle dipendenze il Servizio Manutenzione e i Servizi Ausiliari, ossia quegli organismi che debbono assicurare la continuità del funzionamento delle macchine, il primo con tempestivi ed attenti interventi (riparazioni, sostituzioni, revisioni, modifiche) ed i secondi con la fornitura della energia elettrica, l’acqua ed il vapore ossia di guanto ho sopra già elencato per presentare un piano di lavoro da me svolto. Dalla Direzione di Fabbrica dipendono ancora i servizi amministrativi, ossia i corrispondenti del settore già visto nel quadro della Dizione Generale, i quali hanno il compito di curare i servizi generali di fabbrica, dalla guardiana alla mensa, i magazzini generali, sia di ricambi che di materie prime e di prodotti finiti, la contabilità industriale, gli acquisti su piazza, il controllo dei cartellini orologio, la corresponsione delle paghe e degli stipendi e via di seguito.
In vecchie fabbriche i Servizi Amministrativi avevano anche la responsabilità propria dell’Ufficio Personale; ma nelle nuove il capo di questo ufficio è stato messo alle dirette dipendenze del Direttore dello Stabilimento. Non può e non deve infatti il Direttore affidare ad altri il controllo di questo settore che costituisce la fonda-mentale sua occupazione, insieme con quanto riguarda la Produzione. Alla Direzione Generale, il Direttore deve rendere i consuntivi mensili circa l’andamento dei reparti; ma a nessuno sfugge che i risultati sono più o meno buoni a seconda della preparazione del personale addetto alle macchine, a seconda dell’impegno posto da questo nel lavoro, a seconda quindi del suo stato d’animo, del suo tono materiale e spirituale già citato sopra; tono che deve essere ispirato dentro la fabbrica e fuori, nel reparto e nella famiglia, nella mensa della fabbrica e nel bar della piazza. A chi ha esperienza di vita aziendale dispiacerà ricordare che certi direttori si avvalevano – un tempo – di persone di fiducia, di informatori, per sapere cosa pensavano i suoi operai, cosa attendevano e talvolta cosa preparavano contro la Direzione stessa per la risoluzione di certi loro assillanti problemi. Oggi non c’è più bisogno di simile regime poliziesco. Almeno per le industrie di importanza nazionale esistono chiari contratti di lavoro, liberamente sottoscritti dalle parti interessate ossia dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esistono pure efficaci mezzi di controllo per il rispetto di detti contratti, anche in questo caso da entrambe le parti.
I citati uffici del « personale » di stabilimento sono strumenti validi per l’applicazione delle clausole contrattuali come delle norme di legge, 1 suindicati sono i vigili custodi degli interessi dei lavoratori. Tralascio volutamente di commentare l’operato di certi Sindacati pur di fare distinzione fra un Sindacato e l’altro: andremmo fuori tema, perchè non dobbiamo indagare su situazioni contingenti e particolari. Tornando al nostro quadro, dovevo rispondere a come oggi un Direttore di Fabbrica può sapere tutto il possibile dei propri operai senza ricorrere a sistemi non qualificabili.
Ha il proprio capo del personale con uffici appositamente dotati di impiegati, di scrivanie, di dati anagrafici, di schede, di informazioni ufficiali; ha quindi la possibilità di conoscere in qualsiasi momento la veste esteriore dei propri dipendenti. Ma un Direttore pensoso delle sorti della fabbrica e degli uomini che gli sono stati affidati, ne vuole conoscere anche l’animo. Questo lo potrà avere solo dal Servizio Sociale, ossia dalle Assistenti di Fabbrica, che gli stabilimenti più sani e più progrediti hanno sempre a propria disposizione – non come dipendenti dirette: che, se vestissero l’uniforme della fabbrica, avrebbero troppe limitazioni non potrebbero rendere a pieno. Non debbo io qui elencare i compiti di detto Servizio, che ha ormai tanti anni di attività e nell’Onarmo ed in opere di diversa denominazione, ma di pari programma. Ritengo solo di fare cosa utile commentando la più recente esperienza fatta presso lo stabilimento in cui lavoro; esperienza non sempre confortante e forse proprio per questo più adatta ad essere illustrata in un Seminario che ha per scopo il perfezionamento della A.S. e del servizio loro affidato.
Non credo di aver detto una verità nuova e brutale, avvertendo che la Direzione della Fabbrica si serve del S.S. come strumento integrativo del proprio Ufficio Personale – per giungere là dove questi non può normalmente arrivare. L’obbiettivo può essere modesto o sublime a seconda di quanto alto sanno guardare gli detti al S.S.: sarà sempre nobile se informato ai principi che l’ONARMO va da anni insegnando nelle sue scuole e negli stabilimenti che le sono stati affidati. Non si dovrà mai trascendere o tradire l’idea. le cristiano: questo è certo. Ma è anche certo che le difficoltà da superare sono tante, specie se si deve operare in un ambiente dove non c’è tradizione industriale e dove la istallazione di nuove fabbriche deve vincere e la natura degli elementi e la diffidenza degli uomini. Rimando alle cronache dei giornali ed ai libri più recenti, che hanno trattato il problema della industrializzazione del Mezzogiorno d’Italia ed hanno riferito episodi diventati ora drammatici di questa realtà nuova per le genti del sud. Posso testimoniare come fin dagli inizi della nostra attività in Sicilia, S.E. Mons. Baldelli volle incontrare i Dirigenti milanesi e mettere a loro disposizione il S.S. dell’ONARMO, le assistenti, i Cappellani, il Centro Sociale, il Centro Missionario e tutta l’organizzazione di Roma. Da allora sono passati quattro anni è solo à°ggi – secondo me – abbiamo i primi risultati positivi – pochi ma sicuri tanto da incoraggiarci sulla strada intrapresa. Quante ansie, quante delusioni, quanto spreco di energia e di denaro (già perchè anche questo occorre) prima di muovere qualche passo e di trovare la via giusta!!
Nuovi ed inesperti gli operai portati a lavorare nella fabbrica; ma inesperti anche il giovane assistente assegnato allo stabilimento, anche il sacerdote novello, nominato per l’occasione Cappellano del Lavoro – diplomato brillantemente il primo in una scuola di Catania, ma capace solo di formulare teorie, e non di accostare e sentire gli operai; magnifico esempio di bontà il secondo, ma odoroso di incenso e non polvere, di peccati raccolti dalle labbra di altri cento, operai incalliti nel vizio, un giorno lontano e poi redenti.
Comunque oggi la realtà è la seguente: lo stabilimento lavora a pieno ritmo – duemila-cinquecento operai circa sono impegnati a far funzionare le macchine installate, altrettanti lavorano per montare nuove macchine e dar vita a nuove lavorazioni. Un A.S. ha sede stabile nella Fabbrica ed un ordine di servizio ha avvertito tutti i dipendenti che possono rivolgersi a lei per qualsiasi necessità.
Un’altra A.S. mantiene i collegamenti fra la fabbrica ed il centro sociale, potenziato di recente e sistemalo appena fuori dallo stabilimento in ariosi locali presi in affitto per l’occasione. Queste due A.S. hanno colloqui frequenti con la Direzione e con l’Ufficio Personale – alla loro sensibilità ed alla loro operosità è affidato l’intero servizio. Dal Centro Sociale verrà distaccato un collaboratore per assistere le famiglie dei lavoratori anche nei paesi d’origine – penetrazione difficile quanto indispensabile anche a non breve scadenza. Ma le occasioni di contatto con essa non mancheranno certamente. Nell’estate scorsa l’A.S. ONARMO ha accompagnato i figli dei lavoratori alle Colonie, ha giocato con loro, ha poi parlato con le mamme e talvolta con i lavoratori stessi. Continuare il colloquio non sarà difficile. Ogni giorno c’è l’infortunio che porta il ricovero del lavoratore in ospedale; là l’A.S. od il Cappellano potranno esser presenti ed utilissimi. Ci saranno poi anche le liete ricorrenze in cui gli stessi lavoratori si faranno più aperti e accoglieranno i nostri con un largo sorriso: la festa del paese, la Cresima o la Prima Comunione di un figliolo, il Battesimo del primogenito, visto che la Fabbrica ha raccolto soprattutto gente giovane e di conseguenza giovani famiglie.
L’attività di Patronato potrà essere parte utile del loro servizio.
La Direzione dello Stabilimento darà atto dei risultati che verranno conseguiti e confida nell’opera delle Assistenti per accelerare il processo di maturazione della classe operaia, anche in questa zona tradizionalmente agricola ed indolente.
Ed il processo dovrà essere chiaro, illuminante per evitare che si ripetano le penose esperienze di un lungo sciopero effettuato nel febbraio scorso. Gli operai vi hanno aderito allora perchè non sapevano che cosa potesse significare una manifestazione del genere per loro del tutto inconsueta, come inconsueta era stata l’offerta di un lavoro sicuro e ben remunerato, almeno al confronto con le mercedi d’uso sulla piazza. Gli stessi Cappellani del Lavoro non sapevano più a chi dare ragione; l’assistente sociale per evitare il peggio si eclissò (era sola e temeva il contatto con la Direzione); la popolazione partecipò divertita ai caroselli della polizia quasi lo spettacolo non dovesse avere altro scopo che lo svago dopo la struggente monotonia degli anni trascorsi senza gli industriali del Nord.
E tutto ciò si sarebbe forse potuto evitare se fra maestranze e Direzione ci fosse stato un clima di maggiore fiducia reciproca, se Cappellani ed A.S. avessero potuto esercitare quella azione catalizzatrice che fa identificare l’interesse dei lavoratori con le esigenze di una Direzione consapevole e generosa. Questo non è stato per noi nei mesi scorsi, ma potrà esserlo in avvenire. I mezzi ci sono: affinateli nelle libere discussioni che animeranno questo seminario per il quale formulo gli auguri più vivi. Uno fondamentale; che abbiate persone adatte per trattare la meravigliosa materia che ha come oggetto i lavoratori, ossia gli umili imitatori del Cristo, vero Dio e vero Uomo; il quale nella officina di Giuseppe, Suo padre, ci ha per primo insegnato le amarezze e le gioie del lavoro.
Possibilità di contenzioso infortunistico dell’opera di Patronato O.N.A.R.M.O., 11-12, 1960, pp. 16-21.
L’argomento si inserisce nel vasto e complesso problema dell’A.S. Tale aspetto dell’A.S. intendo lumeggiare, senza voler esibire un’esposizione di carattere dottrinario.
Tuttavia appare utile sottolineare il significato e l’importanza dei Patronati e quindi descriverne l’azione nei confronti del lavoratore e dell’istituto Assicurativo.
Assistenza sociale e servizio sociale
Uno dei più salienti ed organici difetti della nostra moderna Società è costituito dalla eccessiva collettivizzazione e meccanizzazione e dalla conseguente spersonalizzazione dell’individuo. L’Assistenza Sociale, in tutte le sue forme, tende a correggere tale vizio organico ed a riportare sul piano umano i rapporti della vita sociale che avendo perduto tale carattere hanno tolto all’uomo la possibilità di adattarsi alle nuove condizioni di esistenza. Tende, in altre parole, a rendere unitario il problema dell’uomo lasciato insoluto dalla eccessiva specializzazione scientifica e pratica e, per raggiungere lo scopo, si serve del Servizio Sociale che è l’insieme dei mezzi attraverso i quali si vuole realizzare l’incontro tra l’uomo e l’istituzione sociale. In questa azione complessa sono da considerare tre elementi di fondo:
I – La Legislazione Sociale che istituisce un ordine il quale, senza modificare o mortificare la natura umana, crea i presupposti dello sviluppo di un ambiente che la esalti e nobiliti
II – Gli istituti Sociali che sono lo strumento pratico dell’attuazione dei fini fissati dalla legislazione sociale con la costituzione degli organi di Sicurezza Sociale.
III – L’Assistenza Sociale che tende ad avvicinare l’uomo alle risorse sociali e cerca di comunicargli la consapevolezza del suo diritto e di renderlo soggetto e non oggetto dell’interesse sociale che opera in collaborazione con i Patronati, organismi del Servizio Sociale. L’azione del Patronato cerca di rendere edotto il lavoratore dei termini esatti della legislazione e delle norme che regolano il funzionamento del regime di sicurezza sociale, ed assume in pieno la responsabilità della tutela di lui e lo svolgimento della prassi amministrativa e legale relative. Ciò in Italia assume particolare rilievo ed è particolarmente necessario per la complessa, legislazione, cosicchè è difficile trovare tecnici completamente informati di tutte le norme della materia accumulate, sostituite e corrette nel tempo.
Se ne deduce che è indispensabile all’Assistente Sociale la conoscenza vera della legislazione, non solo, ma altresì il possesso reale della parte normativa e dei dettagli della pratica dell’assistenza ed anche dei giudizi, opinioni e reazioni degli assistiti in rapporto alle prestaci erogate.
Tutto ciò, se realizzato, raggiungerebbe gli n; essenziali della sicurezza sociale e determinerebbe anche meglio il conseguimento delle finalità educative e morali che nel nostro Patronato-ONARMO sono l’obiettivo primo di tutta l’assistenza.
Il Patronato-ONARMO va considerato come un organismo vivo e completo di strutturazioni strumentali e di Servizi per il lavoratore.
Pertanto, quale organismo vivente, è soggetto a crescita, a sviluppo, ad arricchimento funzionale a costante ricerca di adeguamento, di espansione e di consolidamento, quali evidenti caratteristiche di prosperità ed efficienza.
Altra considerazione opportuna è quella che il Patronato-ONARMO, opera in una realtà esterna anch’essa in continuo divenire e sviluppo, progressivo, che ne suppone l’opera nel settore, direi più delicato e difficile di disciplina assistenziale: quello dei bisogni sociali individuali e collettivi. La collaborazione tra Servizio e Patronato deve intendersi come un continuo processo di evoluzione negli organi e nelle funzioni del Patronato e con valersi delle esperienze fatte, delle acquisizioni culturali, delle scuole di Servizio Sociale, di Seminari specifici, della buona organizzazione e preparazione dei singoli e della loro buona volontà.
Importante è notare l’aspetto proprio del nostro Patronato-ONARMO orientato, nella propria attività, dal contenuto e sostanza della concezione sociale secondo la morale cattolica. Pertanto devono essere nostri compiti:
I – Promuovere l’assistenza morale del lavoratore negli eventi di danno.
II – Assistere il lavoratore nello svolgimento delle pratiche amministrative e medico-legali onde ottenere per lui le prestazioni previste dalla legge.
in – Comunicare al lavoratore la conoscenza delle leggi sociali e delle norme protettive.
IV – Svolgere assistenza educativa e consultiva nel campo della tutela sociale.
V – Improntare l’opera ai concetti della morale cattolica. Proponendoci progresso e perfezionamento dobbiamo provvedere a curare con maggiore interesse i vari settori:
con il perfezionamento del Servizio Sociale.
con il perfezionamento dei Servizi Sanitari.
con il collegamento efficace fra periferia e centri direttivi.
con il completamento dell’azione Sanitaria mediante l’integrazione continua dell’assistenza legale quando dalla prima (del settore contenzioso amministrativo) si debba passare alla seconda (del settore contenzioso legale).Tutto ciò abbiamo voluto precisare prima di trattare la relativamente ristretta e precisa materia del contenzioso infortunistico.
Contenzioso
Concetto di contenzioso amministrativo e di contenzioso legale Se contenzioso è tutto ciò che è materia di possibile controversia, dobbiamo subito precisare che parlando di contenzioso ci si intende riferire, per quanto concerne la vera e propria opera di Patronato, a quello che vuole essere:
Il contenzioso Amministrativo Infortunistico. Esso è l’insieme di questioni che possono sorgere nei rapporti fra lavoratore e Istituto Assicurativo e di norme che ne regolano lo svolgimento, oltre il quale, sussistendo divergenze tra gli interessi dei singoli (rappresentati dal Patronato) e gli interessi della comunità, (rappresentati dall’istituto Assicurativo) si passa al:Contenzioso Legale. A tutela degli interessi individuali e collettivi (o se preferite nelle controversie fra individuo ed Istituto di assicurazione infortunistica) interviene la funzione dei Tribunali ordinari, giudicanti solo attraverso modalità particolari, costituite dal fatto che il Giudice ordinario è affiancato da tecnici-periti d’ufficio.
Infortunio
Vogliamo pertanto precisare l’infortunio ed i successivi tempi utili sia alle prestazioni offerte dalla legislazione sociale che alle controversie da esaurire in Sede amministrativa: tempi tutti strettamente fissi ed inderogabili affidati alla solerte ed intelligente Opera del Patronato nella persona fisica delle Assistenti Sociali.
Nozioni d’infortunio
Per infortunio s’intende un danno all’individuo lavoratore avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro. Il concetto di danno comprende ogni alterazione esterna od interna, apparente o no, superficiale o profonda, patita da un organismo fisico-psichico per cui se ne determini deterioramento o annientamento.
Tralasciamo di considerare i requisiti della causa di infortunio, le concause, la occasione di lavoro, il rischio « in itenere » ed altre collaterali questioni di infortunistica, per passare alle norme della procedura che più da vicino e personalmente riguardano il Patronato e le Assistenti Sociali per esso operanti.
Procedura
Avvenuto l’infortunio, e supposte eseguite tutte le operazioni di denuncia e di assistenza da parte dei competenti Organismi, si giunge alla parte pratica nelle sue diverse possibilità:
I – L’Istituto assicuratore non crede dover liquidare indennizzi all’assicurato e gliene dà comunicazione con le prescritte modalità. L’assicurato, nostro assistito, può o no accettare. L’Assistente Sociale, competente della materia, deve consigliare l’assistito ed indirizzarlo al Sanitario o al legale del Patronato per i più opportuni e consapevoli consigli o addirittura per l’assistenza nella opposizione all’istituto secondo le norme della legge.
II – L’Istituto notifica all’assicurato, al termine dell’assistenza sanitaria se c’è stata, e comunque a conclusione dell’infortunio: i termini della temporanea ed il giudizio circa gli esiti e relativa valutazione in centesimi di capacità lavorativa ridotta. A questo momento è particolarmente indispensabile la presenza attiva dell’Assistente Sodale perchè faccia intervenire l’opera del Patronato attraverso il parere del tecnico Sanitario del Patronato e del Legale che decidano sulla obbiettività delle lesioni e sulla accettabilità o meno delle conclusioni percentuali di danno e di relativa rendita proposta dall’istituto assicuratore e faccia, se opportuno, opposizione appoggiata a certificato Sanitario del Patronato stesso. Bisogna aver chiaro nella mente che ove l’assistito accettasse senza discutere o per ignoranza o per qualunque altra ragione il disposto, conclusivo iniziale dell’istituto assicuratore atta fine della prestazione dell’assistenza sanitaria per un infortunio, tale disposto non sarebbe più modificabile per disposizione di legge. Infatti, anche se è errato, non è ammessa la Revisione per errore, anche se fosse palese, ed il disposto sarebbe solo modificabile per ragioni di obiettivo aggravamento, non sempre possibile anzi naturalmente difficile per la naturale, ovvia riduzione degli esiti, dovuta al ritorno ad integrità dei tessuti ed organi e per lo spontaneo adattamento funzionale (Esempi pratici: Amputazione malquotata e non passibile di aggravamento. Esame obbiettivo deficiente o malfatto e conclusione pratiche relative ecc.).
L’opposizione al disposto conclusivo dell’istituto assicuratore va fatta entro i termini inderogabili di giorni trenta dotta comunicazione del disposto stesso. Pertanto le Assistenti Sociali debbono tenere di ciò esatto ed intelligente conto, per il tempestivo invio ai centri Sanitari dove ogni assistito inviato al Sanitario di Patronato esige tempi di visite, ricerche e conclusioni. Tutte queste pratiche esigono giorni, mentre gli assistiti sono molti ed a tutti bisogna provvedere entro i termini di legge.
Pertanto gli assistiti debbono essere inviati al Sanitario di Patronato con assoluta sollecitudine. Ove condizioni eccezionali avessero determinato involontaria prossima od immediata scadenza dei termini, è sufficiente che l’Assistente Sociale faccia firmare all’assistito, entro il termine dei trenta giorni, lettera di opposizione alle conclusioni dell’istituto assicuratore con riserva scritta di produrre la documentazione sanitaria ed amministrativa. Anche se successivamente il Sanitario non vedesse i termini per fare opposizione, la pratica si estinguerebbe di fatto per mancanza della documentazione sanitaria, mentre diverrebbero operanti automaticamente le conclusioni dell’istituto assicuratore. Quindi nulla danneggerebbe l’assistito, mentre Sii si sarebbe comunque aperta la via a quello eventuale ed unico modo di opporsi al primo disposto conclusivo dell’istituto assicuratore che, sottoscritto in prima istanza alla fine dell’infortunio, diventa inalterabile. L’Istituto assicuratore che riceva opposizione corredata dei documenti di Patronato ha l’obbligo di rispondere entro trenta, giorni. A questa scadenza, se non avesse risposto, è nella facoltà del singolo e del Patronato di convocarlo in giudizio.
Le disposizioni sono uguali sia per gli infortuni industriali che per quelli agricoli e pertanto non se ne fa una distinta trattazione.
Di solito non interessa intraprendere subito una procedura legale, il cui diritto comunque non decade, e si attende la replica dell’istituto assicuratore che rispondendo deve accettare l’opposizione dell’organo sanitario di Patronato e disporre l’accertamento collegiale. Ove l’accertamento collegiale non fosse seguito da un giudizio concorde si passa all’arbitrato, unico itinerario da percorrere prima che il procedimento legale si dimostrasse indispensabile. In questo caso entrano in scena il legale e la magistratura ordinaria. Tribunale, Corte di Appello: sino alla Cassazione.
Ma l’azione dinanzi all’Autorità giudiziaria non può essere proposta se non dopo esaurita tutta la procedura amministrativa. Di questa fase amministrativa abbiamo voluto determinare i tempi che costituiscono le possibilità di contenzioso nel caso di un infortunio e della sua successiva pratica di svolgimento.
Vogliamo dire qualche cosa sulle denunce d’infortunio. La denuncia d’infortunio va sempre fatta a tutela di interessi che, anche al momento dell’infortunio e delle sue immediate sequenze, potrebbero non sembrare evidenti o possibili. Occorre al Patronato prima di agire avere la procura o delega del lavoratore e regolarmente compilata su modulo. La denuncia è preferibile sia fatta subito, sia per la decorrenza delle indennità che per ogni altra pratica di assistenza e prestazione
in rapporto, ma ‘può essere comunque fatta entro un anno dalla data dell’infortunio. Dopo tale data esiste la prescrizione per il conseguimento delle prestazioni (denuncia indennità – rendita etc.) stabilite per legge.
Praticamente il tempo viene, per successivi disposti comminabili di legge, ad essere allungato, ma è preferibile non riferirci a questa possibilità.
Nel caso di un infortunio mortale i termini di denuncia restano invariati e riflettono l’opera dei superstiti. Nel caso che un assistito venga a morte in conseguenza di un infortunio, e dopo la liquidazione delle indennità di rendita di inabilità temporanea e permanente, le ulteriori domande di rendita e prestazioni di legge previste per i superstiti, vanno inoltrate entro il termine di trenta giorni dalla morte.
Tutte queste scadenze debbono essere tenute presenti dalle Assistenti Sodali perchè costituiscono altrettante possibilità utili e fattive di contenzioso infortunistico.
È da ricordare che le prestazioni economiche cui possono aver diritto gli assicurati sono:
1) Indennità giornaliera per inabilità temporanea.
2) Rendita per inabilità permanente.
3) Rendita di superstiti.
4) Assegno – una tantum – in caso di morte.
Controversie
La revisione « per errore » del 1° giudizio dell’istituto assicuratore, prevista e possibile per legge fino al 1935, entro i due anni dallo stesso 1° giudizio, è venuta a mancare con la legge stessa del 1935.Pertanto è indispensabile che l’opera del Patronato intervenga nell’occasione della assegnazione e costituzione della rendita. Si è già detto questo, ma giova ripeterlo
Come fare lo abbiamo già detto. Comun vogliamo sottolineare che è il primo giudizio già un primo motivo di possibile, e dico più o meno, utile controversia fra individuo e Istituto assicuratore. E dico utile in quanto è il più momento dell’intervento consapevole di Patronato a tutela dell’assicurato anche verso l’operaio eventuale del settore Medico-Legale. Altri elementi di controversia e pertanto di interventi di Patronato sono dati dalle Revisioni e Ricorsi.
La misura della inabilità percentuale e della rendita costituite col 1° giudizio può essere riveduta annualmente a richiesta dall’Assicurato o dall’istituto assicuratore al 1° anno data dall’infortunio e non prima di sei mesi dalla costituzione della rendita. Così per 4 anni ogni anno – e dopo tale termine la prassi può ripetersi per due volte di 3 in 3 anni – e pertanto fino a 10 anni dalla data dell’infortunio avvenuto. Queste prestazioni possono essere richieste dal singolo anche se l’infortunio fosse stato chiuso senza costituzione di rendita, ma solo se fu fatta a suo tempo la denuncia. Questo sottolinea ancora l’importanza della denuncia di ogni infortunio. Se, al termine della revisione, il giudizio e-messo dall’istituto assicuratore, – anche se sia stato detto Istituto a richiedere la revisione cosi come è in suo potere, – non fosse accettato dall’assicurato, questi può inoltrare ricorso attraverso il Patronato ed ecco pertanto una nuova possibilità di contenzioso a disposizione della nostra opera di Patrocinio. Altra possibilità è quella della richiesta di revisione per aggravamento, inoltrata dal singolo a tutela dei suoi interessi, in rapporto all’infortunio subito, richiesta che va inoltrata, corredata di certificato sanitario di Patronato, entro i termini già esposti in relazione al quanto prima dell’infortunio, del successivo decennio e di altri dieci anni infine. Tale richiesta Patronale sanitaria di revisione può essere accettata o no dall’istituto, dopo suo accertamento unilaterale sulla perora dell’assistito, aprendo cosi un corso di pratiche Collegiali, od Arbitrali o addirittura offrendo l’adito alle pratiche legali che sono tutti momenti dell’azione assistibili dall’Opera di patronato.
Controversie Legali
È nel diritto del singolo appellarsi alla giustizia ordinaria del Paese perchè sia risolta, anche il tema di infortuni e sequele, controverso fra lo stesso e l’istituto assicuratore. A tal proposito è opportuno ricordare che l’istituto assicuratore rappresenta per così dire l’interesse della Collettività (che è quanto dire di noi stessi) e che pertanto la pratica legale deve esser fondata su solide basi obbiettive anatomiche, giuridiche e morali. Quindi è necessario un fondato e sereno studio e giudizio delle pratiche da parte degli organi competenti di Patronato: sanitario e legale.
Questo reclama la serie e completa complementarietà di questi due organismi, la codificazione di norme e prassi preliminari alla pratica legale e la costituzione di una responsabilità centrale di supervisione sull’operato, in questo settore, delle Sezioni Provinciali. Tutto ciò si è inteso organizzare con la creazione di una Direzione Nazionale e con la codificazione di norme utili a selezionare le pratiche degne di assistenza legale e stabilire la prassi dei singoli tempi dell’assistenza sanitaria fino al passaggio degli atti alla persona legale. Dirette ragioni della centralizzazione del servizio di supervisione responsabile sono state la delicatezza e la serietà della materia, orientata secondo i precisi indirizzi propri dell’ONARMO, e l’incidenza notevole delle spese del Servizio Medico-Legale. Si chiama all’appello anche in questo caso l’opera delle Assistenti Sociali. Si richiede Loro molta oculatezza nei rapporti con gli assistiti molta conoscenza della materia, competenza, maturità di giudizio e prudenza; meglio se vi è anche competenza amministrativa.
Alle sig. assistenti sociali
In dettaglio e senza la minima intenzione di contundere la sensibilità legittima delle nostre Assistenti Sociali, noi rivolgiamo alle stesse la preghiera di:
– Non sostituirsi al Medico ed all’Avvocato.– Non dare consigli tecnici sanitari o legali agli assistiti fuori di quelli relativi alle prestazioni di legge sulle Assicurazioni Sociali, lasciando l’intera e completa responsabilità agli organi del Patronato.– Specificare tassativamente agli Assistiti che è solo nella sede Sanitaria – Medico – Legale che potranno avere il giudizio ed il consiglio più utili oltre che la completezza dell’Assistenza.– Convincersi che nel caso dell’Assistenza Legale non vi è argomento di pietà o di comprensione umana che tenga, ma solo elementi obbiettivi medico-Legali di giudizio. Pertanto le Assistenti Sociali non riserbino astio al Sanitario ed al Legale se, contrariamente ai sensi di umana pietà e comprensione, declinassero l’incarico di inoltrare alla via giudiziaria una pratica a Loro cara.– Dedicare particolare attenzione, per eventuali procedimenti Legali, specialmente a quelle pratiche concluse, in sede di accertamento Collegiale o Arbitrale, con parere discorde in quanto portano già il germe dell’utile e possibile provedura legale.
L’apostolato del Cappellano del Lavoro e l’Assistente Sociale O.N.A.R.M.O., 11-12, 1960, pp. 22-28.
di P. Policarpo M. da Longhena o.f.m. Cappellano della Segreteria Generale ONARMO
L’ONARMO (opera Nazionale Religiosa Morale Operai) fin dalle sue origini si è presentata con un programma ben definito: « rendere più cristiane le masse operaie, operando nell’ambito del loro ambiente», finalizzando fin dal primo giorno della sua esistenza la propria attività tra i lavoratori in un’azione di avvicinamento a Dio, attraverso sopratutto il Ministero del Sacerdote, Cappellano del Lavoro, che entra negli ambienti lavorativi unicamente in veste di Sacerdote per svolgere solo missione sacerdotale.
1 – Caratteristica dell’Apostolato del Cappellano del Lavoro
Il Cappellano del lavoro ha partecipato alla vita dell’Onarmo fin dai suoi albori come elemento essenziale e insieme come figura tipica con una sua fisionomia inconfondibile.
Il Cappellano del lavoro è il pioniere di un moderno apostolato, che si svolge nelle fabbriche, nelle miniere, in qualunque luogo dove l’uomo lavoro, lotta, soffre, per guadagnarsi il pane quotidiano.
In questi ambienti il Cappellano del lavoro entra esclusivamente nella sua veste di sacerdote e soltanto di sacerdote per dare ai lavoratori ciò che può dare cioè la verità e la Grazia.
Tale infatti è la missione che Cristo ha affidato al sacerdote: «andate dunque ammaestrate tutte le genti… insegnando loro ad osservare tutto ciò, che io vi ho comandato » (Mt 28,19) e « andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15).
Il primo compito del Cappellano del Lavoro è quello di portare il messaggio evangelico nel mondo del lavoro, d’invadere quindi di luce gli ambienti lavorativi, dove purtroppo, serpeggiano i più grossolani errori contro il dogma e la morale.
Insieme col mandato di predicare il Vangelo, Gesù ha dato al sacerdote il potere di distribuire la grazia. «così; ognuno ci riguardi come Ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio » (1 Cor 4,1). Il Mistero per eccellenza nascosto ai secoli ed alle generazioni passate, ma ora svelato ai suoi santi, (Col 1,24) è il Cristo mistico. E ai Sacerdoti è affidato il compito di edificare e perfezionare attraverso i secoli il Cristo mistico, aggiungendo al medesimo sempre nuove membra. Ed è la Grazia, la Grazia di cui il Sacerdote è il distributore per eccellenza, che incorpora in Cristo. Il Cappellano del Lavoro, entrando nelle fabbriche scendendo nelle miniere solo in veste di sacerdote non solo deve essere dispensatore di luce, ma deve anche donare Grazia.
Nel grande, meraviglioso sorprendente mondo del lavoro, dove pulsa la vita economica e materiale, ma insieme sovente domina la morte sovrannaturale, il Cappellano del Lavoro deve portare la vita, la vera vita, quella vita divina che inserita nella vita sociale diventa un coefficiente efficace per risolvere quella questione che tanto tormenta la nostra generazione. Anche nelle fabbriche, anche nelle officine, anche negli ambienti di lavoro deve essere costruita la comunità cristiana invisibile, deve essere costruito come dice San Paolo, il Corpo mistico di Cristo: a questo scopo, soltanto per questo scopo vi entra il Cappellano del Lavoro.
Apportando la Grazia il Cappellano del Lavoro diventa anche messaggero di amore in quel mondo, qualche volta arroventato dalla discordia e dall’odio, qual è appunto il mondo del lavoro, perchè l’ONARMO, soprattutto con l’apostolato del Cappellano del Lavoro, vuole l’attuazione del precetto della carità in quel mondo, e fondamento di ogni rapporto sociale, Come forza che muove e informa ogni atto umano nei confronti di Dio e del prossimo, come elemento vivificante della giustizia e delle aride leggi economiche e come principio dei nuovi rapporti sovrannaturali tra datori di lavoro e lavoratori.
per raggiungere più facilmente tali finalità l’ONARMO vieta al Cappellano del Lavoro ogni partecipazione a lotte sindacali e politiche e ogni inframmettenza nelle controversie salariali tra dirigenti e maestranze, perchè solo mantenendosi al di fuori e al di sopra dei partiti e della lotta di classe egli può dire a tutti, padroni e operai, senza reticenze e senza timori, quali sono1 doveri specifici di ciascuno.
2 – Urgenza dell’Apostolato del Cappellano del Lavoro
A questo punto si potrebbe obiettare se è proprio necessario andare in fabbrica, entrare negli ambienti di lavoro per dispensare la verità e la Grazia? Per questo non si sono costruite le Chiese, erette le Parrocchie? Nelle Chiese dunque e nell’ambito della Parrocchia il Sacerdote eserciti il ministero della Parola e della Grazia. D’altra parte non è forse stata affidata alla Parrocchia la missione della salvezza delle anime? Nella presente economia Cristo ha voluto che la salvezza si effettuasse nell’incorporazione a Lui, ma ha voluto anche che l’unione invisibile con Lui si traducesse nell’unione di tutti i battezzati raccolti in comunità visibile intorno all’unico capo da Lui preposto: « chi ascolta voi, scolta me, chi disprezza voi, disprezza me » (Lc 10,16). E questo capo visibile è il Vescovo, che perciò rappresenta in mezzo a noi Cristo, e di Cristo ne continua la missione, facendosi in ciò aiutare da uomini, ai quali trasmette parte dei suoi poteri, perchè li esercitino sopra una determinata porzione del gregge, denominata appunto Parrocchia.
La Parrocchia pertanto non è che una piccola comunità di cristiani, inquadrata in un’altra comunità più vasta, che si chiama Diocesi e questa a sua volta inquadrata in un’altra comunità ancora più vasta: la Chiesa Cattolica. Come la Chiesa anche la Parrocchia è il Cristo che rivive non solo nei Pastori, ma anche in tutti i battezzati viventi nella fede e nella grazia, e rivive per continuare la sua missione di salvezza.
Anche la Parrocchia perciò continua la missione salvifica di Cristo. E la Parrocchia anche nel Secolo XX ha ancora la capacità di assolvere questa sua missione.
Ma allora perchè mandare Sacerdoti nelle fabbriche, nelle officine, negli ambienti di lavoro, per esercitare il ministero della salvezza delle anime?
In questo modo essi non compiono opera di disgregazione della comunità parrocchiale?
Tutt’altro, affermiamo noi. Il Cappellano del Lavoro col suo apostolato negli ambienti lavorativi coopera, deve cooperare alla ricostruzione e al perfezionamento della comunità parrocchiale.
Poichè l’ONARMO fin dai primi anni della sua esistenza ha voluto e vuole ancora che il Cappellano del Lavoro sviluppi il suo apostolato secondo una forma triangolare: ambiente di lavoro, famiglia e parrocchia. L’urgenza di tale apostolato si rende manifesta se noi ci soffermiamo anche solo brevemente a considerare la situazione religiosa delle masse lavoratrici e i loro rapporti con la comunità parrocchiale, di cui dovrebbero far parte!L’allontanamento della classe operaia dalla Chiesa è stato definito lo scandalo del nostro secolo. Infatti la rapida industrializzazione, il laicismo imperante, la propaganda marxista, le ingiustizie sociali, congiunti con altri fattori, fino dalla fine del secolo scorso hanno prodotto una frattura tra il mondo del lavoro, e la Chiesa, frattura che si è maggiormente accentuata nei primi decenni del nostro secolo, sottraendo masse di lavoratori, soprattutto dell’industria, all influenza benefica della Chiesa. Le conseguenze di tale allontanamento della classe operaia dalla Chiesa furono quanto mai funeste dal punto di vista religioso e morale del lavoratore.
Il lavoratore non solo ha abbandonato la religione, ma ha iniziato a combatterla come un ostacolo alle sue giuste rivendicazioni sociali.
Bandita la religione dal mondo del lavoro, anche la morale non ha potuto sostenersi, e gli ambienti lavorativi che cosa sono diventati? Nei medesimi si è creata un’atmosfera di odio e di rancore e il mondo del lavoro è stato talvolta travolto da una ondata di immoralità. E anche oggi la situazione religiosa e morale di certi ambienti non ostante la presenza in esso di associazioni e organismi cattolici, non è certamente rosea.
Alcune strutture politiche e sindacali continuano ad esercitare la loro nefasta e deleteria azione sulla massa operaia.
Il contatto continuo con le macchine, senza un efficace richiamo alla vita spirituale, materia-lizza l’uomo, annullando quasi in lui la vita dell’anima. La promiscuità influisce spesso sulla decadenza morale delle classi lavoratrici.
A tutto ciò si aggiungano le condizioni di particolare disagio createsi all’esterno dell’azienda e che rendono difficile il regolare compimento del dovere religioso ai lavoratori; la distanza tra casa e Chiesa e l’ambiente di lavoro, l’incalzare dei turni di lavoro diurni, notturni ed anche festivi, la necessità di maggior riposo e di evasione specialmente dalla città appena si può godere di una giornata libera. Tutto questo coopera a tenere lontano dalla vita della comunità cristiana le masse lavoratrici.
E il Ministero pastorale tradizionale, cioè parrocchiale, nelle sue statistiche, registra cifre di assenze sconfortanti, mentre si constata tristemente che la Messa festiva, la Comunione pasquale da parte di molti lavoratori rappresenta solo un episodio della settimana o dell’anno; essi non hanno nessun contatto vitale con la parrocchia. Non è possibile ignorare tale situazione senza che il bene delle anime e della Chiesa stessa ne scapiti.
Urge quindi impostare nell’intimo dell’Azienda una sollecita ed efficace azione pastorale perchè quella parrocchiale non arriva più in modo efficace alla intelligenza e alla volontà di molti lavoratori. È necessario pertanto che il prete entri nella fabbrica, nelle aziende, negli ambienti di lavoro perchè solo con questa sua presenza sacerdotale nei medesimi potrà riunire nuovamente in una mirabile sintesi lavoro e religione e gettare un ponte reale tra l’altare e l’officina. Se il Sacerdote vuole ancora incontrarsi con non pochi lavoratori è necessario che egli esca di Chiesa, entri in quel mondo che esercita sopra di essi, della loro vita familiare e sociale la sua influenza.
3 – Tecnica dell’Apostolato del Cappellano del Lavoro
L’ONARMO come ha dato al Cappellano del Lavoro una fisionomia tutta sua propria, così al medesimo ha insegnato una tecnica di apostolato che in quarantanni circa di esperienza ha rilevato una particolare efficacia per riconquistare a Cristo le classi lavoratrici. L’ONARMO vuole che il Cappellano del Lavoro si inserisca nella vita delle fabbriche in veste di Sacerdote, in maniera tale da diventare come un membro della grande famiglia dei lavoratori, per svolgere apostolato che deve svilupparsi secondo una triplice direttiva.
a) Apostolato di accostamento individuale al lavoratore.
Poichè l’apostolato del Cappellano del Lavoro deve essere apostolato di ambiente, egli perciò deve avvicinare il lavoratore nel luogo delle sue quotidiane fatiche, iniziando con lui un dialogo tutto permeato di amore evangelico, e locarsi la simpatia, la fiducia di lui e di suo fratello, l’amico e così conoscerne le aspirazioni, le esigenze spirituali, le deficienze, i drammi che esistono sovente nell’animo del lavoratore per diventarne poi la guida spirituale.
b) Apostolato di gruppo
Il Cappellano del Lavoro, creatasi attorno una corrente di calore, deve preoccuparsi di riunire i migliori operai delle singole fabbriche, costituendo gruppi scelti di lavoratori che ben preparati e indirizzati, devono diventare la forza prima e fondamentale dell’organizzazione onarmistica degli ambienti di lavoro. Tra questi gruppi ricordo soprattutto l’Apostolato della Preghiera e le Conferenze Aziendali di S. Vincenzo.
1) Apostolato della Preghiera
L’Apostolato della Preghiera nel suo impegno quotidiano molto facile ed apparentemente semplice, ma di valore incalcolabile per il bene delle anime, fu accolto con fervore dai lavoratori, anche perchè non vi trovarono nessun appiglio politico. Il rapido sviluppo conseguito in pochi anni ne è dimostrazione luminosa.
L’ONARMO fin dall’inizio della sua esistenza, come mezzo efficacissimo per riaccendere nel cuore dei lavoratori la fiamma dell’amore a Dio si è servito dell’Apostolato della Preghiera; ma solo nel dicembre 1956 ottenne dalla Direzione Generale dell’A.d.P., affidato ai Padri Gesuiti, uno speciale statuto per i Centri Aziendali ONARMO, e da allora si cominciò ad istituire canonicamente « Centri Aziendali ONARMO », sia pure considerati come una « Sezione Particolare dell’A.d.P. ».Alla Segreteria Nazionale per i Centri Aziendali ONARMO dell’A.d.P. alla fine di giugno 1956 sono giunte notizie di n. 1.894 « Centri Aziendali ONARMO » canonicamente eretti con n> 178.793 di iscritti: uomini n. 120.002, donne n. 58.791 e nei quali operano con fervore, meritevoli di ogni encomio, n. 3.282 zelatori e n. 1.751 zelatrici.
Nel febbraio 1957 si ottenne dalla Direzione Nazionale dell’A.d.P. autorizzazione a stampare un foglietto commento della intenzione mensile esclusivamente per i lavoratori, e da una tiratura di 29.000 nel febbraio 1957 si è giunti nel bimestre settembre-ottobre 1960 ad una tiratura di 208.000 copie. Così l’A.d.P. riunendo gli operai in una associazione, nella quale la preghiera stessa come apostolato viene organizzata in modo da costituire in ogni fabbrica un « piccolo esercito di coloro che pregano », è nelle mani del Cappellano del Lavoro « l’aiuto il più possente nel suo sforzo di cristianizzare il mondo del lavoro, talvolta lontano dagli ideali del Vangelo ».
2) Le Conferenze Aziendali di S. Vincenzo
Nel mondo del lavoro, dove sovente il vento delle discordie e delle lotte sociali divide i figli di uno stesso Padre, l’ONARMO con le conferenze aziendali di S. Vincenzo, attuate dai suoi Cappellani, ha reso operante tra i lavoratori l’amore a Dio nella pratica dell’amore del prossimo, amore che si estrinseca nella visita all’ammalato, nell’assistenza, in una parola a tutti coloro che soffrono nel corpo e nell’anima. Per mezzo delle conferenze aziendali di San Vincenzo il Cappellano dell’ONARMO porta nelle aziende il lievito della divina carità e coopera al miglioramento di molti lavoratori, mediante la loro volontaria partecipazione al dolore e alla necessità dei propri simili, amati con quell’amore, che Gesù ha lasciato come distintivo dei suoi seguaci: « In questo si riconoscerà che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri » (Gv 13,35).
3) Ritiri agli operai
Con l’apostolato della Preghiera e con l’apostolato della carità l’ONARMO indica ai suoi Cappellani come mezzo sempre valido per compiere opera di riconquista a Cristo dei lavoratori i ritiri per gli operai.
Non mi dilungo ad illustrarvi la particolare efficacia dei ritiri per ricondurre i nostri lavoratori ad una vita integralmente cristiana.
Il ritiro nella preghiera e nella meditazione in tutti i tempi ha creato i Santi; e sarà sempre il ritiro che formerà l’operaio tipo dal punto di vista religioso e sociale.
c) – Apostolato di massa
Come già ho precedentemente affermato l’apostolato del Cappellano ONARMO è apostolato di ambiente. Tra i mezzi atti a compiere tale apostolato vi sono certe manifestazioni religiose, tenute negli stessi ambienti di lavoro, come celebrazione del Precetto Pasquale, commemorazione dei lavoratori defunti, preparazione del Santo Natale, Festa della Famiglia, ecc.
Tali manifestazioni nelle officine, dove risuona lo stridore delle macchine, rappresentano una sosta benefica, un richiamo ai valori dello spirito, un mezzo quanto mai efficace ad elevare la mente degli operai a Dio.
4) Il Cappellano del Lavoro e l’Assistente Sociale
Il Sindacato cattolico contribuisce all’opera salvatrice della Chiesa sotto la guida della Gerarchia. Incorporati in Cristo per mezzo del Battesi mo, aggregati all’esercito del Re dei secoli per mezzo della Cresima, tutti i Cattolici hanno l’obbligo di cooperare per la dilatazione del Regno di Cristo. È fuori dubbio quindi che anche l’Assistente Sociale debba fare dell’apostolato. Ma qui sorge il problema: una Assistente Sociale può fare apostolato in quanto Assistente Sociale? Il Servizio Sociale corrisponde ad una necessità della nostra epoca, nella quale l’estensione dell’assistenza previdenziale, assicurativa e sanitaria a tutte le categorie di cittadini, trova molti particolarmente tra le classi lavoratrici, impreparati a rivendicare i propri diritti presso i numerosi Istituti. Ma il Servizio Sociale non è qualche cosa di astratto; bensì una attività che si finalizza, secondo i diversi Enti, presso i quali si attua.
L’ONARMO, nata con una propria finalità: « rendere più cristiane le masse operaie, operando nell’ambiente di lavoro », affiancando l’opera del Cappellano col servizio sociale, e questo ha impresso ad esso il carattere di collaborazione col Cappellano per il raggiungimento delle sue finalità. Così l’ONARMO, come il fondatore, ha sempre visto e voluto l’Assistente Sociale fin dagli anni lontani della sua prima esperienza, quando chiamava le prime Assistenti Sociali a svolgere la loro attività tra i lavoratori: non semplicemente impiegata e funzionarla; ma soprattutto missionaria, e perciò essa stessa apportatrice di luce agli operai, di conforto ai loro cuori, di forza spirituale alle loro volontà. L’Assistente Sociale ONARMO nella molteplicità dei servizi che svolge sul piano della consulenza amministrativa, previdenziale, assicurativa e sul piano assistenziale propriamente detto, come nelle varie iniziative alle quali dà corso sul piano culturale, ricreativo, ecc… deve sempre mirare alle finalità dell’ONARMO: «rendere più cristiane le masse operaie ».E allora diventa bella la missione dell’Assistente Sociale ONARMO! Missionaria del Lavoro, protesa, mediante l’esercizio della sua ‘Cessione, verso la salute delle anime, proprio laddaove tanti allontanati sono dalla Chiesa. Combattente coraggiosa e audace per difendere il Regno di Cristo, là dove oggi sono presenti talvolta coloro che lavorano per distruggere il Regno di Cristo.
Eppure è la Missione dell’Assistente Sociale per una maggiore elevazione della personalità del lavoratore nella difesa della sua dignità, nella salvaguardia della sua fede e nell’aiuto che l’Assistente Sociale può offrire al lavoratore, perchè egli possa ascendere nella giustizia e nella pace ad una concezione più cristiana della vita e del lavoro. Un Eminentissimo Presule scriveva recentemente alla Gioventù Femminile di A.C. della sua Diocesi: « Penso che se la nostra Diocesi avesse cinquemila giovani votate all’affermazione della fede e del costume cristiano, tutta la popolazione ne sarebbe scossa e tante belle iniziative si potrebbero avviare » (Messaggio della Salvezza in una lettera del Card. Montini all’Italia 14 agosto 1960). Ed io dico che se l’ONARMO avesse 5.000 Assistenti Sociali che sentono tutta la grandezza della loro missione e che con l’entusiasmo e con la generosità delle anime pure e innamorate di Dio si consacrano all’adempimento di tale missione, noi saremmo sicuri di poter presto salutare con gioia il giorno della rinascita cristiana del mondo del lavoro italiano. È bella la missione dell’ONARMO, ma è anche impegnativa! Perchè l’Assistente Sociale possa assolvere fruttuosamente la sua nobile missione, deve ricevere una formazione tecnica professionale, una educazione cristiana e ascetica tutta particolare. Già Pio XII parlando degli assistenti sociali, diceva: « l’Assistente Sociale ha bisogno di soda spiritualità, di alcune qualità fondamentali, le quali una buona intelligenza, doti di simpatia, spirito di iniziativa e di collaborazione,competenza personale e fedeltà alla Chiesa: c’è bisogno di queste doti: come c’è bisogno di spirito di servizio, di una carità illuminata dalla fede e animata dalla speranza à».Per portare nel mondo del lavoro la luce della verità e la fiaccola della carità è necessario possedere la verità e la carità.
Un’Assistente Sociale dell’ONARMO che non possiede una cognizione delle verità del Cristianesimo e che non vive la vita cristiana non può assolvere la sua missione. Missionaria del lavoro, l’A.S., come già ho accennato, deve essere quindi la principale collaboratrice del Cappellano nel suo apostolato di recupero alla vita Sacramentale e perciò alla vita della Grazia e della comunità parrocchiale dei fratelli lavoratori. Sottolineo la parola: collaboratrice. L’A. S. non sostituisce il Cappellano del Lavoro, e tanto meno deve sovrapporsi al medesimo, o agire in contrasto con Lui. Secondo l’intenzione del Fondatore dell’ONARMO il Cappellano del Lavoro è il primo responsabile delle attività che l’ONARMO svolge negli ambienti di lavoro. Egli rappresenta la Chiesa e pertanto deve guidare anche l’attività di quegli organismi ausiliari che affiancano il suo apostolato, tra i quali le Assistenti Sociali. Con questo non intendo affermare una assoluta dipendenza dell’A.S. dal Cappellano nello svolgimento della sua attività professionale. In questo settore l’Assistente Sociale ONARMO ha piena e diretta responsabilità, secondo le direttive della Sede Centrale, mentre il Cappellano del Lavoro deve rispettare tale autonomia, anzi deve valorizzarla al massimo, orientando verso l’A.S. i lavoratori per tutto ciò che sono di sua competenza, senza avere la pretesa di dare direttive sul suo metodo, e soprattutto senza senza esigere che l’Assistente Sociale diventi una sua Segretaria e tanto meno una sua dattilografa. E l’A. S. collaborerà efficacemente all’apostolato del Cappellano del Lavoro, prestando la sua opera preziosa e squisitamente femminile nel potenziamento delle attività onarmistiche, promosse dal Cappellano del Lavoro, quali: l’Apostolato della Preghiera, le Conferenze Aziendali della S. Vincenzo e l’Opera dei Ritiri agli Operai, e al Cappellano del Lavoro indirizzando i lavoratori per le loro necessità spirituali. In tale modo il Cappellano del Lavoro e l’Assistente Sociale, ciascuno nell’ambito della propria Missione, in una prudente e perfetta armonizzazione di attività, contribuiranno efficacemente al raggiungimento delle finalità dell’ONARMO: « rendere più cristiane le masse operaie ».
Esperienze della più giovane assistente sociale di fabbrica, 11-12, 1960, pp. 28-33.
di Maria Ciolli
Come ognuno ha potuto leggere sul programma distribuitoci, l’argomento che mi è stato assegnato di trattare, non è di carattere specifico, ma tale da spingermi a dover parlare in tono autobiografico; chiedo scusa quindi se qualche volta mi sfuggirà di usare la prima persona, e se non potrò essere sempre troppo chiara: poichè l’argomento stesso non mi aiuta ad essere organica né sistematica. Tutti voi prima di me vi sarete resi conto come il nostro lavoro sia a carattere marginale: ed è questa, credo, la cosa più importante che ho imparato attraverso i miei primi sei mesi di esperienze nel servizio sociale di fabbrica. È un lavoro marginale nel senso più immediato della parola:
si svolge in ore che devono essere trovate ai margini dell’orario di lavoro;
in locali quasi sempre adibiti ad altri scopi;
si deve connettere con la vita delle varie aziende mantenendosi in condizioni qualche volta di struttura tollerata, anche se in un’azienda si riesce ad ottenere un ufficio propri e il tempo necessario per poter svolgere cori tranquillità il servizio.
Il nostro lavoro per la sua propria essenza ha bisogno di rimanere sostanzialmente marginale rispetto all’attività dell’azienda, che non è assistenziale, ma produttiva. È vero che secondo alcuni il servizio sociale è utile alla produzione, ma tale sua utilità è accidentale, è una conseguenza di quel che fa, non è il suo fine specifico, come avrò occasione di spiegare anche in appresso. Il suo fine specifico obbliga l’assistente sociale a rimanere in condizioni di indipendenza morale e sociale rispetto al datore di lavoro e alle organizzazioni di lavoratori, e questa condizione mi pare debba chiamarsi marginale, perchè il termine « indipendente » implicherebbe un significato inesatto di separazione completa. A queste considerazioni sono stata indotta dalle mie prime esperienze e soprattutto dalle umiliazioni subite nei primi contatti con i lavoratori e con i dirigenti. E ho dovuto concludere che è sgradevole non avere «un sasso su cui poggiare il capo »; è sgradevole ma non è inutile, e forse è necessario affinchè sia realmente libero il nostro lavoro e realmente assicurata la nostra moralità professionale. Questa infatti potrebbe facilmente essere posta in tentazione quando, e per la sede e per lo stipendio e per la carriera e per i rapporti professionali noi ci troviamo alle dipendenze di chi, come il datore di lavoro, non può non subordinare ogni altra attività alle esigenze e agli interessi della produzione.
Ciò posto accenno alle difficoltà soggettive, personali, che si accompagnano più o meno con l’entusiasmo giovanile e la giovanile inesperienza, ci sono le difficoltà oggettive:
1) dirigenti e maestranze per i quali il servizio sociale è una ignorata novità di cui diffidano in modo diffuso e generico;
2) ostilità preconcetta della massa operaia a volte chiusa alle innovazioni e a volte influenzata dalla propaganda classista;
3) tempo disponibile molto limitato, sia per l’eccessiva quantità di lavoro da svolgere, e sia la fretta che ha l’operaio di andarsene via appena lascia il lavoro;riserbo naturale dell’operaio nel proporre i suoi bisogni e i suoi problemi alla presenza dei compagni di lavoro, per mancanza di un locale dove possa essere ricevuto;
5) numero relativamente elevato delle fabbriche affidatemi, congiunto con la lontananza dal centro;
6) mancanza del Cappellano del Lavoro, mancanza quindi di quell’aiuto spirituale, estremamente necessario, come appunto ha sottolineato Sua Eccellenza Mons. Baldelli nel discorso inaugurale di questo seminario, perchè il servizio sia efficiente e possa raggiungere i suoi scopi che sono di carattere non solo umano ma anche soprannaturale. E devo infine anche dire che non ho trovato soltanto difficoltà, ma anche consolanti testimonianze di generosa bontà presso gli operai e le operaie, che, nonostante le difficoltà della vita, conservano un desiderio di bene e una fede religiosa anche se teoricamente poco definita.
Parlerò adesso delle varie fabbriche in particolare, cercando di indicare i loro vari aspetti:
1. – Molino e Pastificio…: fabbrica che assorbe 70 operai, di cui 50 uomini e 20 donne.
L’azienda garantisce una certa sicurezza economica, le maestranze ricevono una buona paga (ciò che nelle altre fabbriche non avviene) e hanno le ferie annue di almeno 15 giorni. Il problema che vi ho dovuto subito rilevare, riguardava discordie e rancori prodottisi tra gli operai stessi. Occorreva un’opera di chiarificazione (possibile attraverso i colloqui individuali e discussioni collettive) perchè ciascuno conoscesse l’importanza che ha il lavoro particolare di ciascuno altro nell’ordine della produzione. A calmare le discordie è stato utile anche1 intervento del direttore della fabbrica, il quale ha cercato di ascoltare i desideri degli operai e a voluto conoscere i motivi dei dissidi; e così si è potuta chiarire la situazione.
Si sono presentati casi individuali abbastanza difficili e delicati, per la soluzione dei quali sarebbe stata necessaria la presenza del Cappellano di fabbrica. Mi sono servita allora della collaborazione del Delegato Diocesano e qualche volta del Parroco del luogo, per risolvere i casi più urgenti.
In questa fabbrica l’inserimento del servizio sociale è stato meno difficile, perchè il direttore si è mostrato aperto e favorevole, allo scopo di avere una collaborazione al miglioramento dell’ambiente di lavoro e di conseguenza anche della produttività. Questo non è propriamente il fine del servizio sociale, tuttavia essendo una reale conseguenza di esso, la si può far valere perchè si aprano le porte delle direzioni aziendali.
Con la collaborazione del Parroco del luogo si è organizzato il precetto pasquale, celebrato verso la fine di aprile. La solennità è servita, oltre che all’adempimento di un dovere religioso, anche a rendere più armoniosi i rapporti degli operai fra di loro e con i dirigenti. È molto sentita l’attività della Commissione Interna la quale si occupa di difendere i diritti degli operai. Il presidente di essa mi parla spesso dei problemi degli operai e delle loro iniziative collettive; e mi segnala i casi che possono essere oggetto del mio lavoro tutte le volte che ne viene a conoscenza.
Molta solidarietà ci è stata per il caso di infortunio di una operaia: quasi tutti gli operai sono andati a visitare la degente in ospedale, ed è stata fatta altresì una colletta a suo beneficio.
Si ha in programma di attuare un vasto piano di lavoro, e in primo luogo di istituire una mensa aziendale. La difficoltà più grande è data dal fatto che in questa fabbrica, come pure nelle altre, non esiste un locale per parlare con gli operai, ma bisogna incontrarli in portineria, subito prima e subito dopo il cambio del turno di lavoro. Non si possono fare quindi dei veri colloqui, spesso ho superato questa difficoltà invitando l’operaio al Centro Sociale in un’ora fuori dell’orario di lavoro. Ma è sempre una cosa scomoda, sia per la lontananza e sia per il poco tempo libero che gli operai hanno a disposizione.
I rapporti con il direttore sono buoni e fondati sulla collaborazione; egli mi ha perfino promesso che mi concederà una piccola stanza ove poter ricevere gli operai quando mi reco in fabbrica.
2. – Fonderie e Smalterie … : fabbrica di circa 170 operai, tipo di industria pesante (per la fabbricazione delle vasche da bagno).
È costituita da due reparti:
a) reparto fonderie, dove viene fusa la ghisa, con operai non specializzati, ma solo di fatica;
b) reparto smalterie, dove avviene la smaltatura delle vasche, vi lavorano operai qualificati, per la maggior parte di giovane età.
Occorre premettere che in questa azienda esistono molti attivisti della C.G.I.L. e la Commissione Interna è costituita da membri di tale sindacato. Nell’ambiente di lavoro, soprattutto nelle fonderie esiste un continuo malcontento tra gli operai nei confronti dei dirigenti e dei capireparto, per la mancanza di attrezzatura antinfortunistica, per il trattamento economico e per le maniere del capo reparto sul posto di lavoro. Gli operai si lamentano delle parole, perchè non si sentono trattati da uomini liberi.
Il lavoro delle fonderie è faticoso e pericoloso, e rende gli operai facilmente eccitabili; la paga giornaliera è bassa perchè la direzione amministrativa si attiene a pagare le maestranze, secondo la tariffa stabilita per la provincia che fa parte dalla 14ª categoria nella classifica nazionale. Per tutto ciò gli operai lavorano malvolentieri e lasciano frequentemente il lavoro accusandosi malati. I capi reparto si lamentano di questo atteggiamento e trattano male gli operai e a volte il giusto ci rimette per il peccatore. Sotto questa continua tensione si svolge il lavoro giornaliero, con continui licenziamenti e quindi nuove assunzioni.
Si può immaginare la utilità del servizio sociale, ma anche la pena e la fatica in questo ambiente, pieno di problemi individuali e collettivi.
È stata questa la fabbrica ove il servizio sociale ha incontrato maggiori difficoltà da parte dei dirigenti e ancora di più da parte degli operai. Il direttore ha accettato la presenza dell’assistente sociale un’ora alla settimana, tanto per non dire totalmente di no, e gli altri dirigenti se ne sono completamente disinteressati. Gli operai hanno reagito con la indifferenza e con la diffidenza.
Il primo caso capitato è stato quello del portiere dello stabilimento, la persona che conosce per primo e più da vicino l’assistente sociale. Si trattava di una pratica di pensione della madre abbastanza complessa, che egli aveva molte volte tentato di risolvere da solo, ma non ci era mai riuscito.
Ha chiesto la mia collaborazione, così che con vari interventi, dopo circa tre mesi, si è riusciti ad ottenere la pensione con tutti gli arretrati.
Contemporaneamente alla composizione di questo caso, altri operai hanno presentato altre loro difficoltà, che per fortuna sono sempre riuscita a risolvere. Mi sono sempre interessata degli operai infortunati o malati, facendo visite domiciliari e ospedaliere, ed ho ascoltato le loro preoccupazioni collaborando con loro per risolverle. Con il trascorrere del tempo hanno cambiato atteggiamento, ma qualcuno si tiene ancora lontano. Quando escono dal lavoro sono tutti anneriti per le polveri che raccolgono nelle fonderie e si vergognano di farsi vedere in quelle condizioni, perchè temono di essere disprezzati. Sono io allora che vado incontro a loro, faccio dei colloqui, porto loro le risposte alle richieste della settimana precedente, e con questo sistema si sentono meno a disagio.
Ho chiesto di parlare con il presidente della Commissione Interna, per conoscere più da vicino i desideri degli operai, ma egli accusando svariati ed anche plausibili motivi, non si è mai reso abbordabile.
Tuttavia proprio in questa fabbrica ho potuto constatare che ove si trova più freddezza, se si ha pazienza e costanza, si ottengono i migliori risultati. Mi si è dato infatti il caso di un operaio il quale, quando gli capitava, mostrava disprezzo per il servizio Onarmo. Un giorno ha chiesto il disbrigo di ima pratica di indennità malattia INAM; dopo qualche giorno è venuto adirato in ufficio perchè all’istituto INAM non si trovava il documento. L’abbiamo assicurato di averlo presentato, mostrandogli le nostre registrazioni; egli se ne è andato non convinto. Dopo essermi accertata che la pratica era in ordine, sono tornata in fabbrica, e gli ho chiesto se era riuscito a sapere qualcosa.
Ha dovuto rispondermi che la pratica era a posto e poi ha soggiunto che aveva bisogno di soldi, che era stato malato e che aveva bisogno altresì di nutrire i suoi bambini. Mi sono interessata della famiglia e della sua malattia. Effettivamente non erano lamenti eccessivi, poichè ricoverato in ospedale per una seconda operazione: ulcera gastrica, aveva poi ripreso il lavoro troppo sollecitamente, e si sentiva di nuovo male.
Infatti due settimane dopo è stato ricoverato in ospedale per una terza operazione: il giorno prima di entrare è venuto in ufficio per mettermene al corrente, pregandomi di tenere tranquilla la moglie. Due giorni dopo l’intervento chirurgico si trovava in uno stato pietoso: gli avevano quasi asportato lo stomaco e gemeva con affanno. La moglie piangeva disperata e la madre di lei le faceva compagnia nel piangere. Ho cercato di sostenere la donna, dicendole che dopo qualche giorno le condizioni sarebbero cambiate. Così è stato, infatti l’operaio si è rimesso pur restando un po’ debole. Nel frattempo sono intervenuta presso il direttore, mettendolo al corrente delle condizioni dell’operaio, verso il quale aveva una certa predilezione per la fedeltà al lavoro che egli aveva sino allora dimostrata. Ho fatto rilevare al direttore l’opportunità di cambiare tipo di lavoro all’operaio, sottolineando le condizioni di esso. Fortunatamente il Direttore mi ha dato ascolto, sicchè questo operaio, tornato al lavoro non sta più in fonderia, ma è diventato una specie di capo-reparto in una delle fasi di produzione meno faticose e meno impegnative. Ora l’operaio è molto cambiato, ha fiducia nel Servizio Sociale, non solo indirizza ad esso i suoi compagni di lavoro, ma collabora con esso in tutti I modi e appoggia tutte le iniziative che prendiamo a favore di quelle maestranze.
Oltre che seguire i casi individuali dei singoli operai, ho rapporti con le famiglie per mozzo di visite domiciliari, specialmente quando il caso implica i membri della famiglia.
Sono riuscita ad entrare in buoni rapporti con due membri della Commissione interna, i quali mi informano delle loro intenzioni e delle iniziative che prendono.
Da un mese a questa parte è stata cambiata la gestione della Fabbrica: prima era genovese, ora è milanese; ed ho il vantaggio che questi nuovi dirigenti conoscono da anni il Servizio Sociale ONARMO e di conseguenza posso agire con più facilità e ottengo la loro collaborazione. Ma all’inizio ho dovuto svolgere una lunga opera di chiarificazione con colloqui individuali e anche con manifesti ove era bene spiegato il nostro servizio.
3 – TABACCHIFICIO di…..: è una fabbrica di tipo stagionale per la lavorazione del Tabacco (cernita e imbottamento) che lavora da ottobre a maggio con un numero di 140 operaie e 10 operai.
Ho trovato facile accesso da parte della Direttrice e della ragioniera le quali hanno collaborato con me perchè tutte le ragazze e le donne sapessero del Servizio Sociale. Ho invece trovato molta indifferenza all’inizio da parte delle ragazze, specialmente delle più giovani che vedevano forse in me una come loro. Dopo un mese circa perciò attraverso discussioni in gruppo e attraverso la buona soluzione di pratiche previdenziali, il clima è diventato più favorevole e più familiare. Quasi tutte sono venute, ora per un motivo ora per un altro, tutte hanno avuto qualcosa da chiedere o per sè o per i familiari. Difficoltà è stata costituita anche in questa fabbrica dal tempo troppo limitato e dalla mancanza di un ufficio.
Tra le operaie dal reparto cernita e quelle del reparto inbottamento si è determinata una separazione dovuta alle necessità tecniche della lavorazione. Per realizzare una maggiore concordia e coesione di intenti si è disposto in modo tale che nella mensa, durante il pranzo, le operaie prendessero posto alternandosi le une con le altre. Inoltre in occasione della Pasqua, con il Parroco della zona si è fatto un corso di conferenze, e il quarto giorno è stata celebrata la S. Messa.
Anche questo è servito molto ad armonizzare i rapporti delle operaie tra di loro.
4) CALZIFICIO: Azienda di 300 operai di cui 250 ragazze e 50 uomini. L’Azienda è addetta alla fabbricazione delle calze; è una società per azioni composta da 4 soci, di cui uno di essi è di religione ebrea. Il Direttore ha appena tollerato inizialmente l’A.S., per non essere male giudicato dalle operaie. Da questa situazione non restava che sensibilizzare da una parte i dirigenti e le capo-reparto circa i problemi e le difficoltà delle operaie, e dall’altra svolgere una costante opera di chiarificazione circa il S.S. I rapporti con il Direttore sono gradualmente diventati buoni e improntati sulla collaborazione reciproca tesa a comprendere le esigenze delle operaie per poterle poi soddisfare.
L’attività che ora si svolge consiste nel seguire casi individuali e pratiche del Patronato; sono in programma iniziative di gruppo attraverso gite e cineforum. Esistono poi: una industria meccanica, che contava un anno fa 300 operai, al tempo che sono entrata in servizio 70, ora è rimasta con 15 operai perchè completamente fallita.
Nell’attesa che venga rimessa in funzione seguo i pochi operai rimasti e tutti gli altri licenziati, che abbiano o no trovata nuova occupazione; la S. R. E. che conta 110 dipendenti sparsi nei vari Comuni della Provincia. àˆ molto difficile poter avere dei rapporti con gli operai perchè sono sempre occupati nei vari impianti, lontani dal Centro. Seguo qualche caso individuale, collaboro con la Direzione a promuovere attività ricreative: in occasione della celebrazione del precetto Pasquale, con la presenza anche del Cappelano della S..R. e., si è fatta una gita, a cui hanno partecipato tutti i dipendenti con le proprie famiglie. È stato infine proposto il S.S. ad una azienda di generi alimentari; conta circa 250 operai di cui circa 120 sono fissi, gli altri 130 sono stagionali e lavorano in prevalenza durante la raccolta dei carciofi. Si attende il consenso che sarà per la metà di settembre. Ogni Fabbrica pur avendo dei problemi comuni con le altre, ha dei particolari aspetti e costituisce un particolare ambiente tecnico psichico e sociale.
Il programma di lavoro è stato e sarà diverso per ogni fabbrica, ma in generale si può dire che si deve insistere ancora su:
1) sensibilizzazione dei dirigenti circa le difficoltà degli operai e i loro problemi familiari.
2) chiarificazione nei confronti dei dirigenti e anche degli operai circa l’attività specifica e i compiti dell’A.S., attraverso i colloqui individuali e i fatti concreti.
3) collaborazione con la Commissione Interna se non altro per venire a conoscenza dei problemi della complessa vita aziendale.
4) promozione di corsi d’istruzione popolare e di aggiornamento tecnico.5) collaborazione per la istituzione di mense aziendali.
6) intensificazione dei rapporti con le famiglie degli operai.
Di tutte le difficoltà di cui finora ho parlato le più spiacevoli sono la diffidenza e lo scetticismo degli operai che risalgono secondo me, non soltanto a cause generali, ma anche a talune deficienze professionali: reali o semplicemente sospettate, che si potrebbero denominare:
1) assistenza discontinua;
2) assistenza iniziata servendosi di pretesti.
Per assistenza discontinua intendo il fatto che il S.S. venga interrotto per un tempo notevolmente lungo,, e anche il fatto che si sostituisca a ad un’altra o troppo spesso o senza ave di realizzare un trapasso di funzioni e dettagliato; è deleterio per l’efficacia del nostro servizio cambiare l’A.S. di una fabbrica così spesso.
Un operaio, quando ha presentato i suoi problemi le sue preoccupazioni le sue difficoltà, i cuoi tetti individuali e familiari, ad una persona nella quale ha fiducia difficilmente poi farà altrettanto con la à« nuova arrivata ».
E cosi quando mi sono presentata presso queste aziende ho trovato gli operai indifferenti e con poca fiducia verso l’A.S. Certamente non si può pretendere che una A.S. rimanga perpetuamente al medesimo posto, occorre però:
1) che si eviti il più possibile di sospendere il S. S. in una fabbrica.
2) che quando tale sospensione sia inevitabile per lo meno si abbia la cura di portare a conclusione tutte le pratiche in corso, di restituire i documenti in possesso, di spiegare con obbiettività i motivi del provvedimento.
3) in caso di sostituzione, la nuova A.S. venga particolareggiatamente informata dall’A.S. precedente su ogni dettaglio, circa gli operai e le famiglie di essi.
4) e che la sostituzione non avvenga se prima la nuova A.S. non abbia lavorato per un certo periodo, di 15 o 20 giorni, accanto all’Assistente precedente, accompagnandola in ogni momento della sua attività. Infine c’è l’altra deficienza professionale che ho chiamata assistenza che si serve di pretesti, con la quale intendo quell’insieme di attività assistenziali che viene eseguito in quanto costituisca occasione o pretesto per una propaganda idee, per una suggestione di qualsiasi genere Per lo più politica o religiosa. Questa intenzione sottintesa può essere anche essere la più retta delle intenzioni ma dobbiamo capire che essa non sfugge alla intuizione pronta e sospettosa degli operai, i quali sogliono vederla anche quando non c’è: e determina in loro uno sfato di diffidenza perchè si ritengono posti davanti ad una trappola. Mi sembra che per eliminare o diminuire questo inconveniente dobbiamo anzi tutto dimostrare di essere ideologicamente quello che siamo senza reticenza e mezzi termini, cristiani che francamente si professano tali e cercano di comportarsi come tali.
Così facendo nessuno, neanche il più malevolo dei nostri assistiti ci potrà incolpare di intenzioni propagandistiche sottintese o recondite.
Ma non basta: occorre infatti che anche interiormente la nostra intenzione sia quella di fare, nell’ambito della nostra attività professionale, l’A.S. e non la propagandista. Qui tuttavia sopravviene una grave difficoltà: può un cristiano battezzato e cresimato, dimenticarsi in un qualunque momento della sua vita di essere un soldato di Gesù Cristo? Il problema è grave e si estende credo a qualunque professione e non credo si possa risolvere con quattro parole.
Mi sembra però che ima via di conciliazione tra l’autonomia professionale e la sudditanza militante del cristiano possa essere questa; una attività professionale, e in particolare in una professione come la nostra, è o almeno può diventare facilmente un atto di carità. Questo atto di carità sarà tanto più perfetto quanto più sarà completo lo sforzo per un esatto adempimento dei doveri professionali. Ora, l’assistenza di pretesto si opporrebbe a tale adempimento, perchè creerebbe gravi opposizioni da parte degli operai. Perciò una assistenza non di pretesti è più professionale e perciò più confacente alla carità.
E infine siccome la carità è l’arma prima ed essenziale del cristiano militante, mi sembra si possa concludere che precisamente un attività assistenziale non pretestuosa sia quella più idonea ad aprire il cuore degli assistiti verso la Fede in cui abbiamo creduto.
Esperienza di servizio sociale in una grande impresa milanese, 11-12, 1960, pp. 34-36.
di Rina Menghini
Il Servizio Sociale alla N.N. è stato introdotto da parecchi anni; sempre che per Servizio Sociale si intenda ancora attività assistenziale svolta in campo burocratico a amministrativo per lo svolgimento di pratiche previdenziali, mutualistiche, ecc.
Alla mia designazione, che risale a circa un anno fa, la situazione si presentava immutata, n processo di inserimento che segue normalmente a quello di introduzione, per svariate ragioni, era rimasto bloccato al punto di partenza. Quindi il mio primo obiettivo fu dì individuare quali erano le cause che limitavano il Servizio Sociale ad una area circoscritta e marginale rispetto all’impresa. Dallo studio dell’ambiente psico-sociale della N.N. sono balzate evidenti tali cause:
1) Errata interpretazione della funzione e del ruolo dell’Assistenza Sociale nell’impresa.
2) Assenza di rapporti personali fra quadri dirigenti e dipendenti, « vizio » che è alla base dell’organizzazione aziendale moderna ma che presenta un carattere di maggiore radicalità in un complesso della mole della N.N. L’esigenza di un vero Servizio Sociale non può essere sentita se tali rapporti non sussistono, venendo a mancare un effettivo interesse per il fattore umano nell’impresa. Individuate le cause era quindi opportuno fissare come primo traguardo da raggiungere una maggiore « sensibilità » dei quadri dirigenti ai postulati del Servizio Sociale ed una chiarificazione sul ruolo e la funzione dell’Assistente Sociale nell’impresa. Nei miei numerosi e periodici colloqui con i vari Dirigenti e capi-uffici mi sono sforzata di presentare il Servizio Sociale, nei termini più chiari e convincenti possibili, non come il sostitutivo di altre attività ma come l’elemento catalizzatore atto a stimolare l’attenzione dei bisogni del dipendente, considerato come entità umana, prima ancora che come entità produttiva. Ogni Assistente Sociale sa quanto questo processo di sensibilizzazione sia laborioso e difficile ma anche come sia l’indispensabile presupposto per una chiara ed esatta impostazione di un Servizio Sociale nell’impresa. L’esperienza di molti anni di lavoro mi ha convinta che uno dei più rilevanti ostacoli da rimuovere al fine di un maggior riconoscimento del nostro Servizio Sociale è quello di creare un à« linguaggio comune à» che favorisca la comprensione dei principi e delle tecniche del Servizio Sociale da parte dei responsabili degli Enti che si servono di Assistenti Sociali per la realizzazione dei fini per i quali essi stessi esistono. È stato spesse volte notato che per una diffusa « forma mentis » il Servizio Sociale viene ancora identificato con l’aiuto di chi dà, senza chiedere l’attiva collaborazione dell’individuo. Questo è vero soprattutto per il Servizio Sociale nelle imprese dove nella migliore delle ipotesi l’assistenza viene amministrata partendo da concetti puramente paternalistici; e cioè si opera e si lavora per i dipendenti e non con i dipendenti. Parlare di sviluppo della personalità, dì impresa come sistema sociale, di democrazia industriale ha ancora un suono retorico ed utopistico abituato a concepire tutto, o quasi, in chiave di cifre e dividendi. Da qui la necessità di una chiarificazione teorica che prelude ad una altrettanto chiara impostazione pratica. Altrimenti il Servizio Sociale si ridurrebbe ad à« uno dei fanti mezzi con i quali, accettando lo à« status à» della struttura industriale come un punto Trino si cerca dì adattare il lavoratore a queste struttura insistendo a voler mutare solo il modo del lavoro lasciando pressocchè intatto quello padronale à». Questi in sintesi i temi dei miei colloqui con i vari dirigenti, i quali, ad onor del vero pur riconoscendo le difficoltà obiettive che si frappongono alla realizzazione, in concreto, di tali principi, hanno apprezzato ed appoggiato il mio sforzo per l’impostazione di un Servizio Sociale che non tradisca tali fondamentali principi. Solo dopo questo primo lavoro di chiarificazione ho creduto opportuno presentare un piano di lavoro illustrante le principali forme applicative del Servizio Sociale nelle imprese, così come risultano efficacemente attuate in aziende da tempo sensibilizzate ai problemi umani che la organizzazione industriale ha posto in essere.
Ho formulato tale piano di lavoro tenendo conto della realtà aziendale in cui opero, dando quindi prevalenza a quelle particolari attività che più ho ritenuto idonee a soddisfare le reali necessità e gli effettivi interessi dei dipendenti. Una delle carenze maggiormente sentite è quella della difficoltà di comunicazione fra Direzione e personale, personale e Direzione. La scala gerarchica della N.N. è complessa e multiforme; il dipendente difficilmente riesce ad individuare a quale degli innumerevoli uffici preposti alla direzione del personale certe sue istanze o lagnanze vadano indirizzate.
Nelle mie ore di ricevimento numerosi sono i colloqui aventi per tema questo argomento. Da qui l’impegno assunto, in accordo con i vari dirigenti, di facilitare quella che, in termini tecnici, viene definita « informazione bilaterale ». Promuovere e facilitare la comunicazione sociale dell’azienda è quindi uno dei compiti che svolgo con maggior impegno, anche se per ora in forma occasionale più che sistematica. Uno dei problemi fondamentali di ogni azienda e in particolare della N.N. è quello di creare armonia fra struttura tecnica e struttura umana; la mancanza di questa armonia provoca squilibri e disadattamenti pregiudizievoli per la vita e lo sviluppo dell’azienda stessa. Il compito di individuare, studiare e risolvere i frequenti conflitti emozionali che portano a svariate forme di disadattamento è stato riconosciuto e appoggiato dalla Direzione. Vari sono stati i casi segnalatimi e positivi i miei interventi per modificare determinate situazioni ambientali e psicologiche che erano all’origine di tali disadattamenti. Nel campo infortunistico sono stata interpellata per vari casi, diversi dei quali presentavano carattere di recidività. Solo ad un attento ed accurato studio del soggetto poteva risultare, come nel fenomeno infortunistico le cause e gli effetti siano reciproci ed interdipendenti. Le mie relazioni sono state lette con interesse proprio per il fatto che l’angolo visuale, dal quale veniva osservato il problema e l’individuo che lo viveva, risultava sensibilmente diverso da quello abitualmente tenuto in sede amministrativa. Oltre i casi segnalatimi dalla Direzione ho considerato ì casi che mi vengono proposti dai singoli dipendenti ottenendo dalla Direzione la autorizzazione a rivolgermi ai Dirigenti dei vari livelli per la soluzione dì casi che comportano l’utilizzazione delle risorse interne dell’Azienda come sussidi speciali, alloggi sociali, ecc. Questii primi passi verso la realizzazione dì un Servizio Sociale inteso non tanto come complesso di determinate attività, quanto come spìrito informatore di tutte quelle attività aziendali che mirano a trasformare la collettività dì lavoro in una comunità aziendale vera e propria.
Relazione dì un periodo di lavoro presso una Fabbrica cittadina a…..:
L’attività di questo periodo si è indirizzata, in modo particolare, a tutta la comunità aziendale. Attraverso l’osservazione diretta e colloqui con vari operai e impiegati, ho potuto rendermi conto meglio delle cause per le quali si era venuta creando, nella fabbrica, una situazione di scontento e di apatia, situazione che si manifestava attraverso il comportamento dei singoli: atteggiamenti e atti aggressivi nei confronti della comunità aziendale e dell’ambiente, ostentazione di indifferenza, manifestazione di sfiducia reciproca fra il gruppo degli operai, basso rendimento nel lavoro.
Ho avuto buone ragioni per credere che una cosa molto importante di questa situazione fosse costituita da uno stato di insicurezza degli operai.
Infatti:
a) la fabbrica è guidata da un capo officina che fa le veci del datore di lavoro, occupato da molti altri impegni; il capo officina, per varie ragioni, è stato spesso cambiato;
b) altre all’assistente sociale, che è presente in fabbrica da appena dieci mesi, all’interno della azienda non esiste nessun gruppo costituito, utile a vedere i rapporti tra datore di lavoro e operai.
Pertanto, in primo luogo, la assenza quasi completa del padrone della fabbrica procurava uno stato di incertezza negli operai, i quali, pur conservando, nei confronti dei datori di lavoro in genere, un atteggiamento diffidente e anche ostile, hanno bisogno di trattare con lui direttamente, per conoscere il suo pensiero, avere un indirizzo, ma sopratutto, direi hanno bisogno della sua presenza, di un suo incoraggiamento, specialmente se hanno fondate ragioni, come in questo caso, per avere riposto stima e fiducia proprio nella persona del datore di lavoro.
In secondo luogo, l’assenza di un gruppo istituito, formato dai dipendenti della fabbrica faceva sì che venisse a mancare il portavoce autorizzato a collegare direttamente gli operai col padrone. L’assistente sociale stessa si trovava tutta isolata, in quanto, volendo comunicare col capo degli operai e collaborare per risolvere problemi inerenti la fabbrica, non si vedeva certo facilitata il compito. Dopo avere quindi studiato, per diverso tempo la situazione, ne ho parlato col datore di lavoro e con gli operai, in diverse riprese.
Al datore di lavoro ho mostrato quelle che a mio parere, sono le necessità degli operai necessità che ho qui sopra esposto e che si rivelano causa della generale situazione di scontento e di scarso rendimento.
Agli operai ho cercato di chiarire i motivi del loro stato di indifferenza e sfiducia nei riguardi del loro gruppo, motivi che trovano la ragione di essere in un bisogno di appoggio che non vedevano soddisfatto. Ho mostrato, al contrario, di avere molta fiducia nei loro riguardi. Ho poi portato agli operai il pensiero del datore di lavoro, il quale si rende conto della necessità di seguire più da vicino personalmente la fabbrica e mostra piacere che gli operai formino la Commissione interna, sia perchè essi avrebbero la possibilità di esporre le loro necessità, sia perchè egli stesso avrebbe il modo di trattare con una rappresentanza della fabbrica.
La risposta degli operai a questo mio lavoro si mostra, almeno per il momento, positiva. Essi appaiono anche pi distesi e fiduciosi, manifestano il desiderio e la buona volontà di trovare un punto d’incontro col datore di lavoro. Oltre a ciò, atteggiamento molto importante che rivela le risorse positive del gruppo, mostrano di voler operare non una scelta basata esclusivamente su interessi.